Tradurre è come rivestire un tetto di tegole
di Gabriella Bosco
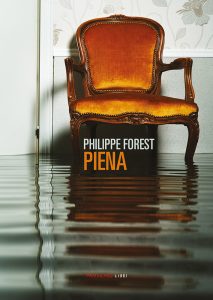 Da una quindicina d’anni ormai, traduco i libri di Philippe Forest. Oggi è un autore molto conosciuto, decisamente “celebre per la sua notorietà”. L’espressione è di Alain Robbe-Grillet che la usava riferita a se stesso e agli altri nouveaux romanciers, di cui negli anni cinquanta e sessanta tutti parlavano ma che in pochi leggevano. Quando vado in giro a presentare un nuovo romanzo di Forest che esce in Italia, come mi accade in questi giorni per Piena (pp. 252, € 18,50, Fandango, Roma 2018), ricevo sempre lo stesso attonito quesito: “Ma come fai a tradurlo?” Quesito al quale, prima ancora che io abbia tempo di imbastire una risposta, fa seguito l’inevitabile seconda parte di pensiero del domandante: “Tutti i bambini tranne uno è un libro bellissimo. L’ho comprato. Però non posso leggerlo. Troppo dolore”. La maggior parte delle recensioni, degli articoli che vengono scritti in merito ai libri di Forest, insistono in effetti su quello. Il romanziere che ha saputo descrivere la morte. L’autore della sofferenza. Lo scrittore che non ha arretrato di fronte alla malattia di sua figlia. Né si può dire che sia falso. Tutti i bambini tranne uno è il libro lancinante e necessario in cui Philippe Forest ha raccontato sotto forma di romanzo quando e come la piccola Pauline si è ammalata di osteosarcoma, e il lungo intenso anno che mamma e papà, con lei, hanno vissuto ancora insieme prima che il male se la portasse via. Un libro che Forest ha scritto incalzato dal bisogno di testimoniare, e per impedire che quell’esperienza cadesse nell’oblio. Tradurlo è stato molto faticoso, non posso negarlo. E però al tempo stesso è stata una delle esperienze più significative che io ricordi. Il romanzo parla di malattia e di morte, e anche, molto, di dolore. Ma è insieme un romanzo d’amore, di amore grandissimo, scritto in nome di quell’amore, e per preservarlo. Per dire “no” allo scandalo della morte, non certo per celebrarla o magari, come capita di sentire, per prendere parte a una sorta di movimento estetizzante e morboso che si stringe intorno alla sofferenza. Vorrei lo si sapesse, lo si sapesse di più e meglio. Sono convinta che sull’opera di Forest gravi un equivoco, assecondato anche da coloro che – critici, studiosi, esegeti – sinceramente lo apprezzano, arrivando a volte a definirlo “il più grande scrittore vivente”.
Da una quindicina d’anni ormai, traduco i libri di Philippe Forest. Oggi è un autore molto conosciuto, decisamente “celebre per la sua notorietà”. L’espressione è di Alain Robbe-Grillet che la usava riferita a se stesso e agli altri nouveaux romanciers, di cui negli anni cinquanta e sessanta tutti parlavano ma che in pochi leggevano. Quando vado in giro a presentare un nuovo romanzo di Forest che esce in Italia, come mi accade in questi giorni per Piena (pp. 252, € 18,50, Fandango, Roma 2018), ricevo sempre lo stesso attonito quesito: “Ma come fai a tradurlo?” Quesito al quale, prima ancora che io abbia tempo di imbastire una risposta, fa seguito l’inevitabile seconda parte di pensiero del domandante: “Tutti i bambini tranne uno è un libro bellissimo. L’ho comprato. Però non posso leggerlo. Troppo dolore”. La maggior parte delle recensioni, degli articoli che vengono scritti in merito ai libri di Forest, insistono in effetti su quello. Il romanziere che ha saputo descrivere la morte. L’autore della sofferenza. Lo scrittore che non ha arretrato di fronte alla malattia di sua figlia. Né si può dire che sia falso. Tutti i bambini tranne uno è il libro lancinante e necessario in cui Philippe Forest ha raccontato sotto forma di romanzo quando e come la piccola Pauline si è ammalata di osteosarcoma, e il lungo intenso anno che mamma e papà, con lei, hanno vissuto ancora insieme prima che il male se la portasse via. Un libro che Forest ha scritto incalzato dal bisogno di testimoniare, e per impedire che quell’esperienza cadesse nell’oblio. Tradurlo è stato molto faticoso, non posso negarlo. E però al tempo stesso è stata una delle esperienze più significative che io ricordi. Il romanzo parla di malattia e di morte, e anche, molto, di dolore. Ma è insieme un romanzo d’amore, di amore grandissimo, scritto in nome di quell’amore, e per preservarlo. Per dire “no” allo scandalo della morte, non certo per celebrarla o magari, come capita di sentire, per prendere parte a una sorta di movimento estetizzante e morboso che si stringe intorno alla sofferenza. Vorrei lo si sapesse, lo si sapesse di più e meglio. Sono convinta che sull’opera di Forest gravi un equivoco, assecondato anche da coloro che – critici, studiosi, esegeti – sinceramente lo apprezzano, arrivando a volte a definirlo “il più grande scrittore vivente”.
Prima di tradurre Forest io avevo alle spalle tre esperienze per me importanti. La traduzione del Solitario di Ionesco, unico romanzo scritto dal grande drammaturgo, che lui stesso, per tramite della figlia Marie-France di cui ero stata allieva negli anni del liceo e di cui sono rimasta amica, giunto alla fine della sua vita, mi aveva attribuito. Facendomi lavorare al suo tavolo, preda di una sorta di terror panico continuo e della più grande esaltazione traduttiva che si possa immaginare. È stato Ionesco a insegnarmi a considerare il testo come un tessuto, e a sentirne “la mano” proprio come faceva mia madre che era maestra elementare ma anche sarta e quando ero piccola mi portava con sé a comprare le stoffe, e le sceglieva in base a quello che sentiva passandole tra le dita. Poi, seconda esperienza, la traduzione della Donna dal collare di velluto di Alexandre Dumas grazie a cui ho scoperto le gioie del lavoro sul pastiche. In quel romanzo infatti Dumas, prendendo come personaggio Charles Nodier, ne utilizza e riscrive ampie parti di testo. Straordinaria avventura insomma: tradurre un autore per interposta persona. Terza esperienza, la revisione di Il silenzio del mare di Vercors, ovvero della traduzione che ne aveva fatto quarant’anni prima, nel 1953, Natalia Ginzburg. Revisione necessaria essenzialmente per via di certe parti da ripristinare, parti che nella sua traduzione Ginzburg, prima di tutto scrittrice anche durante l’atto traduttivo, aveva in qualche modo adattato a sé. Altro esercizio formativo se mai ce ne sono stati, per via del compito di restituzione che mi veniva chiesto, del testo alla sua tessitura originaria.
 Mi sono presentata così al primo appuntamento con Forest, con i due primi suoi libri che ho avuto occasione di tradurre. Non Tutti i bambini tranne uno, non ancora il primo romanzo, bensì due piccoli saggi oggi introvabili (ma che presto verranno riproposti dai benemeriti di Nonostante edizioni, nell’ambito di un grosso volume di saggi forestiani che comprende oltre a quei primi due gran parte di quelli scritti in seguito): Il romanzo, il reale e Il romanzo, l’io. Due piccoli saggi che avevo snidato alla Bibliothèque Nationale de France preparando un corso universitario sulle scritture in prima persona e che, appena letti, mi erano sembrati imprescindibili. E per i quali ho trovato accoglienza immediata nella collana Holden Maps edita dalla Bur, diretta all’epoca da Dario Voltolini (rispettivamente 2003 e 2004). Nel primo di quei due piccoli ma densissimi saggi, Forest si chiedeva se oggi, nell’era del dopo-storia, quella che fa seguito alla Shoah e all’esplosione della bomba atomica, ha ancora senso scrivere un romanzo. Domanda per replicare alla quale Forest impiega tutte le pagine del testo, dicendo: un romanzo oggi ha senso se prova a rispondere all’appello impossibile che il reale gli rivolge. Una formula apparentemente criptica, ma molto esplicita una volta lette le argomentazioni dell’autore. Il romanzo che ha ancora senso oggi, come Se questo è un uomo di Primo Levi, è per lui quello che non arretra di fronte alla testimonianza dell’impossibile, quello che prova a cercare un linguaggio – che ricorra tanto al senso filosofico quanto al non senso poetico – al fine di dire ciò per cui le parole normalmente mancano. Mentre nel secondo di quei saggi, Il romanzo, l’io, Forest spiegava che a suo modo di vedere questa risposta il romanziere può provare a darla solo se passa per il prisma del je, della scrittura personale. Introdotto dal suo pensiero teorico, Forest è così arrivato in Italia con il primo romanzo, il sempre ricordato Tutti i bambini tranne uno (edito originariamente da Alet, 2005 e riproposto nel 2018 da Fandango), romanzo che in Francia, con il titolo L’enfant éternel, era invece uscito prima dei due saggi, di cui essi erano stati come l’illustrazione a posteriori. In certi particolari sovvertimenti dell’ordine della frase, in numerosi aggettivi illogicamente sostantivati, in participi passati insistentemente posposti, sta tutta la forza di questo romanzo involontario, che si è fatto da sé contro il suo autore, che si è imposto e ha trovato il suo spazio a spinte e strattoni.
Mi sono presentata così al primo appuntamento con Forest, con i due primi suoi libri che ho avuto occasione di tradurre. Non Tutti i bambini tranne uno, non ancora il primo romanzo, bensì due piccoli saggi oggi introvabili (ma che presto verranno riproposti dai benemeriti di Nonostante edizioni, nell’ambito di un grosso volume di saggi forestiani che comprende oltre a quei primi due gran parte di quelli scritti in seguito): Il romanzo, il reale e Il romanzo, l’io. Due piccoli saggi che avevo snidato alla Bibliothèque Nationale de France preparando un corso universitario sulle scritture in prima persona e che, appena letti, mi erano sembrati imprescindibili. E per i quali ho trovato accoglienza immediata nella collana Holden Maps edita dalla Bur, diretta all’epoca da Dario Voltolini (rispettivamente 2003 e 2004). Nel primo di quei due piccoli ma densissimi saggi, Forest si chiedeva se oggi, nell’era del dopo-storia, quella che fa seguito alla Shoah e all’esplosione della bomba atomica, ha ancora senso scrivere un romanzo. Domanda per replicare alla quale Forest impiega tutte le pagine del testo, dicendo: un romanzo oggi ha senso se prova a rispondere all’appello impossibile che il reale gli rivolge. Una formula apparentemente criptica, ma molto esplicita una volta lette le argomentazioni dell’autore. Il romanzo che ha ancora senso oggi, come Se questo è un uomo di Primo Levi, è per lui quello che non arretra di fronte alla testimonianza dell’impossibile, quello che prova a cercare un linguaggio – che ricorra tanto al senso filosofico quanto al non senso poetico – al fine di dire ciò per cui le parole normalmente mancano. Mentre nel secondo di quei saggi, Il romanzo, l’io, Forest spiegava che a suo modo di vedere questa risposta il romanziere può provare a darla solo se passa per il prisma del je, della scrittura personale. Introdotto dal suo pensiero teorico, Forest è così arrivato in Italia con il primo romanzo, il sempre ricordato Tutti i bambini tranne uno (edito originariamente da Alet, 2005 e riproposto nel 2018 da Fandango), romanzo che in Francia, con il titolo L’enfant éternel, era invece uscito prima dei due saggi, di cui essi erano stati come l’illustrazione a posteriori. In certi particolari sovvertimenti dell’ordine della frase, in numerosi aggettivi illogicamente sostantivati, in participi passati insistentemente posposti, sta tutta la forza di questo romanzo involontario, che si è fatto da sé contro il suo autore, che si è imposto e ha trovato il suo spazio a spinte e strattoni.
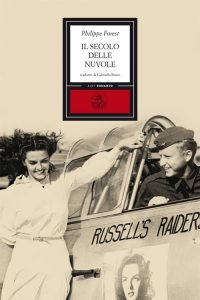 Sono poi venuti, uno dopo l’altro, i libri successivi di Forest, che disegnano un percorso dell’autore, una sua costante ripresa dell’esperienza da cui tutto ha avuto inizio nel tentativo di dirla in modo diverso, di portare più avanti la scrittura in direzione di un luogo a lui stesso sconosciuto verso il quale tuttavia tende. Mi è impossibile ripercorrere qui tutte le tappe, ma voglio ricordare quello che è stato un ulteriore apprendimento di grande utilità per il mio stare sulle tracce dell’autore. Mi riferisco alla traduzione dei Testi per nulla e di alcune altre prose brevi di Beckett (Einaudi, 2010), pagine mute in certe parti sino all’inverosimile, per venire a capo delle quali ho effettuato un lavoro di natura genetica, risalendo a tutti gli stadi antecedenti per i quali l’autore era passato, brouillons fortunatamente conservati e consultabili. Attraverso lo studio di questo andamento progressivamente prosciugatorio delle frasi, mi è stato meno difficile riprodurne in italiano gli esiti. Viaggio dentro alla penna di Beckett che non dimenticherò e che si è rivelato molto funzionale allo scopo di affrontare uno scoglio impervio, quando mi sono trovata a tradurre, di Forest, Il secolo delle nuvole (Alet, 2012). Un romanzo di seicento pagine nel quale è raccontata la storia del Novecento attraverso quella dell’aviazione, a sua volta raccontata attraverso la storia del padre dell’autore, che era stato pilota, prima di guerra, poi civile. “Far stare nel romanzo tutto lo spessore del passato, intrecciando la storia di tutti con la mia, con il filo conduttore del destino di un uomo (mio padre) lui stesso legato a una delle principali utopie dell’era moderna (l’aeronautica)”, scriveva Forest nel progettare il romanzo. Si era affezionato al participe présent come resa francese della forma in -ing di Faulkner che pensava di ricalcare, l’andamento strofico della sua pagina, scandito da una sorta di rima lancinante, “forme verbali necessarie – scriveva – perché il testo riesca a scivolare senza sosta dal passato al presente e dal presente al passato”. Una volta finito il libro, Forest si era poi reso conto che a guidare la forma (la sua ricerca, il suo ritrovamento) era stato invece Claude Simon. L’idea secondo cui raccontare “è un po’ come mettersi a cercar d’incollare i frammenti sparsi, incompleti di uno specchio, sforzandosi maldestramente di farli combaciare e non ottenendo che un risultato incoerente, irrisorio, idiota. Ma con la testardaggine, nonostante tutto, di progredire dentro a quel caos in modo da darne una rappresentazione impossibile attraverso la quale – come si legge nella Strada delle Fiandre – si giunge a una realtà forse più reale del reale”. Quel participe présent che a tale scopo scandiva tutto il romanzo: come preservarlo in traduzione, mantenendo la fluidità della lingua forestiana senza tradirne la forma? La soluzione l’ho scovata nel procedimento beckettiano del tuilage, della scrittura realizzata per ripetizioni e successive piccole varianti come si trattasse della copertura di un tetto, laddove le tegole, tuiles, si sovrappongono quasi completamente ma non del tutto ed è la parte non sovrapposta, ovvero la piccola variante, a far avanzare il tetto, e fuor di metafora il testo. Le voci verbali in -ndo hanno così poco alla volta cessato di farmi inciampare per diventare al contrario gli appigli, punti numerati sulla carta da unire con la matita per far apparire il disegno.
Sono poi venuti, uno dopo l’altro, i libri successivi di Forest, che disegnano un percorso dell’autore, una sua costante ripresa dell’esperienza da cui tutto ha avuto inizio nel tentativo di dirla in modo diverso, di portare più avanti la scrittura in direzione di un luogo a lui stesso sconosciuto verso il quale tuttavia tende. Mi è impossibile ripercorrere qui tutte le tappe, ma voglio ricordare quello che è stato un ulteriore apprendimento di grande utilità per il mio stare sulle tracce dell’autore. Mi riferisco alla traduzione dei Testi per nulla e di alcune altre prose brevi di Beckett (Einaudi, 2010), pagine mute in certe parti sino all’inverosimile, per venire a capo delle quali ho effettuato un lavoro di natura genetica, risalendo a tutti gli stadi antecedenti per i quali l’autore era passato, brouillons fortunatamente conservati e consultabili. Attraverso lo studio di questo andamento progressivamente prosciugatorio delle frasi, mi è stato meno difficile riprodurne in italiano gli esiti. Viaggio dentro alla penna di Beckett che non dimenticherò e che si è rivelato molto funzionale allo scopo di affrontare uno scoglio impervio, quando mi sono trovata a tradurre, di Forest, Il secolo delle nuvole (Alet, 2012). Un romanzo di seicento pagine nel quale è raccontata la storia del Novecento attraverso quella dell’aviazione, a sua volta raccontata attraverso la storia del padre dell’autore, che era stato pilota, prima di guerra, poi civile. “Far stare nel romanzo tutto lo spessore del passato, intrecciando la storia di tutti con la mia, con il filo conduttore del destino di un uomo (mio padre) lui stesso legato a una delle principali utopie dell’era moderna (l’aeronautica)”, scriveva Forest nel progettare il romanzo. Si era affezionato al participe présent come resa francese della forma in -ing di Faulkner che pensava di ricalcare, l’andamento strofico della sua pagina, scandito da una sorta di rima lancinante, “forme verbali necessarie – scriveva – perché il testo riesca a scivolare senza sosta dal passato al presente e dal presente al passato”. Una volta finito il libro, Forest si era poi reso conto che a guidare la forma (la sua ricerca, il suo ritrovamento) era stato invece Claude Simon. L’idea secondo cui raccontare “è un po’ come mettersi a cercar d’incollare i frammenti sparsi, incompleti di uno specchio, sforzandosi maldestramente di farli combaciare e non ottenendo che un risultato incoerente, irrisorio, idiota. Ma con la testardaggine, nonostante tutto, di progredire dentro a quel caos in modo da darne una rappresentazione impossibile attraverso la quale – come si legge nella Strada delle Fiandre – si giunge a una realtà forse più reale del reale”. Quel participe présent che a tale scopo scandiva tutto il romanzo: come preservarlo in traduzione, mantenendo la fluidità della lingua forestiana senza tradirne la forma? La soluzione l’ho scovata nel procedimento beckettiano del tuilage, della scrittura realizzata per ripetizioni e successive piccole varianti come si trattasse della copertura di un tetto, laddove le tegole, tuiles, si sovrappongono quasi completamente ma non del tutto ed è la parte non sovrapposta, ovvero la piccola variante, a far avanzare il tetto, e fuor di metafora il testo. Le voci verbali in -ndo hanno così poco alla volta cessato di farmi inciampare per diventare al contrario gli appigli, punti numerati sulla carta da unire con la matita per far apparire il disegno.
Ho finito lo spazio a disposizione e rimaneva da dire almeno dell’ultimo romanzo tradotto, Piena, storia allucinata e sensuale della straordinaria esondazione di un fiume mentre due persone si amano prese in mezzo a un’epidemia di misteriose scomparse. Aggiungo allora solo questo: è un Forest nuovo, che già con Il gatto di Schrödinger ha imboccato un sentiero diverso, ma sempre allo scopo di trovare quel luogo, “tradurre la precipitazione della vita verso il vuoto che la chiama tracciando tuttavia al suo interno l’irrisoria e splendida scia della sua testimonianza”.
Mostrare che ciò che è non si situa in nessun posto se non nel racconto che qualcuno ne fa.
gabriella.bosco@unito.it
G. Bosco insegna letteratura francese all’Università di Torino


