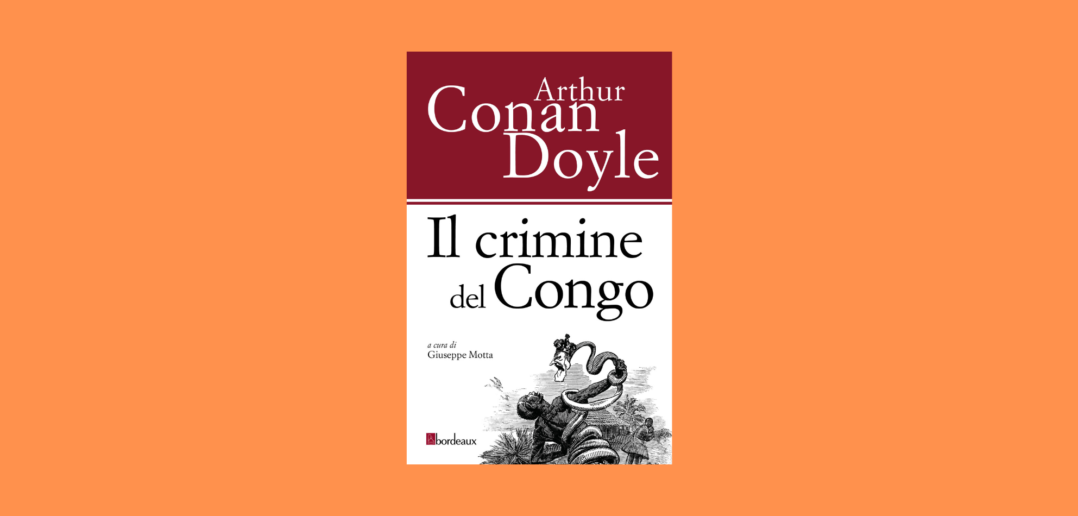Sotto il segno della chicotte
di Mario Marchetti
Arthur Conan Doyle
Il crimine del Congo
a cura di Giuseppe Motta,
pp. 165, € 14,
Bordeaux, Roma 2020
L’immagine di Arthur Conan Doyle si è cristallizzata sul suo immortale Sherlock Holmes. D’altronde il suo stesso aspetto si prestava a simile identificazione: eleganza sportiva, baffi a manubrio senza eccessi, pantaloni alla zuava, coppola tartan… Come si sa, Doyle cercò di liberarsi del suo odiosamato doppio facendolo precipitare in un burrone, ma il pubblico non glielo permise: era schiavo del personaggio. Doyle avrebbe voluto in realtà occuparsi solo di spiritismo, di romanzi storici e reportage giornalistici, come The Great Boer War (1900) per il quale fu insignito del titolo di baronetto. Sherlock Holmes gli andava stretto, e che lo sguardo di Doyle andasse oltre il puro gioco delle deduzione lo si può notare dai quattro romanzi dedicati al celebre detective, infrattivo consumatore di cocaina. In essi, con l’eccezione del goticamente fosforescente Mastino dei Baskerville, le vicende criminose si allargano al mondo per toccare temi all’epoca di grande attualità: dal potente e sinistro stato creato dai mormoni e dalla loro Chiesa dei santi degli ultimi giorni nello Utah in Uno studio in rosso (1887), al Raj, l’impero anglo-indiano, della rivolta dei Sepoys, le truppe bengalesi, nel Segno dei quattro (1890), in cui il futuro baronetto si lascia sfuggire a mezza bocca che gli inglesi andavano in India per arricchirsi, dunque non solo per addossarsi il fardello dell’uomo bianco, per finire nel 1915 con La valle della paura, dove l’omicidio avvenuto in un maniero del Sussex ci rinvia ai centri minerari americani sotto il ferreo controllo della malavita. Conan Doyle si affaccia su questi argomenti scabrosi per poi ritrarsene rendendo omaggio a quella che alla fin fine reputa la superiore civiltà anglo-americana: basti pensare che nella Valle della paura chi fa trionfare la giustizia è un uomo della famigerata agenzia Pinkerton, il cui ruolo poco scrupoloso al servizio dei robber barons è cosa ben nota.
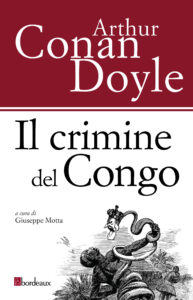 Ma veniamo al Crimine del Congo (1909). Qui è in campo il Conan Doyle giornalista e grande giornalista. La sua requisitoria contro Leopoldo II re dei Belgi che con l’accordo – sarebbe più esatto dire connivenza – delle potenze europee e degli Stati Uniti si era costruito nel Congo uno stato personale di cui era padrone assoluto, dove ogni efferatezza era permessa, é condotta in maniera limpida, pacata e radicale al tempo stesso. Certamente il suo sguardo non è altrettanto acuto quando si tratta delle pratiche coloniali francesi (qui Céline docet nel suo Viaggio al termine della notte del 1932) e tedesche ma, soprattutto, inglesi. E così, alla fine del suo pamphlet, Doyle sembra quasi sbalordito che dopo tante testimonianze inoppugnabili (le ceste di mani mozzate) rese possibili, tra l’altro, dalla miracolosa Kodak (1888, “Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto”), dopo il dettagliato rapporto del console britannico Roger Casement del 1904, dopo le risultanze della stessa commissione di inchiesta che Leopoldo II nel 1906 era stato costretto a istituire su pressione internazionale, non accadesse nulla. Nessuno interviene. Come scrive Doyle “Il risultato finale della commissione, in pratica è stata la punizione dei nativi e non dei loro assassini”. In realtà qualcosa successe, lo Stato libero del Congo nel 1908 passò dalle mani di Leopoldo II al governo belga. E tutto continuò come prima, ma sì, con qualche atrocità in meno. Nessuno aveva interesse ad aprire il vaso di Pandora del Congresso di Berlino (1884-85), a partire dal quale si era scatenata la corsa all’interno del continente nero delle potenze europee. Era stato proprio il Congresso di Berlino a sancire la nascita dello Stato libero del Congo (esteso 80 volte il minuscolo Belgio) affidandolo a Leopoldo II – che, per parte sua, aveva preparato il terreno con la creazione del Comité d’études du Haut-Congo nel 1878 esibendosi in un profluvio di dichiarazioni umanitarie – con la missione di aprire quell’immenso territorio al libero commercio, porre fine al cannibalismo e combattere la tratta degli schiavi in mano agli arabi di Zanzibar. Nell’impresa Leopoldo si avvalse dell’opera dell’eroicizzato avventuriero Henry Morton Stanley, sui cui libri di viaggio e di scoperta, veri instant books, pubblicati immediatamente anche in Italia dai fratelli Treves, ogni ragazzo dell’epoca sognò. E fu così che la popolazione indigena da occasionale preda degli schiavisti arabi diventò sistematica vittima dei civilizzatori europei che imposero un sistema di lavoro coatto senza limiti.
Ma veniamo al Crimine del Congo (1909). Qui è in campo il Conan Doyle giornalista e grande giornalista. La sua requisitoria contro Leopoldo II re dei Belgi che con l’accordo – sarebbe più esatto dire connivenza – delle potenze europee e degli Stati Uniti si era costruito nel Congo uno stato personale di cui era padrone assoluto, dove ogni efferatezza era permessa, é condotta in maniera limpida, pacata e radicale al tempo stesso. Certamente il suo sguardo non è altrettanto acuto quando si tratta delle pratiche coloniali francesi (qui Céline docet nel suo Viaggio al termine della notte del 1932) e tedesche ma, soprattutto, inglesi. E così, alla fine del suo pamphlet, Doyle sembra quasi sbalordito che dopo tante testimonianze inoppugnabili (le ceste di mani mozzate) rese possibili, tra l’altro, dalla miracolosa Kodak (1888, “Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto”), dopo il dettagliato rapporto del console britannico Roger Casement del 1904, dopo le risultanze della stessa commissione di inchiesta che Leopoldo II nel 1906 era stato costretto a istituire su pressione internazionale, non accadesse nulla. Nessuno interviene. Come scrive Doyle “Il risultato finale della commissione, in pratica è stata la punizione dei nativi e non dei loro assassini”. In realtà qualcosa successe, lo Stato libero del Congo nel 1908 passò dalle mani di Leopoldo II al governo belga. E tutto continuò come prima, ma sì, con qualche atrocità in meno. Nessuno aveva interesse ad aprire il vaso di Pandora del Congresso di Berlino (1884-85), a partire dal quale si era scatenata la corsa all’interno del continente nero delle potenze europee. Era stato proprio il Congresso di Berlino a sancire la nascita dello Stato libero del Congo (esteso 80 volte il minuscolo Belgio) affidandolo a Leopoldo II – che, per parte sua, aveva preparato il terreno con la creazione del Comité d’études du Haut-Congo nel 1878 esibendosi in un profluvio di dichiarazioni umanitarie – con la missione di aprire quell’immenso territorio al libero commercio, porre fine al cannibalismo e combattere la tratta degli schiavi in mano agli arabi di Zanzibar. Nell’impresa Leopoldo si avvalse dell’opera dell’eroicizzato avventuriero Henry Morton Stanley, sui cui libri di viaggio e di scoperta, veri instant books, pubblicati immediatamente anche in Italia dai fratelli Treves, ogni ragazzo dell’epoca sognò. E fu così che la popolazione indigena da occasionale preda degli schiavisti arabi diventò sistematica vittima dei civilizzatori europei che imposero un sistema di lavoro coatto senza limiti.
L’amministrazione, interessata alla gomma e all’avorio, stabiliva le quote da ottenere, agli agenti belgi delle stazioni toccava fare rispettare le consegne, ma il lavoro sporco era affidato a una manovalanza indigena con pieni poteri sul corpo della popolazione: la chicotte – una tagliente frusta di pelle di ippopotamo – era lo strumento fondamentale del dominio. E se questa non bastava si ricorreva al taglio delle mani o, senza batter ciglio, all’uccisione degli inadempienti sotto l’occhio vigile degli agenti bianchi. L’obiettivo era raggiungere la quota. La popolazione in vent’anni di simile trattamento si ridusse da circa 20/25 milioni a 15 – era meglio morire, come dissero in molti a Casement –, i villaggi vennero abbandonati nella vana ricerca di un rifugio nella foresta o al di là del grande fiume, ma i profitti raggiunsero il 300 per cento annuo. Un genocidio non teorizzato, ma praticato con indefesso rigore. È Simone Weil ad osservare nel 1940 (La questione coloniale e il destino del popolo francese) che la novità nazista consistette semplicemente nell’applicare i metodi coloniali ai paesi di razza bianca. La bulimia di denaro e l’egolatria del sovrano belga sono splendidamente messe in scena da Mark Twain nel Soliloquio di re Leopoldo (1905), in una contrapposizione un po’ ingenua tra il vecchio sistema monarchico europeo fonte di ogni nequizia e la democrazia americana per definizione innocente (e dire che la guerra filippino-americana che aveva portato al controllo coloniale yankee dell’arcipelago si era appena conclusa nel 1902!). L’interesse per il caso del Congo, al di là dei contingenti interessi di bandiera e anche di appartenenza religiosa (protestanti versus cattolici) rivela qualcosa di più profondo. Gli spiriti più sensibili vi vedevano messa a nudo, senza orpelli, la natura del colonialismo. Dal Congo bisognava volgere lo sguardo, pena la medusizzazione. Si desiderava, per così dire, un colonialismo o un imperialismo dal volto umano, per confermarsi nel ruolo – come occidentali – di portatori di civiltà. Tema sviluppato con scandaglio dostoevskiano da Conrad in Cuore di tenebra (1902): l’orrore (The horror!) di cui sussurra (He cried in a whisper) Kurtz in agonia concerne lui stesso e la civiltà di cui è figlio, e non tanto, o non solo, la wilderness africana, quella wilderness che gli ha permesso di vedere dentro di sé, abbagliandolo e annientandolo al tempo stesso. Certamente Conrad, non senza una certa scettica ironia, prova un penchant per la civiltà nella sua versione inglese. E fu questo tratto presumibilmente a non fargli firmare la petizione a favore di Roger Casement – la cui vita è dispiegata da Vargas Llosa nel Sogno del celta (2010) – condannato a morte per il suo coinvolgimento nella tentata rivolta irlandese del 1916 contro il Regno Unito, in piena guerra mondiale. Quel Casement che aveva tanto coraggiosamente portato alla luce nel suo rapporto la barbarie del colonialismo, e da cui Conrad tanto aveva imparato.
m.ugomarchetti@gmail.com
M. Marchetti è traduttore e presidente del Premio Italo Calvino