La sorella negletta della rivoluzione industriale
recensione di Carlo Fumian
dal numero di aprile 2017
Sven Beckert
L’IMPERO DEL COTONE
Una storia globale
ed. orig. 2014, trad. dall’inglese di Andrea Asioli
pp. XXX – 610, € 34
Einaudi, Torino 2016
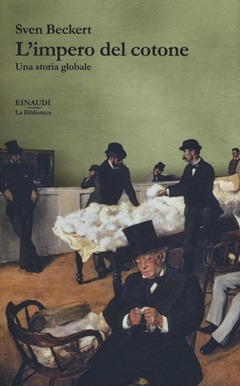 Con fatica, tra numerose resistenze passive e qualche ostilità, lentamente la storia globale comincia a circolare nelle fibre della cultura storica e dell’accademia italiana. Le discipline vivono e prosperano se si formalizzano, si radicano, in una parola si istituzionalizzano: il che significa insegnamenti (desueto: cattedre), riviste, collane editoriali, centri di ricerca, dottorati, e così via. Basta seguire la pista della global history dagli anni sessanta in poi – per intenderci, dalla Chicago di William McNeill (scomparso nel luglio del 2016 a 99 anni) alla California di Kenneth Pomeranz – per poter misurare l’essenzialità del processo di istituzionalizzazione. Non vi è ora nessuna tra le principali università del ranking mondiale che non abbia investito in uno o più centri di ricerca in campo storico, economico, giuridico-politico, incentrato attorno ai global studies. In questo quadro la storia delle commodity – si pensi alle ricerche di Mark Kurlasnky, dedicate a Cod (come recita enfaticamente il sottotitolo, la “biografia del pesce che ha cambiato il mondo”, Penguin, 1997; in Italia Merluzzo, Mondadori, 1999) e a Salt (Penguin, 2002; in Italia Sale, Rizzoli, 2003), o ancora alle peripezie transcontinentali della cocciniglia fascinosamente raccontate da Amy Butler Greenfield in A Perfect Red (HarperCollins, 2005) – rappresentano un accesso privilegiato per la comprensione dei processi di conquista-integrazione (e talvolta disintegrazione) dei mercati globali e l’intricata trasformazione della produzione, dello scambio e del consumo su scala planetaria.
Con fatica, tra numerose resistenze passive e qualche ostilità, lentamente la storia globale comincia a circolare nelle fibre della cultura storica e dell’accademia italiana. Le discipline vivono e prosperano se si formalizzano, si radicano, in una parola si istituzionalizzano: il che significa insegnamenti (desueto: cattedre), riviste, collane editoriali, centri di ricerca, dottorati, e così via. Basta seguire la pista della global history dagli anni sessanta in poi – per intenderci, dalla Chicago di William McNeill (scomparso nel luglio del 2016 a 99 anni) alla California di Kenneth Pomeranz – per poter misurare l’essenzialità del processo di istituzionalizzazione. Non vi è ora nessuna tra le principali università del ranking mondiale che non abbia investito in uno o più centri di ricerca in campo storico, economico, giuridico-politico, incentrato attorno ai global studies. In questo quadro la storia delle commodity – si pensi alle ricerche di Mark Kurlasnky, dedicate a Cod (come recita enfaticamente il sottotitolo, la “biografia del pesce che ha cambiato il mondo”, Penguin, 1997; in Italia Merluzzo, Mondadori, 1999) e a Salt (Penguin, 2002; in Italia Sale, Rizzoli, 2003), o ancora alle peripezie transcontinentali della cocciniglia fascinosamente raccontate da Amy Butler Greenfield in A Perfect Red (HarperCollins, 2005) – rappresentano un accesso privilegiato per la comprensione dei processi di conquista-integrazione (e talvolta disintegrazione) dei mercati globali e l’intricata trasformazione della produzione, dello scambio e del consumo su scala planetaria.
La storia e le persone
L’Italia sconta, in questo processo, un palese ritardo. Senza dubbio perché, oltre a diffonderla, la storia globale bisogna anche “farla”, e farla davvero costa molti soldi, tempo e fatica: visitare numerosi archivi in diversi paesi, conoscere più lingue e controllare bibliografie assai disperse geograficamente e tematicamente. Altrimenti si incorre nel principale peccato di norma rimproverato alla storia globale: dar vita a opere di sintesi basate su fonti secondarie. Belle, intelligenti, ma superficiali (un’accusa spesso rivolta alle pionieristiche opere di McNeill). Un’altra accusa ricorrente è quella di dar vita a lavori consolatori, perché troppo inclini a predicare le magnifiche sorti di un onnicomprensivo sincretismo frutto di interconnessioni, scambi, internazionalizzazioni, salvifiche svolte tecnologiche, in una sorta di nuova, ottimistica febbre sansimoniana (il principale organo di stampa dei fervidi seguaci di Saint-Simon era appunto “Le Globe”). È il caso recente di Il mondo globalizzato, curato da Akira Iriye (Einaudi, 2014), ma certamente non del magnifico e pluripremiato libro di Sven Beckert, professore di storia americana a Harvard e brillante studioso del capitalismo. Per molti versi, diciamolo subito, un testo fondamentale, costruito su una base documentale di amplissimo spettro tematico e geografico. Preceduta di poco dalla pubblicazione dell’ottimo – e forse più rigoroso, come specifica storia del cotone – contributo di Giorgio Riello (Cotton. The Fabric that Made the Modern World, Cambridge University Press, 2013, vincitore nel 2014 del World History Association Bentley Book Prize), la ricerca di Beckert non pare abbia fatto in tempo a nutrirsene, ma è comunque interessante notare come nell’arco di un anno due opere di storia globale di raffinata fattura siano state dedicate alla stessa commodity, ritenuta a ragione una chiave di volta nella costruzione del moderno capitalismo e, per estensione del mondo moderno tout court.
L’indice di L’impero del cotone suona come un bollettino di guerra, allineando temi quali costruzione e redditività del “capitalismo di guerra”; la “cattura” della manodopera e le conquiste territoriali; il sudore e il sangue dello schiavismo e la centralità della guerra civile americana, che “rimbomba in tutto il mondo”; la trasformazione del capitalismo di guerra in capitalismo industriale; le “distruzioni (creative)” di tardo Ottocento, che ridisegnano il rapporto – su scala planetaria – tra centri manifatturieri e campagne, ora che la tecnologia offre la possibilità di congiungere e controllare aree remotissime senza ricorrere allo schiavismo, generando nel suo percorso “la più significativa ondata di deindustrializzazione di sempre”; infine, il percorso e le mappe della produzione del cotone, dall’Asia al nuovo continente e ritorno. È giusto ricordare comunque come la storia globale di Beckert non dimentichi le persone, e le seicento pagine del libro siano popolate da straordinarie figure di anonimi schiavi, ricchissimi mercanti, grandi proprietari agricoli e magnati dell’industria tessile.
Come ha sintetizzato lo stesso Beckert nella rapida ma ovviamente informata voce Cotton, stilata per la History of World Trade since 1450 (a cura di John J. McCusker, Macmillan REference USA, 2006), “lungo gran parte della storia umana il cotone è stato lavorato lì dove veniva prodotto. Solo nel xix secolo, sulla scia della rivoluzione industriale, grandi quantità di cotone cominciano ad essere trasportate attraverso continenti ed oceani. Mentre il cotone diventava una delle commodity globali di maggior valore una rete commerciale di eccezionale densità ricopriva il mondo da New Orleans a Bombay, da Alessandria a Liverpool”.
Schiavi a servizio del cotone
Se per molti secoli il cotone fu una merce sostanzialmente asiatica (e per quasi un millennio il principale prodotto della manifattura preindustriale), il giro di boa avviene a fine Settecento: con la rapida espansione della produzione di tessuti di cotone in Inghilterra, e successivamente nel Continente, i mercanti europei trovarono conveniente approvvigionarsi in aree diverse dalle tradizionali piazze ottomane e asiatiche. Fu la volta del Brasile e dei Caraibi, ma già attorno al 1790 la produzione delle Indie Occidentali declinò, data la riluttanza dei piantatori locali a distogliere terra e forza lavoro dalle piantagioni di canna da zucchero (senza contare i guasti prodotti da terrorizzanti rivolte, come a Santo Domingo). La fame europea di cotone sembrava ormai irrefrenabile: fu allora la volta degli Stati Uniti, che dalle Indie Occidentali importarono il tratto fondamentale della produzione del cotone tra tardo Settecento e ricostruzione seguita alla guerra civile americana: la manodopera schiavistica.
Per tutto l’Ottocento gli Usa rimarranno i principali esportatori di cotone del mondo. Erano superbamente attrezzati: terra a volontà, clima perfetto per lo sviluppo degli arbusti di Gossypium, nugoli di schiavi e fortunati incontri con genialità tecnologiche quale la “cotton gin” (engine) di Eli Whitney, del 1793, una sgranatrice che semplificava enormemente l’arduo lavoro di separazione della fibra dai semi appiccicosi e dai residui. Le esportazioni americane letteralmente esplosero, passando dai 2 milioni di libbre del 1794 al miliardo e 768 milioni del 1860. Fino al 1936 il cotone rimarrà la principale voce delle esportazioni statunitensi (e la prima delle importazioni britanniche, seguita da lana, grano, zucchero, burro, legname, the, seta e bacon).
Nell’entre-deux-guerres altri esportatori si affacceranno, riportando il pendolo verso l’Asia, con l’India che non aveva perso il suo ruolo egemone nel mercato cinese, in sostanza ritornando così ad un mercato multipolare e sancendo la detronizzazione di King Cotton. Oggi la produzione e la lavorazione della bianca fibra ha significativamente abbandonato l’Occidente (anche se nel 2000 gli Stati Uniti producono ancora circa il 20 per cento del cotone mondiale, ma grazie a imponenti sussidi statali, quasi 4 miliardi di dollari nel solo biennio 2001-2002), tornando, per così dire, da dove erano venute.
Il mondo era diventato più piccolo
La guerra civile americana rappresenta uno spartiacque cruciale. Quando nell’aprile del 1865 i cannoni tacquero nel continente nordamericano, tra i mercanti dilagò il panico, da Liverpool a Bombay: “Questo panico globale – scrive Beckert – fece capire a contadini, operai, industriali e mercanti quanto fossero diventate salde le interconnessioni tra le varie regioni del mondo. Gli effetti delle battaglie combattute nella rurale Virginia si ripercuotevano sui piccoli villaggi del Berar e del Basso Egitto, la scelta delle sementi da parte di un contadino in Brasile era legata all’andamento del mercato di Liverpool, e a Bombay i prezzi delle proprietà immobiliari crollarono appena la notizia della distruzione di Richmond per mano delle forze unioniste raggiunse la costa dell’India”. Scrisse un osservatore britannico: “Abbiamo visto quanto siano potenti e veloci gli effetti del ‘prezzo’ nelle più remote parti del globo”. Il mondo era diventato più piccolo, commenta Beckert, ma soprattutto “era cambiato parecchio anche il modo in cui il cotone ne teneva insieme le parti”.

E il mondo, talvolta disperato, dei produttori? Racconta Beckert che in aree coloniali – in particolare in India e nella provincia di Berar – a metà Ottocento si manifesta in tutta la sua ampiezza una radicale trasformazione delle campagne, che tendono a perdere il loro carattere “ibrido” (così si esprimeva un testimone, il segretario di stato per l’India, riferendosi alla diffusa realtà protoindustriale che mescolava agricoltura e manifatture domestiche) e a dedicarsi alla produzione per i mercati mondiali, in primis quello britannico: nel Berar la tradizionale diversificazione produttiva lascia il campo alla specializzazione cotoniera, mentre l’antica manifattura si dissolve: nel 1861 la superficie a cotone era di 629.000 acri, nel 1865 raddoppia, alla fine degli anni ottanta raddoppia di nuovo, e agli inizi del XX secolo dal Berar giunge un quarto della produzione indiana di cotone, superiore a quella dell’intero Egitto. L’arrivo della ferrovia si rivelerà strategico: nel 1869 così un altro testimone potrà prevedere correttamente che il treno avrebbe introdotto nel Berar le stoffe europee, perché le popolazioni locali espulse dalla manifattura tessile potevano “essere messe a disposizione come manodopera agricola, il che (avrebbe portato) al disboscamento della giungla e al conseguente ampliamento della superficie coltivabile”. Si trattava, sostiene Beckert, della più significativa ondata di deindustrializzazione di sempre, e del tramonto della filatura e della tessitura a mano a cui si erano dedicate per secoli milioni di persone, soprattutto donne.
La nascita delle Borse
A ciò si collega un’altra radicale distruzione creativa: dopo gli anni sessanta dell’Ottocento le miriadi di intermediari che avevano consentito lo spostamento del cotone dai campi alle fabbriche furono sostituiti da un “manipolo di commercianti cotonieri (…) integrati verticalmente. (…) Importatori e intermediari vecchia maniera erano al tramonto”, ma ciò che completò la loro virtuale eliminazione fu la nascita di un “esiguo numero di Borse del cotone” in grado di controllarne il commercio globale: New York e New Orleans tra 1869 e 1871, poi rapidamente Le Havre, Brema, Osaka, Shanghai, San Paolo del Brasile, Bombay, Alessandria d’Egitto, tutti mercati specializzati nello scambio di contratti “sulla consegna futura del cotone”. Come stava avvenendo per il grano, i contratti futures domineranno il commercio mondiale delle commodity. È il segnale di un avvenuto mutamento epocale: a scambi mondiali corrisponde la creazione di una piazza – lontana e avulsa dalle zone di produzione – dove si determina il prezzo di quella materia prima, ora divenuta appunto una moderna commodity, e si controlla a distanza il destino di milioni di vite legate alla produzione e alla lavorazione del cotone in tutto il mondo.
Beckert descrive molto bene questa transizione da un commercio interpersonale, basato sulla valutazione “individuale” della merce e la fiducia reciproca, ad uno “totalmente astratto dalla realtà materiale del cotone e altamente standardizzato” il cui risultato sarà la determinazione di un unico prezzo mondiale “disponibile a qualsiasi ora del giorno”. A sua volta il processo decisionale relativo alla standardizzazione della materia prima passava dai mercanti agli uffici statali: ad esempio dal 1914 sarà attivo a New York l’Original Official Cotton Standards of the United States, responsabile della validazione tecnica dei contratti futures, e nel 1923 verrà promulgato il Cotton Standard Act, che rese illegale qualsiasi altro standard. In buona sostanza la costruzione dell’impero del cotone ritratto da Beckert fu il risultato di due forze confluenti, dove l’aggressività di mercanti, piantatori e imprenditori si salda – pressoché in ogni passaggio strategico – con l’intervento degli stati e dei governi, finanziando e costruendo infrastrutture essenziali alla produzione e alla commercializzazione del cotone, o obbligando con la forza altri paesi semi-indipendenti a rinunciare, per fare un esempio, a forme di protezione dalle importazioni britanniche ed europee. Ma rimane qualche dubbio che la pur affascinante storia del cotone possa davvero contenere e rappresentare la storia del capitalismo tout court, come è palese nelle aspirazioni di Beckert.
Rivoluzione commerciale
Ora, il paradigma interpretativo che sottende il libro è al tempo stesso nuovo e antico; potremmo definirlo neo-marxista ma le etichette non rendono giustizia alla ricchezza e alle molteplici nuances del libro, né servirebbe citare Polanyi, Arrighi o Gunder Frank come probabili riferimenti interpretativi, peraltro non citati. Sta di fatto che la storia del cotone di Beckert vuole essere la storia degli esordi di un capitalismo (una volta si sarebbe parlato di fase mercantilista) che nella guerra, nel dominio, nella schiavitù trova il suo fuoco e il suo metro, mettendo invece in secondo piano – si pensi a recenti lavori altrettanto ricchi di stimoli, come The World that Trade Created, di Kenneth Pomeranz e Steven Topik (Sharpe, 1999), o Global Markets Transformed 1870-1945, di Steven Topik e Wells Allen (Harvard University Press, 2014) – l’immensa mole, enigmatica nella sua densità, di innovazioni tecnologiche e organizzative che accompagna (induce?) la trasformazione dell’economia e della società contemporanee.
Il dibattito su questo punto rimane aperto, ma attraverso il prisma di una singola merce Beckert ci ha offerto comunque un contributo fondamentale all’indagine di una troppo spesso negletta “rivoluzione commerciale”, che a chi scrive pare addirittura più importante della contigua, studiatissima “sorella” industriale. Il mondo degli scambi e dei “mercanti” e delle loro peculiari tecniche finanziarie e organizzative – individui, famiglie, multinazionali, compagnie, bazar, borse merci, brokers e contratti, senza dimenticare lo sviluppo di apparati scientifici e accademici, quali camere di commercio internazionali, scuole commerciali e di business – rimane ancora al di là di una frontiera raramente attraversata dagli storici (anche se non mancano luminosi tentativi, come l’importante libro di Stanley Chapman, Merchant Enterprise in Britain: From the Industrial Revolution to World War I, Cambridge University Press, 2003). Pascoli ideali per futuri storici globali.
carlo.fumian@unipd.it
C Fumian insegna storia contemporanea all’Università di Padova
Seguendo le merci: sul numero di aprile 2017 Carlo Fumian intervista Sven Beckert.


