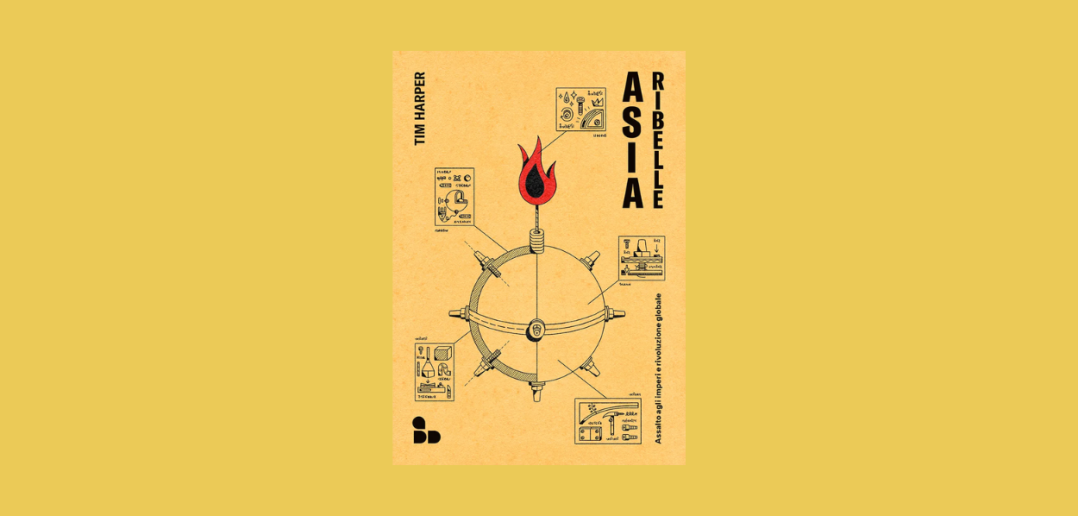Nuovi approcci storiografici su un continente in rivolta
di Noemi Lanna
Il volume Asia ribelle (add, 2024) di Tim Harper costituisce il continuum storiografico delle monografie Forgotten Armies. The Fall of British Asia, 1941-1945 (2004) e Forgotten Wars. the End of Britain’s Asian Empire (2007), scritte a quattro mani con Christopher Bayly da Harper, che insegna storia del Sudest asiatico all’Università di Cambridge. Come lo stesso Harper osserva, in tutti e tre i volumi, protagonista è la guerra, più precisamente il conflitto iniziato con l’invasione giapponese del Sudest asiatico nel 1941-1942. L’attacco dell’impero giapponese ipoteca ciò che fino a poco tempo prima appariva alle Forze alleate come una solida risorsa: la vasta porzione di possedimenti britannici compresa tra l’India e Singapore, serbatoio di forze armate e generosa dispensatrice di ambite materie prime. Al tempo stesso, innesca una sanguinosa trasformazione che porterà alla fine dell’impero britannico in Asia e alla nascita del moderno Sud e Sudest asiatico.
Le guerre combattute da eserciti “dimenticati” prima e dopo la sconfitta del Giappone costituiscono l’oggetto di alcune pubblicazioni recenti nelle quali la ricostruzione delle vicende belliche diventa premessa per una più ampia riflessione sullo sgretolamento dell’ordine coloniale e sulle dinamiche che hanno portato al raggiungimento dell’indipendenza nel lungo periodo.
In Asia ribelle, Harper getta luce sugli eventi prodromici a questa profonda trasformazione per analizzare il ruolo che la rete clandestina attiva in India, Cina e Sudest asiatico ha avuto nella resistenza anticoloniale e nei processi di nation building. Le coordinate temporali della ricerca sono già di per sé indicative della sua originalità. Il punto di partenza è il 1905, anno in cui il Giappone trionfa sulla Russia zarista, imponendosi come punto di riferimento per la resistenza anticoloniale, ma anche anno della partizione del Bengala, che suscita proteste e boicottaggi di merci britanniche. Il punto di arrivo dell’analisi è il 1927, anno in cui si consuma l’ultima delle grandi rivolte, quella che chiude la stagione del movimento clandestino asiatico e anticipa la guerra fredda, “i cui inizi si possono rintracciare nel panico bolscevico che colse gli imperi negli anni venti, o ancora prima nella battaglia contro l’anarchismo internazionale”. Il risultato di questa innovativa impostazione è un’analisi che propone una visione “eccentrica”. La prospettiva di Harper ridimensiona la portata periodizzante della prima guerra mondiale (e degli eventi a essa strettamente correlati come la rivoluzione bolscevica e la fine degli imperi), trascende i confini nazionali in un approccio felicemente transnazionale e tiene in debito conto le peculiarità delle reti clandestine che sono oggetto del volume. Esse sono state infatti non solo occulte ma anche simbiotiche nelle loro relazioni con le forze dell’ordine internazionali: persecutori e perseguitati si sono alimentati e plasmati a vicenda, come nel volume è sapientemente dimostrato.
L’Asia ribelle che dà il titolo italiano al volume è l’Asia “sotterranea” (Underground Asia è il titolo originale del libro), fatta da una generazione in movimento che opera in un mondo interconnesso: non quello visibile e compiaciuto delle grandi esposizioni universali e dei processi di integrazione economica globale, ma quello oscuro e temuto – ma non per questo meno interdipendente – che opera sotto la superficie dell’impero, affrontando il potere occidentale “con la logica del suo stesso globalismo”. Quello che fu capace, prima ancora di “assaltare gli imperi”, come recita la seconda parte del titolo, di “vedere l’Asia come un tutto unico”, andando oltre le barriere poste dai confini coloniali. Le storie di questo “mondo alla rovescia” sono narrate in modo avvincente, pur senza nulla sacrificare al rigore scientifico. Ciò rende la lettura dell’opera non solo stimolante per l’originale prospettiva storiografica che offre, ma anche piacevole.
Il Giappone, che affiora più volte nel grande affresco storico di Harper ora come oggetto di fascinazione dell’Asia ribelle ora come suo implacabile persecutore, è protagonista di Il Giappone contemporaneo dal 1945 a oggi (Einaudi, 2024) di Andrea Revelant, che insegna storia del Giappone all’Università Ca’ Foscari di Venezia. La monografia copre la storia del secondo dopoguerra, suddividendo la trattazione in tre grandi blocchi. La prima parte si concentra sul decennio della ricostruzione, nel quale ha luogo un processo di profonda trasformazione delle strutture istituzionali, politiche, sociali ed economiche fortemente influenzato dal settennio dell’occupazione militare alleata del Giappone (1945-1952). Nella seconda parte, si analizza il periodo della “lunga crescita” (1955-1990), caratterizzato da una protratta espansione economica terminata negli anni novanta, ovvero “l’età dell’incertezza” alla quale è dedicata la terza parte dell’opera. La ricostruzione storica è attenta alla dimensione economica, sociale e politica che sono sistematicamente analizzate in ciascuna delle tre parti. Uno spazio particolare è dedicato all’analisi delle istituzioni e dei sistemi normativi, anche a livello internazionale e al contributo che il Giappone ha dato alla loro definizione.
Per la ricchezza di temi e di intersezioni, il volume offre tre possibili itinerari di lettura. Può essere letto innanzitutto come complemento del volume Il Giappone moderno dall’Ottocento al 1945 (Einaudi, 2018) dello stesso autore. Se è vero che il 1945 ha segnato una cesura profonda, è altrettanto vero che non sono mancati elementi di continuità. Come la storiografia più recente ha evidenziato, la nascita del Giappone democratico e pacifista nel secondo dopoguerra è avvenuta con modalità che per essere comprese appieno richiedono un continuo raffronto con le dinamiche prebelliche e una lucida consapevolezza della natura composita che ha avuto l’azione riformatrice delle Forze alleate – innovativa e radicale in alcuni settori, meno incisiva in altri. In secondo luogo, il volume si presenta come uno stimolante contributo alla storia della guerra fredda. “Ancora estremorientale” – per riprendere la icastica definizione di Brzezinski – della quale gli Stati Uniti avevano bisogno per tutelare i loro interessi nel Pacifico, con la sua stabilità e il suo dinamismo economico, il Giappone è stato una componente fondamentale della Pax americana in Asia. Analizzando il contesto interno e internazionale nel quale le scelte di Tokyo sono maturate, il volume contribuisce a gettare luce sulle dinamiche economiche e securitarie della regione nell’era bipolare. Infine, il libro di Revelant può essere un interessante punto di partenza per l’analisi della storia italiana. Come ha ben argomentato Richard Samuels nel suo Machiavelli’s Children. Leaders and their Legacies in Italy and Japan (Cornell UP, 2003), anche nel secondo dopoguerra Italia e Giappone hanno condiviso vincoli strutturali (la vulnerabilità legata alla peculiare collocazione nei rispettivi contesti geopolitici regionali), facendo fronte con scelte analoghe (massimizzare i vantaggi dell’allineamento con gli Stati Uniti) alle sfide poste dal bipolarismo. L’articolata analisi del lungo percorso che ha traghettato il Giappone dalla ricostruzione agli incerti anni novanta, accompagnata da frequenti rimandi al caso italiano, illumina la storia contemporanea dei due paesi, fornendo ampi spunti di riflessione non solo ai lettori specialisti ma anche a chi si accosti per la prima volta alla storia dell’arcipelago.
nlanna@unior.it
N. Lanna insegna storia moderna e contemporanea del Giappone all’Università L’Orientale di Napoli