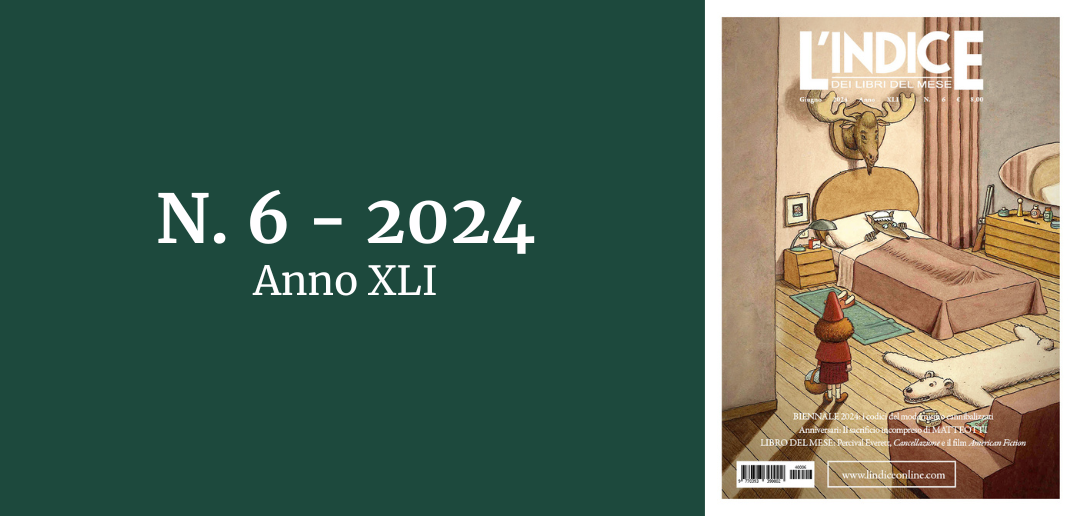Una storia non facile da comprendere
di Niccolò Pianciola
Chiunque segua il discorso pubblico intorno alla guerra in Ucraina non può che giungere alla conclusione che questo paese sia difficile da capire per noi italiani. Due aspetti in particolare ne rendono ardua la comprensione. Da un lato, la cultura e la società ucraine sono state plasmate nel corso degli ultimi secoli da un rapporto di subalternità imperiale a un grado che forse non ha paralleli in Europa. Inoltre, la storia dell’Ucraina è costellata di fratture profonde e traumatiche che hanno diviso le generazioni non solo per le transizioni di regime susseguitesi nel Novecento, ma per il ricorrente oblio imposto su avvenimenti e figure storiche anche recenti. Una serie di libri dà ora ai lettori la possibilità di orientarsi nelle peculiarità di questa storia spaesante.
Per leggibilità e ampiezza dello sguardo, i libri di Simone Bellezza e Andreas Kappeler sono le migliori introduzioni a una storia dell’Ucraina interpretativa di lungo periodo. Quella di Kappeler è un’analisi dell’interconnessione della storia ucraina e russa, che mette bene in evidenza il rapporto asimmetrico tra le due culture nel corso delle grandi trasformazioni ottocentesche, tenendo al centro della narrazione gli individui e le loro scelte, anche di appartenenza nazionale, e fornendo coordinate importanti per capire come mai la maggioranza della classe politica russa a partire dal 1991 non sia riuscita a pensare all’Ucraina come a uno stato indipendente. Questa convinzione, spiega Kappeler, data almeno dall’inizio del XIX secolo, se non prima, e accomuna pressoché tutto lo spettro politico. Nel 1823 Pavel Pestel’, il decabrista propugnatore di un progetto di repubblica democratica di stampo giacobino, stabiliva nel suo progetto costituzionale che tutti gli abitanti delle province ucraine dovessero essere “considerati autentici russi”. Seguirono poi slavofili come Ivan Aksakov, occidentalisti come Michail Katkov, liberali come Pëtr Struve che nei decenni successivi denunceranno “l’idea ucraina” (ovvero che esistesse una nazione ucraina separata da quella russa) usando metafore simili sulla divisione “innaturale” del corpo nazionale. Scriveva Struve nel 1912 che se l’intellighenzia ucraina riuscirà a “infettare il popolo con la sua ‘ucrainicità’, allora vedremo formarsi una falla immensa e inedita nel seno dello stesso popolo russo”. L’idea degli ucraini come sottoinsieme dei russi è dunque antica, ha una diffusione storicamente ben più vasta degli ambiti della destra nazionalista o della tradizione slavofila, ed è una conseguenza diretta della dimensione imperiale della dominazione zarista. Come ha ricordato Francesco Strazzari, uno dei più lucidi studiosi italiani di relazioni internazionali, citando intellettuali ucraini che hanno adottato una prospettiva postcoloniale, anche il diffuso scarso investimento a conoscere un paese “a lungo pensato come insignificante, dotato di una cultura minore (“tanto lì parlano tutti il russo…”), ridotto a pedina in un gioco geopolitico fra Russia e Occidente” è conseguenza della lunga storia di rapporti imperiali tra centro russo e periferia. Merito di Strazzari è anche quello di decostruire e contestualizzare il concetto di “geopolitica”, che ha goduto di tanta fortuna negli ultimi decenni.
L’agile libro di Bellezza è invece una panoramica sul movimento nazionale ucraino negli ultimi due secoli, un tipo di studio che a tutt’oggi non esiste in nessun’altra lingua. L’esaustività dei riferimenti bibliografici ne fanno un’ottima guida introduttiva alla storiografia sull’Ucraina in età contemporanea. Bellezza tratteggia una storia transnazionale del processo di identificazione sociale e politica con l’idea di Ucraina: un approccio in parte obbligato, vista l’importanza della Galizia austriaca nella storia del movimento nazionale ucraino nell’Ottocento. Ma tratta anche l’attivismo (non necessariamente nazionalista) nelle comunità ucraine della diaspora, soprattutto nordamericana, ingrossate da flussi migratori composti in gran parte di rifugiati politici fuggiti dalle guerre e rivoluzioni che hanno devastato e insieme consolidato politicamente, nel Novecento, le terre ucraine. Pone poi esemplarmente il nazionalismo ucraino tra gli anni venti e quaranta nel contesto dei “nazionalismi integrali” variamente legati al fascismo e al nazismo, collocando l’Organizzazione dei nazionalisti ucraini (fondata nel 1929 e poi guidata anche da Stepan Bandera) nella famiglia dei fascismi europei.
Un’altra storia che si vuole “globale” dell’Ucraina (anche se in traduzione italiana ha perso l’aggettivo nel titolo), quella di Yaroslav Hrytsak, analizza le popolazioni delle attuali terre ucraine nella rete di connessioni che le hanno legate ad altre regioni d’Europa e del mondo: dalle influenze culturali (che gli ucraini, prima di diventare sudditi periferici di una metropoli imperiale, avevano esercitato sulla cultura moscovita), ai mercati globali. Con un’indovinata costruzione del testo, Hrytsak inframmezza i capitoli con sezioni tematiche che seguono un fattore o un fenomeno cruciale della storia ucraina attraverso i secoli. È appunto il caso del grano delle terre nere, che da tempo nutre le popolazioni di altri continenti, e che era diventato la più importante commodity esportata dall’impero zarista nella seconda metà del XIX secolo. Hrytsak è riuscito a realizzare l’ambizioso progetto di scrivere una “storia nazionale” di lungo periodo libera dal “nazionalismo metodologico” che reifica la nazione come soggetto storico attraverso i secoli, in un libro dal forte taglio interpretativo e poco “evenemenziale”, di scorrevole lettura poco aiutata però da una traduzione non sempre all’altezza. Anche Hrytsak, come Bellezza, non fa sconti alla narrazione nazionalista, mettendo in luce le responsabilità delle formazioni militari ucraine nell’ondata di pogrom antiebraici durante la guerra civile postzarista, così come la partecipazione dei nazionalisti ucraini alla Shoah e la loro politica di pulizia etnica dei polacchi in Volinia e Galizia nel 1943-45. Se Kappeler aiuta a capire la dimensione di subalternità imperiale della società e della cultura ucraine, e a contestualizzare l’evoluzione dell’attivismo nazionale ucraino, Bellezza e Hrytsak mettono a fuoco la seconda grande alterità della storia ucraina nelle ricorrenti cesure storiche traumatiche e nell’oblio imposto sul passato. Ad esempio, la cruciale “generazione degli anni sessanta”, gli intellettuali ucraini del pre-dissenso cui Bellezza ha dedicato una monografia che erano imbevuti dell’ideologia socialista, alla quale le istituzioni sovietiche li avevano acculturati, e ignoravano il recente passato ucraino, dalle dinamiche della grande carestia alla tradizione nazionalista, di cui era proibito parlare in Urss.
Bandera e i suoi sodali rimasero schiacciati tra una memoria della resistenza antisovietica post-1945 (una guerra vera e propria che fece centinaia di migliaia di morti fino all’inizio degli anni cinquanta), e la propaganda sovietica che ne faceva dei semplici lacchè dei nazisti. Solo con l’indipendenza fu possibile sviluppare una storiografia libera e pluralista, troppo tardi per evitare la strumentalizzazione politica di Bandera: un simbolo che, nell’Ucraina postsovietica, fu “risemantizzato” come emblema della resistenza contro le mire imperiali moscovite, sottacendone le convinzioni fasciste e le pratiche genocidarie di Oun e Upa. Questa selettività chiarisce però che il suo uso politico recente ha poco a che fare con la popolarità di idee di estrema destra nel paese. La complessa transizione dall’Ucraina sovietica allo stato indipendente è al centro della poderosa ricerca di Simona Merlo. Più di due terzi del suo libro sono dedicati al periodo 1985-1994, dalla salita al potere di Gorbačëv alle prime elezioni presidenziali dell’Ucraina indipendente, primo passaggio di potere pacifico e democratico. La vittoria di Kučma nel 1994 ha segnato l’inizio della divergenza politica e culturale dell’Ucraina dalla Russia, una recente e peculiare traiettoria storica sapientemente delineata da Andrea Graziosi in un libro che analizza anche le pesanti eredità sovietiche nel consolidamento del regime di Putin. Lo studio di Merlo è basato su una solida ricerca negli archivi, e fornisce un quadro sfaccettato degli attori politici degli anni di transizione attivi nelle varie regioni dalle spiccate peculiarità sociali, economiche e culturali, le cui complesse interazioni hanno composto il mosaico dell’Ucraina indipendente. Nella parte introduttiva, Merlo fornisce anche un informatissimo ed equilibrato panorama della storia politica ucraina nel secondo dopoguerra, e un lungo epilogo segue le vicende del paese dal 1994 all’invasione russa. Il ritorno della Storia di Serhii Plokhy – di cui era stata da poco tradotta una nitida sintesi (Le porte d’Europa) basata su una mole impressionante di ricerche su vari aspetti della vicenda storica ucraina – documenta nei dettagli l’aggressione russa dal 2014 all’inizio del 2023, ricollegando l’invasione su larga scala alla sindrome postimperiale delle élite russe. Come Bellezza, anche Plokhy vede nell’attuale guerra uno spartiacque storico nella coscienza politica ucraina, pietra miliare di una identificazione nazionale ormai inesorabilmente contrapposta a quella russa.
niccolo.pianciola@unipd.it
N. Pianciola insegna storia dell’Eurasia all’Università di Padova