Scenari euroatlantici di contestazione e difesa delle disuguaglianze consolidate
di Gian Giacomo Migone
dal numero di luglio/agosto 2016
Quali che siano gli attentati, i colpi di scena, gli scheletri che i due principali candidati – Hillary Clinton e Donald Trump – tireranno fuori dall’altrui armadio, prima durante e dopo le convention, ad oggi le elezioni presidenziali in corso hanno confermato la vitalità delle istituzioni americane e la conseguente capacità di accogliere e incanalare novità politiche di grande rilievo. Malgrado gli sforzi titanici di occultarli, per manipolazione, falsa coscienza o semplice ignoranza, dei principali media, non soltanto italiani.
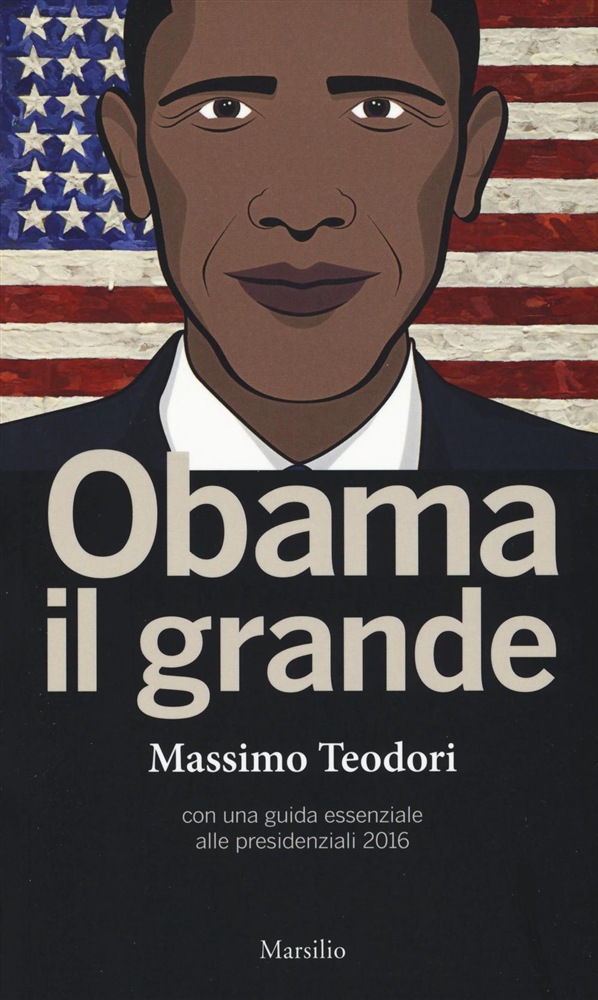 Prima di prendercela con i media, rendiamo conto di quanto è stato pubblicato in forma di libri, com’è nostro compito. Innanzitutto, Massimo Teodori, collaudato esperto ed insegnante di politica americana in Italia, ha fornito un agile libretto il cui contenuto corrisponde al titolo: Obama il grande, con una guida essenziale alle presidenziali 2016 (pp. 110, € 10, Marsilio, Venezia 2016). Si tratta di una sommaria difesa dell’operato del presidente uscente che ne mette in luce alcuni risultati acquisiti (tra cui il consolidamento dello status degli afro-americani nelle istituzioni, l’estensione della tutela della salute a circa due terzi della popolazione, una maggiore cautela nell’impegno militare statunitense in giro per il mondo). Tuttavia, l’autore non identifica nella lettura multipolare di quel mondo uno dei meriti principali della presidenza di Obama; forse per la preoccupazione, più dell’autore che dell’oggetto della sua indagine, di riaffermare un primato egemonico degli Stati Uniti rispetto ad altri stati emergenti. L’autore attribuisce esclusivamente a una destra che lo vorrebbe riscattare, la tesi di un declino del potere americano, sempre in termini relativi rispetto al resto del mondo. Forse anche per il carattere sintetico e divulgativo del volume, l’autore sceglie di ignorare il dibattito, di ampio respiro storiografico, che si è sviluppato per anni su questo argomento. Mentre David P. Calleo, Paul Kennedy, Prem Shankar Jha e altri hanno impostato e alimentato questo dibattito, individuando nella guerra del Vietnam una svolta nel senso del declino, altri, Niall Ferguson, non a caso evocato da Teodori, e Norman Kagan, per non citare l’ormai pentito Fukuyama, si sono schierati sul fronte opposto, fino a comprendere Victoria de Grazia e David Ellwood, che individuano le rinnovate potenzialità egemoniche americane soprattutto nel soft power derivante dalle innovazioni tecnologiche. Teodori non coglie, o sceglie di non cogliere, la sfida – non solo da destra (Trump e i suoi precursori europei), ma anche da sinistra (Sanders, Corbyn, che hanno dato forma politica più compiuta a movimenti popolari come quello spagnolo e greco) – che si profila contro uno stato di ineguaglianza crescente nelle società occidentali, tale da averne indebolito le istituzioni politiche, compresa quella rappresentata dalla stessa presidenza Obama.
Prima di prendercela con i media, rendiamo conto di quanto è stato pubblicato in forma di libri, com’è nostro compito. Innanzitutto, Massimo Teodori, collaudato esperto ed insegnante di politica americana in Italia, ha fornito un agile libretto il cui contenuto corrisponde al titolo: Obama il grande, con una guida essenziale alle presidenziali 2016 (pp. 110, € 10, Marsilio, Venezia 2016). Si tratta di una sommaria difesa dell’operato del presidente uscente che ne mette in luce alcuni risultati acquisiti (tra cui il consolidamento dello status degli afro-americani nelle istituzioni, l’estensione della tutela della salute a circa due terzi della popolazione, una maggiore cautela nell’impegno militare statunitense in giro per il mondo). Tuttavia, l’autore non identifica nella lettura multipolare di quel mondo uno dei meriti principali della presidenza di Obama; forse per la preoccupazione, più dell’autore che dell’oggetto della sua indagine, di riaffermare un primato egemonico degli Stati Uniti rispetto ad altri stati emergenti. L’autore attribuisce esclusivamente a una destra che lo vorrebbe riscattare, la tesi di un declino del potere americano, sempre in termini relativi rispetto al resto del mondo. Forse anche per il carattere sintetico e divulgativo del volume, l’autore sceglie di ignorare il dibattito, di ampio respiro storiografico, che si è sviluppato per anni su questo argomento. Mentre David P. Calleo, Paul Kennedy, Prem Shankar Jha e altri hanno impostato e alimentato questo dibattito, individuando nella guerra del Vietnam una svolta nel senso del declino, altri, Niall Ferguson, non a caso evocato da Teodori, e Norman Kagan, per non citare l’ormai pentito Fukuyama, si sono schierati sul fronte opposto, fino a comprendere Victoria de Grazia e David Ellwood, che individuano le rinnovate potenzialità egemoniche americane soprattutto nel soft power derivante dalle innovazioni tecnologiche. Teodori non coglie, o sceglie di non cogliere, la sfida – non solo da destra (Trump e i suoi precursori europei), ma anche da sinistra (Sanders, Corbyn, che hanno dato forma politica più compiuta a movimenti popolari come quello spagnolo e greco) – che si profila contro uno stato di ineguaglianza crescente nelle società occidentali, tale da averne indebolito le istituzioni politiche, compresa quella rappresentata dalla stessa presidenza Obama.
 Questo compito è stato, invece, assolto da un altro volumetto di Bernie Sanders, Quando è troppo è troppo! Contro Wall Street, per cambiare l’America, (a cura di Rosa Fioravante, pp. 187, € 15, Castelvecchi, Roma 2016) a cui lo stesso editore ha fatto opportunamente seguito con un libro dedicato a un fenomeno politico, per molti aspetti analogo a quello di Sanders, che ha portato Jeremy Corbyn alla guida del partito laborista britannico (Jeremy Corbyn, La rivoluzione gentile, a cura di Domenico Cerabona Ferrari, pp. 95, € 12,50, Castelvecchi, Roma 2016). I media tacevano, o liquidavano come marginali e antiquati questi nuovi protagonisti, fino al momento in cui Corbyn non superò la prima prova elettorale delle elezioni amministrative (con risultati negativi soltanto in Scozia, per opera del partito indipendentista) e Sanders non vinse, poco alla volta, le primarie in ben ventitré stati.
Questo compito è stato, invece, assolto da un altro volumetto di Bernie Sanders, Quando è troppo è troppo! Contro Wall Street, per cambiare l’America, (a cura di Rosa Fioravante, pp. 187, € 15, Castelvecchi, Roma 2016) a cui lo stesso editore ha fatto opportunamente seguito con un libro dedicato a un fenomeno politico, per molti aspetti analogo a quello di Sanders, che ha portato Jeremy Corbyn alla guida del partito laborista britannico (Jeremy Corbyn, La rivoluzione gentile, a cura di Domenico Cerabona Ferrari, pp. 95, € 12,50, Castelvecchi, Roma 2016). I media tacevano, o liquidavano come marginali e antiquati questi nuovi protagonisti, fino al momento in cui Corbyn non superò la prima prova elettorale delle elezioni amministrative (con risultati negativi soltanto in Scozia, per opera del partito indipendentista) e Sanders non vinse, poco alla volta, le primarie in ben ventitré stati.
Da questi modesti libretti, praticamente introvabili sui banchi delle librerie (e questo è un altro problema), emerge una nuova realtà politica. Che il dominio di una finanza irresponsabile, capace di comprare la politica di cui ostenta e alimenta il disprezzo, peraltro spesso giustificato, di provocare una crisi economica mondiale lucrandoci sopra, è ormai sfidato da una nuova modernità politica, che crede in diritti e libertà democratiche, strumentalmente usati dalla politica vecchia, dei Clinton, dei Blair, persino dal piccolo Renzi. È questo il senso profondo e duraturo della candidatura di Bernie Sanders, non a caso sostenuta da giovani di tutte le razze e da quei lavoratori disoccupati e precari che respingono l’invito di Trump a rivolgere la loro rabbia contro nuovi immigrati, in fuga da guerre, malattie, corruzione, droga in larga parte importati dai loro paesi dal più ricco Occidente. Il senatore del Vermont non diventerà candidato del partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, ma è già l’arbitro del destino di una candidata assai più vulnerabile; la quale ha disperato bisogno, per sconfiggere Trump, almeno di una parte dei voti conquistati dal suo rivale democratico nel corso delle primarie. Infatti, ciò che non è stato spiegato ai più, è il mutamento strutturale subito dal sistema politico americano.
Se fino all’elezione di Reagan, con una partecipazione stabile al voto di poco superiore al 50 per cento, vinceva il candidato, democratico o repubblicano che fosse, in grado di conquistare gli elettori moderati di centro, da quando è cresciuta la partecipazione al voto (fino a raggiungere la punta del 64 per cento nella prima elezione di Obama), non è più così. Vince chi convince il maggior numero di elettori, rispettivamente alla propria destra e alla propria sinistra, ad andare alle urne, con l’effetto inevitabile di radicalizzare lo scontro che diventa competizione all’interno delle istituzioni, come da noi (sarà una coincidenza?). Da questo punto di vista Hillary Clinton è una candidata assai vulnerabile, al punto che ci potrebbe essere qualche colpo di scena dell’ultima ora, in occasione della convention di Philadelphia. Per quanto Hillary possa mobilitare Obama, Elizabeth Warren (particolarmente preziosa perché con Sanders la principale critica di Wall Street), più difficilmente lo stesso Sanders, come può non essere identificata come la principale rappresentante di una classe dirigente non soltanto politica, sempre più odiata? O liberarsi di un passato tuttora incombente? Non è un caso se la candidata in pectore si è sempre rifiutata di rendere pubblici i discorsi a pagamento di fronte alla banca Goldman Sachs per oltre 600.000 dollari e i contenuti delle mail che non avrebbe dovuto gestire dal suo server privato quando guidava il Dipartimento di stato (suscitano sospetti diffusi i finanziamenti della Fondazione Clinton, provenienti dall’Arabia Saudita, paese accusato di sostenere il terrorismo islamico di marca wahabita e sunnita).
Persino Ernesto Galli della Loggia in un editoriale di prima pagina del “Corriere della Sera” del 3 giugno, ha dovuto prendere atto che negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna, è in atto una grande ribellione, soprattutto giovanile, che coinvolge un numero crescente di persone. Essa si fonda su una presa di coscienza che, dalla scintilla di Occupy Wall Street, si diffonde nell’intero paese, con un tema dominante: combattere una diseguaglianza che dagli anni ottanta, senza correttivi rilevanti, rende pochi ricchi sempre più ricchi a scapito di tutti gli altri, dalla borghesia medio-alta in giù. Ne consegue che la ribellione ha spazi potenziali di crescita pressoché illimitati e che, soltanto per i meccanismi di controllo tecnico delle primarie statunitensi (per tacere delle continue contestazioni della regolarità del voto), non ha assunto una dimensione ancora più dirompente nei confronti del sistema politico nel suo insieme.
Senza spiegarne le origini e le ragioni economico-sociali, in un primo tempo i così detti mainstream media hanno liquidato il fenomeno sottolineando gli aspetti grotteschi della candidatura di Donald Trump come un sintomo di malessere che spinge soprattutto all’estrema destra larghi strati di popolazione nei principali stati occidentali. È diffusa la consapevolezza di connotati razzisti accentuati dai flussi immigratori, ulteriormente esasperati da una lettura etnico-religiosa di attentati come quello di Orlando, mentre qualche commentatore si spinge fino a evocare gli effetti, storicamente verificati, che può avere una diffusa proletarizzazione dei ceti medi. Per mesi la ribellione narrata è stata quella all’estrema destra, all’interno del partito repubblicano, mentre i suoi effetti sul partito democratico sono stati lungamente ignorati o minimizzati. I Farage, Le Pen, Salvini in Europa, ora Trump negli Stati Uniti, sono stati più pronti a tradurre in politica questo malessere. Ma quali lezioni ne derivano per i vari Clinton, Hollande e Renzi?
Coloro che oggi sono al comando, i cavalieri della finanza e delle multinazionali dominanti, quelli che appaiono sullo schermo, dietro al tavolo dei ministri al G8, nello straordinario film di Roberto Andò Le confessioni – non certo disponibili a cedere potere a chi potrebbe seriamente intaccare l’assetto vigente – sarebbero capaci di cavalcare la nuova destra, anziché continuare a illudersi che si tratta di un avversario di comodo? Per poi considerarlo un male minore in qualche modo addomesticabile, come in altri frangenti di una storia non lontanissima. È quello che il partito repubblicano sta facendo nei confronti di Trump, con i rischi del caso. Oppure preferiranno, costoro, sostenere Clinton, la democratica, perché compatibile? Un’Europa ancora alla ricerca di se stessa farà bene a prestare attenzione. Il problema si pone se la stessa Banca Morgan – che contribuì in maniera rilevante a consolidare il regime di Mussolini nella seconda metà degli anni venti – sente il bisogno di raccomandare la revisione di carte costituzionali prodighe di diritti come quella italiana e tedesca, pur di non mettere in discussione una virgola del suo pensiero unico (cfr. J. P. Morgan and Co., The Euro area adjustment: about halfway there, in “Europe Economic Research”, 28 maggio 2013).
g.gmigone@libero.it
G G Migone ha insegnato storia del Nord America e delle relazioni euro-atlantiche per oltre quarantacinque anni


