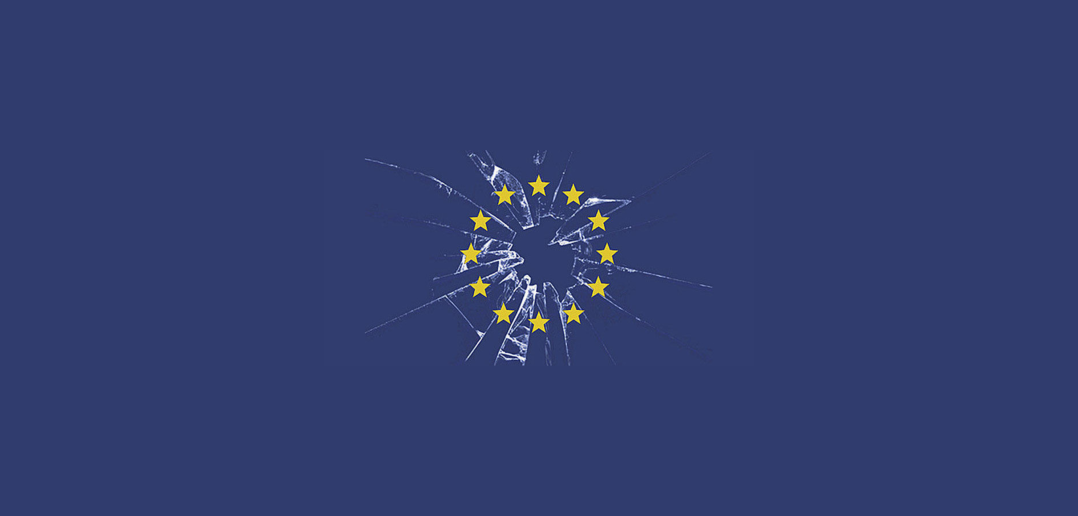La crisi dell’Unione europea tra deficit democratico e deindustrializzazione
di Jacopo Rosatelli
Riflettendo sull’Unione europea, Ralf Dahrendorf amava ripetere: “Se l’Ue facesse domanda di essere accolta nell’Ue, questa domanda dovrebbe essere respinta per insufficienza di democrazia”. La fonte è al di sopra di ogni sospetto: non un pericoloso estremista, ma un liberal-democratico; non un accanito nazionalista, ma un intellettuale cosmopolita. E, soprattutto, uno che sapeva di cosa parlava, sia in ragione delle sue ricerche, sia per essere stato membro della commissione della Comunità europea negli anni settanta. Pertanto, si tratta di un’affermazione che non si può liquidare con sufficienza, trattandola come fosse repertorio dell’impresentabile populismo euroscettico. Impossibile sfuggire alla serietà della questione: è vero che l’Ue è affetta da un grave deficit democratico?
Arduo sostenere che non lo sia: basti pensare a natura e compiti delle sue principali istituzioni – commissione, consiglio, parlamento, banca centrale – e ai rapporti che intercorrono (o no) fra di loro. Oppure al sistema di governance economica costruito a partite dal 2010, e culminato nel cosiddetto fiscal compact, che ha di fatto sottratto al libero gioco politico – a livello nazionale, ma anche a livello continentale – la determinazione degli indirizzi sulla politica di bilancio. Norme e istituzioni europee assumono un’aura tecnica, neutra, e la politica, ossia il libero confronto di visioni del mondo, scompare. Nell’Ue non vige il principio cardine della democrazia rappresentativa, anche nella sua accezione più realistica e meno esigente: poter mandare a casa i governanti che non ci sono piaciuti, sostituendoli con altri che abbiano un programma diverso. La mancata democratizzazione dell’Ue, e cioè il tradimento del progetto del Manifesto di Ventotene, è uno dei temi che accomuna i recenti volumi del sociologo tedesco Claus Offe, del politologo italiano Andrea Scavo e del duo filosofico sloveno-croato Slavoj Žižek-Srećko Horvat: testi diversi fra di loro per struttura (rispettivamente un pamphlet, un saggio e una raccolta di articoli) e linguaggio, ma che si propongono tutti di offrire strumenti di interpretazione critica della situazione nella quale versa l’Europa alla vigilia delle elezioni e a sei anni dallo scoppio della grande crisi.
Quello democratico è il primo e forse il maggiore, ma non è certo l’unico deficit di cui soffre l’attuale Ue: destano allarme il deficit di bilancio di alcuni stati membri, così come quello delle bilance commerciali. Tre deficit intrecciati fra loro, afferma Offe, risolvibili di conseguenza soltanto insieme. Opportunamente scartata quella regressiva e più semplice (“basta con l’Europa”), un’efficace soluzione dei problemi, tuttavia, non è a portata di mano. Il più radicale nel rappresentare la trappola nella quale si trova l’Europa è proprio Offe: “Ciò che sarebbe necessario fare con urgenza è estremamente impopolare e di conseguenza praticamente impossibile in un contesto democratico”. A suo giudizio, in scacco sono sia le classi dirigenti democratiche dei paesi “in salute”, coscienti che sarebbe utile adottare anche misure redistributive verso i paesi indebitati, sia quelle delle “periferie”, consapevoli del bisogno di svalutazione interna (cioè tagli a salari e welfare) per rilanciare le loro economie. Scelte politiche che risultano però impossibili, dal momento che vengono osteggiate dalle rispettive opinioni pubbliche nazionali, permanentemente a rischio di pericolose fughe a destra. La crisi dell’Ue diventa, quindi, una crisi d’ingovernabilità, resa acuta dalla mancanza di una vera dimensione politica europea sovranazionale di fronte al predominio degli attori (governi e partiti) nazionali.
Per nulla inclini a ritenere che i paesi “indebitati” dovrebbero tirare la cinghia sono Žižek e Horvat, che insistono esclusivamente sulla denuncia degli effetti delle politiche di austerità: impoverimento di massa, saccheggio dei beni pubblici, ma anche avanzata delle destre fasciste, come la greca Alba dorata. A monte di tutto ciò, una critica radicale dell’economia politica del debito: quel neoliberismo che con una mano taglia salari e pensioni e con l’altra offre alle persone la possibilità di accedere al credito al consumo, di avere accesso ai mutui per la casa, ai prestiti studenteschi al posto delle borse di studio, alle assicurazioni private al posto della sanità pubblica. Un’offerta che prevede poi, naturalmente, la restituzione della somma elargita con gli interessi: per chi non è in grado di onorare il debito sono guai. Le banche, invece, non corrono rischi: gli stati si sono sempre mostrati pronti a soccorrerle.
Si cimenta con il problema del debito anche Scavo, che sottolinea in particolare un aspetto, spesso sottovalutato: i paesi s’indebitano perché “le economie nazionali non viaggiano più ai ritmi di un tempo; perché la ricchezza che l’Europa produce non riesce più a sostenere i consumi delle famiglie e la spesa sociale”. Il vecchio continente ha smesso di essere un luogo nel quale si produce, per ridursi a essere solo un enorme supermercato: Fiat, Natuzzi, Bridgestone, Indesit sono alcuni dei nomi che raccontano gli ultimi episodi di quella che Luciano Gallino ha chiamato già dieci anni fa “la scomparsa dell’Italia industriale”. E oltre i nostri confini la musica non cambia, come mostra (uno per tutti) l’esempio della Nokia: nel 2008 chiude lo stabilimento tedesco di Bochum per spostarsi a Cluj in Romania; tre anni dopo, via anche dal sito rumeno per approdare in Asia.
I tre testi non sfuggono al classico problema del “che fare”: la critica dell’Europa reale si accompagna al delinearsi di proposte per uscire dalla crisi, in un senso ovviamente molto diverso da quello cui siamo stati abituati dalle retoriche imperanti. Alle ricette dell’austerità care ad Angela Merkel e Mario Draghi si contrappongono misure di solidarietà verso i paesi indebitati e investimenti per il rilancio dei settori produttivi. Ma anche (lo fa in particolare Scavo) un impegno dell’Ue sul fronte del commercio internazionale che miri all’introduzione di una clausola sociale negli accordi Wto, senza alcuna paura di passare per protezionisti. Già oggi esistono norme che impediscono, ad esempio, la commercializzazione di manufatti realizzati da carcerati: basterebbe estendere simili divieti ai prodotti che siano il frutto di lavoratori privi dei diritti fondamentali, e il dumping sociale all’origine della deindustrializzazione europea verrebbe frenato. Anche Žižek e Horvat invitano a pensare al ruolo globale dell’Europa (una dimensione inspiegabilmente assente nel pamphlet di Offe): un ruolo oggi nullo quando non dannoso (si pensi al suo trasformarsi in fortezza contro i migranti), ma che potrebbe essere invece molto positivo, e in grado di offrire un modello alternativo ai capitalismi americano e cinese. I difficili cambiamenti auspicati hanno bisogno, naturalmente, di soggetti che riescano a metterli in atto. Il libro di Scavo è un richiamo a sindacati e sinistra in generale a uscire dal torpore e a ingaggiare la battaglia. Dietro la genericità del riferimento alla sinistra, si coglie che l’autore ha in mente soprattutto i socialisti, la principale famiglia politica progressista nella Ue. Žižek e Horvat individuano invece nell’esperienza del partito della sinistra radicale greca, Syriza, e nel suo leader Alexis Tsipras (che scrive la prefazione al libro) i protagonisti della lotta per un’Europa diversa. Anzi, per l’Europa tout court: “Syriza è sinonimo di Europa! Syriza è sinonimo di ciò di cui dobbiamo essere orgogliosi come europei!”. Sicuro che serva un percorso di protesta e resistenza di chi soffre maggiormente la crisi si mostra Offe, che tuttavia non si esprime su chi possa assumerne la leadership per guidarci alla meta. Per uscire, cioè, dalla trappola in cui ci hanno e ci siamo cacciati.
jacopo.rosatelli@gmail.com
J Rosatelli è dottore di ricerca in studi politici
I libri
Claus Offe, L’Europa in trappola. Riuscirà la Ue a superare la crisi?, presentaz. di Michele Salvati, pp. 102, € 10, Il Mulino, Bologna 2014
Andrea Scavo, Il ratto di Europa. La battaglia globale della nuova sinistra europea, prefaz. di Cesare Damiano, pp. 161, € 11, Ediesse, Roma 2014
Slavoj Žižek-Srećko Horvat, Cosa vuole l’Europa?, ed. orig. 2013, trad. dall’inglese di Gigi Roggero, prefaz. di Alexis Tsipras, Ombre corte, Verona 2014