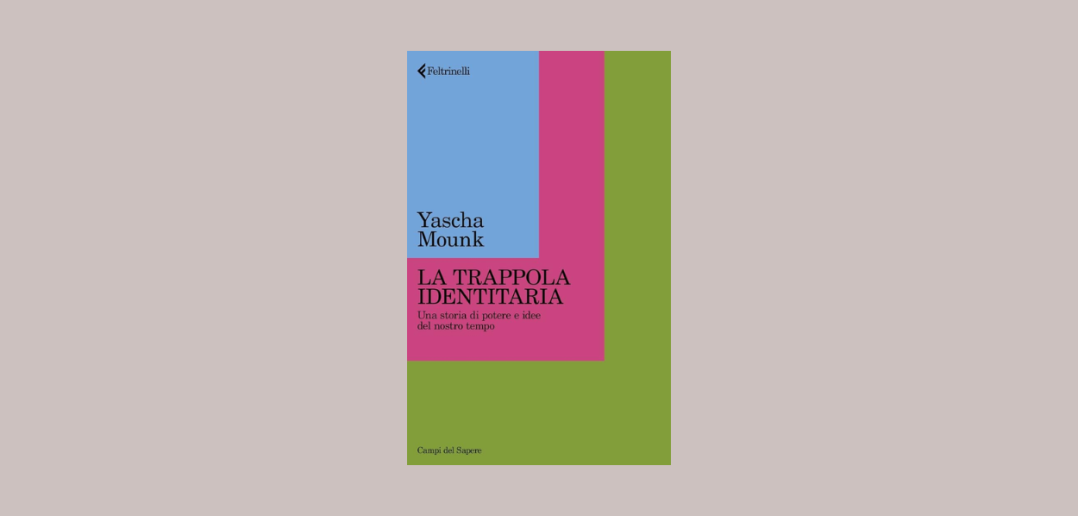Critica della sragione separatista
di Pier Paolo Portinaro
Yascha Mounk
La trappola identitaria
Una storia di potere e idee del nostro tempo
ed. orig. 2023, trad. dall’inglese di Francesca Pe’,
pp. 384, € 30,
Feltrinelli, Milano 2024
The Identity Trap è uscito in originale nel 2023. Si deve dar atto a Yascha Mounk di aver avuto buon fiuto: nel frattempo la trappola è scattata, gli americani hanno mostrato con le elezioni di novembre di volerci cascare in pieno, e ci sono cascati. A pagare il prezzo dell’elezione di Trump saranno sicuramente anche i gruppi più svantaggiati (e meno lungimiranti) dell’elettorato di destra. Ma ad aderire alla visione woke che ha così profondamente diviso la società americana sono stati i potenziali elettori del Partito democratico che non hanno espresso un voto – restando prigionieri dei veti incrociati dei talebani dei diritti e delle differenze (costati circa dieci milioni di voti). Il significato della lezione impartita dalle elezioni sembra evidente: più i gruppi che dovrebbero avere a cuore una prospettiva universalistica di emancipazione cadono vittima della trappola identitaria e più la destra radicale rafforza le sue posizioni. La trappola identitaria finisce così per essere la trappola in cui rischia di cadere la stessa democrazia.
Il libro di Mounk ricostruisce, avendo come osservatorio privilegiato gli Stati Uniti, la genesi di quella che propone di definire “sintesi identitaria”. Un costrutto che, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, si è venuto formando sotto la triplice influenza del postmodernismo, del postcolonialismo e della “teoria critica della razza” – chiamando in causa schiere di intellettuali che hanno dettato la linea nei tanti dipartimenti e centri accademici proliferati da quando ha cominciato a prendere piede la delusione sull’universalismo del movimento dei diritti civili (da Foucault a Said a Spivak). Questa ideologia poggia sostanzialmente sui seguenti postulati, sottratti, in virtù del rifiuto dell’esistenza di una verità oggettiva, a ogni falsificazione: 1) i cittadini svantaggiati appartenenti a gruppi diversi “non potranno mai capirsi a vicenda”, perché condividono esperienze significative ma incomunicabili sulla natura della loro oppressione (questo è il nocciolo della standpoint theory); 2) ai gruppi dovrebbe essere assicurata una sorta di proprietà collettiva sui loro prodotti culturali; 3) le istituzioni dovrebbero operare a) per “proteggere le minoranze dall’esposizione a discorsi offensivi o discriminatori”; b) per favorire l’identificazione dei cittadini in base a criteri etnici, religiosi, sessuali o di genere; e c) per rimediare alla diseguaglianze adottando politiche “sensibili all’identità”.
La versione popolare di queste idee ha esercitato nell’ultimo quindicennio una “tremenda influenza” sulle norme e le pratiche sociali che governano la sfera pubblica (una vera e propria marcia attraverso le istituzioni, come quella studentesca degli anni sessanta del secolo scorso) e sul piano politico ha avuto come effetto la disintegrazione della cultura politica del Partito democratico. Quello che è risultato è infatti una sorta di “separatismo progressista” che persegue la secessione dalle piattaforme politiche ispirate all’universalismo e alimenta la radicalizzazione delle culture politiche, scatenando la rabbia anche contro i dissenzienti della propria tribù. Una delle tesi del libro è che la sintesi identitaria mina alla radice il principio su cui si fonda la democrazia rappresentativa: e proprio per questo populismo di destra e trappola identitaria si alimentano a vicenda.
La sintesi identitaria si rivela controproducente in quanto le politiche pubbliche sensibili a etnia, genere, orientamento sessuale tendono a inasprire le divisioni tra i vari gruppi, aumentando il rischio di conflitti futuri. Mounk non lesina le critiche a quei settori del Partito democratico che hanno fatto proprie le “retoriche dell’equità” e la polemica contro la meritocrazia, e si impegna per contro a stilare un manifesto liberale. Il liberalismo, infatti, se da un lato è in grado di riconoscere la rilevanza dei “marcatori identitari” senza farne la chiave di tutto, dall’altro tiene fermo l’assunto che solo un orientamento universalistico può portare le società verso una vera eguaglianza di trattamento per tutti.
Mounk ha quindi mostrato fiuto nell’individuare un serio fattore di vulnerabilità della cultura politica americana e delle democrazie che da questa più si sono lasciate ispirare. Ma oltre a spiegare la natura della trappola identitaria egli dichiara di voler esporre i motivi per cui è urgente tentare la fuga, e mostrare come farlo. Sarebbe facile ma ingeneroso obiettare ora che l’intervento dell’intellettuale militante giunge tardi e che la constatazione, formulata a conclusione del volume, secondo cui si intravedono i segni che “la trappola identitaria comincia a passare di moda”, si è rivelata ingiustificatamente ottimistica. Ponderate le varie previsioni, l’autore è piuttosto prudentemente orientato ad affermare che “molti degli assunti fondamentali della sintesi identitaria si sono radicati così a fondo nell’ideologia e nelle istituzioni della società americana che non svaniranno”. Potremmo forse dire che essa è già diventata la filosofia dominante della società multiculturale.
Non convince invece l’argomentazione di Mounk nel confutare la tesi di chi vede nelle teorie woke una forma di “marxismo culturale”. In realtà i sostenitori della sintesi identitaria hanno sostituito razza, genere e orientamento sessuale alla classe economica come chiave per capire il mondo, ma al pari dei marxisti denunciano il carattere ideologico di valori universali e regole neutre e propendono, al fine di costruire un mondo più giusto, per norme e leggi che facciano “dipendere esplicitamente il modo in cui lo stato tratta i cittadini – e il modo in cui i cittadini si trattano a vicenda” – dal gruppo di appartenenza. E qui sta – andrebbe riconosciuto con severo disincanto – la ragione della crisi di fondo della sinistra occidentale, vale a dire il congiunto cedimento tanto delle analisi delle classi sociali quanto delle teorie dei diritti. Lunga e difficile appare, sembra di dover dire, la via per la riconquista della ragionevolezza politica.
pierpaolo.portinaro@unito.it
P. P. Portinaro ha insegnato filosofia politica all’Università di Torino
La tentazione essenzialista delle minoranze
di Massimo Vallerani
Il libro di Mounk ha il merito di mettere in luce i termini di un conflitto da tempo in corso nelle società occidentali, con particolare virulenza negli Stati Uniti: davanti a società non solo segmentate, ma anche violentemente polarizzate su sistemi di valori di tipo razziale, una parte rilevante dei movimenti progressisti ha sviluppato un uso “strumentale” dei concetti di identità e di razza come armi politiche: proprio la razza, termine mai tramontato negli Stati Uniti, viene assunta come segno di autoriconoscimento da parte delle minoranze discriminate. I casi più estremi di questa vague ideologica appaiono (per un lettore europeo) per certi versi sconcertanti: valga per tutti, la creazione di classi scolastiche riservate a studenti di colore o di altre minoranze etniche (per prendere coscienza della loro condizione); o la convinzione che solo i membri di una minoranza oppressa possono capire e quindi esprimere realtà inerenti alla loro “identità”, con un conseguente divieto per gli esterni di accedere alle “culture altre”. È il ritorno a un “essenzialismo identitario” che usa a piene mani nozioni riprese dall’armamentario razzista originario, con la speranza che la sua intensificazione ne rovesci il significato. Ma il significato delle parole si costruisce socialmente, non a tavolino, e soprattutto non su un tavolo impostato – in maniera paradossale per un movimento “rivoluzionario” – su un paradigma parareligioso che prevede vergogna (per i bianchi), pentimento, ravvedimento, risarcimento (degli oppressi). Mounk ha buon gioco a mostrare i limiti di questa “sintesi identitaria”, senza peraltro negare la realtà delle discriminazioni in atto.
Manca però nel libro una critica seria al concetto stesso di identità, condotta da storici, sociologi e antropologi – per l’Italia valgano gli studi di Francesco Remotti – che da tempo hanno sottolineato non solo la totale artificialità del concetto (e di questo sia Mounk sia i “separatisti progressisti” sono ovviamente al corrente) ma la nocività dei meccanismi messi in moto dall’uso applicato del termine. Ogni meccanismo identitario implica necessariamente un atto di separazione, di de-cisione, un taglio netto del flusso di legami e relazioni in cui i singoli sono immersi – e sui quali costruiscono il senso della propria personalità sociale – a vantaggio di una sola preminente caratteristica (negativa o positiva). Nella sua forma peggiore, quella etnica, l’identità è attribuita con un intento naturalmente discriminatorio e contrappositivo, per cui i membri dei vari gruppi sono in conflitto e gerarchicamente asimmetrici. Ancora: la nascita di identità è sempre accompagnata dall’affermazione di una nuova ristretta “élite di decisori” che decretano chi può entrare nel gruppo e a quale profilo sociale deve ubbidire: un atto d’imperio a cui non sfugge, purtroppo, il “separatismo progressista” che si incarica di decidere chi sono i membri di una minoranza. L’identità, comunque la si prenda, isola le persone, le impone segni distintivi e le sottomette a un’élite autoelettasi. Invertire la direzione del meccanismo (identità assunta e non “data”) non ne cambia la natura intima.
Bisognerebbe partire dal dato incontrovertibile che l’identità, e ancora di più la razza, sono termini letteralmente privi di senso sociale: non si capisce a quale realtà si riferiscono, si basano su categorie arbitrarie e in certi casi assurde (basti vedere i significati di “race” nel Census americano, che coprono con la stessa parola colore, nazione, etnia) e sono del tutto irredimibili. Quando un termine-concetto è sbagliato in sé, anche il suo uso strategico fatto con “le migliori intenzioni” è destinato al fallimento, perché il meccanismo identitario mette in moto le stesse deleterie conseguenze del suo uso “originario”. Forse, solo una lenta dissoluzione dell’identità nella pluralità delle appartenenze delle persone potrebbe funzionare come antidoto contro le politiche discriminatorie dei governi e dei gruppi dominanti.
massimo.vallerani@unito.it
M. Vallerani insegna storia medievaleall’Università di Torino