Luoghi, oggetti e liturgia
di Alessandro Del Puppo
dal numero di settembre 2017
La Holy Virgin Mary di Chris Ofili: una madonna dipinta con sterco d’elefante e clipping da riviste porno. Il Piss Christ di Andres Serrano: la foto di un crocifisso immerso in una teca contenente, così si dice, urina. La rana crocifissa di Martin Kippenberger: una rana crocifissa, appunto, con in una mano un uovo e nell’altra un boccale di birra: la simbologia è disputata.
È perfino troppo facile, quando si inizia a parlare di religione e arte contemporanea, scivolare dal sacro al sacrilegio. E fermarsi lì, compiaciuti del clamore perlopiù a buon mercato così procurato, oppure scandalizzarsene, per le stesse ragioni. O altrimenti credere che il paradigma corrente dell’arte contemporanea sia sufficiente per poter argomentare il rapporto tra arte e religione o tra arte e sacralità: quando invece, nel migliore dei casi, si conosce solo il primo termine.
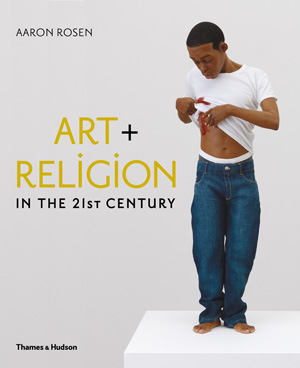 Questa almeno l’impressione che offrono alcuni recenti titoli internazionali, come il libro di Aaron Rosen Art+Religion in the 21st Century. Un volume desideroso sin dal titolo di occhieggiare ai millennials e di solleticare, perlopiù, le versioni soft e light di religioni fai-da-te, politicamente corrette e consumisticamente ben posizionate: stili di vita tra il vegano e il macrobiotico, tra lo psichedelico californiano e l’animistico caraibico, prontamente convertibili in oggetti destinati alle gallerie di Manhattan o ad Art Basel. Dove cioè la spinosa questione del sacro è affrontata nel modo più semplice possibile, cioè, perlopiù, evitandola o diluendola in una retorica new age politicamente correttissima. Un tale canone di artisti, peraltro indistinguibile da quello mercantile delle top galleries internazionali, suscita non poche perplessità. È perfino troppo semplice osservare che l’arte religiosa si è convertita, e da tempo ormai – lasciando da parte Hegel – in religione dell’arte, a sottofondo mistico-contemplativo: il rarefatto minimalismo californiano, i ciclopici interventi ambientali di James Turrell, l’ossessiva mitologia “celtica” di Matthew Barney. Insomma, la versione più aggiornata e non meno confusa del trascendentalismo e del panteismo americani, come già si vedeva in tanta, forse troppa, e nemmeno troppo gradevole pittura di paesaggio ottocentesca. Certo è pur vero che molte questioni si possono comprendere nel passaggio dalla pittura dei protestanti americani all’astrazione dei pittori ebrei (Gottlieb, Newman, Rothko). Ma restano anche “esperienze”, come nel saggio di Taylor, a vario titolo rubricate come “spirituali” senza che dell’aggettivo si misuri la congruenza, l’estensione della portata, la difficoltà stessa dei suoi assunti. Per tacere della beatificazione di personaggi come Joseph Beuys, la cui furba mescolanza di sciamanesimo, alchimia e antroposofia in tempi passati è servita, soprattutto, a trasformare un ex-aviatore nazista in prodigio del mondo dell’arte. In realtà, il rapporto tra arte, liturgia e sacralità è faccenda ben più seria e che pone questioni serie: la rimozione dell’arte sacra contemporanea da buona parte dei manuali di storia dell’arte, il rapporto fra qualità e industria dei manufatti, fino alla questione più importante di tutte, e cioè quella delle committenze. Fa piacere che possano soccorrere, in tempi recenti, alcune pubblicazioni.
Questa almeno l’impressione che offrono alcuni recenti titoli internazionali, come il libro di Aaron Rosen Art+Religion in the 21st Century. Un volume desideroso sin dal titolo di occhieggiare ai millennials e di solleticare, perlopiù, le versioni soft e light di religioni fai-da-te, politicamente corrette e consumisticamente ben posizionate: stili di vita tra il vegano e il macrobiotico, tra lo psichedelico californiano e l’animistico caraibico, prontamente convertibili in oggetti destinati alle gallerie di Manhattan o ad Art Basel. Dove cioè la spinosa questione del sacro è affrontata nel modo più semplice possibile, cioè, perlopiù, evitandola o diluendola in una retorica new age politicamente correttissima. Un tale canone di artisti, peraltro indistinguibile da quello mercantile delle top galleries internazionali, suscita non poche perplessità. È perfino troppo semplice osservare che l’arte religiosa si è convertita, e da tempo ormai – lasciando da parte Hegel – in religione dell’arte, a sottofondo mistico-contemplativo: il rarefatto minimalismo californiano, i ciclopici interventi ambientali di James Turrell, l’ossessiva mitologia “celtica” di Matthew Barney. Insomma, la versione più aggiornata e non meno confusa del trascendentalismo e del panteismo americani, come già si vedeva in tanta, forse troppa, e nemmeno troppo gradevole pittura di paesaggio ottocentesca. Certo è pur vero che molte questioni si possono comprendere nel passaggio dalla pittura dei protestanti americani all’astrazione dei pittori ebrei (Gottlieb, Newman, Rothko). Ma restano anche “esperienze”, come nel saggio di Taylor, a vario titolo rubricate come “spirituali” senza che dell’aggettivo si misuri la congruenza, l’estensione della portata, la difficoltà stessa dei suoi assunti. Per tacere della beatificazione di personaggi come Joseph Beuys, la cui furba mescolanza di sciamanesimo, alchimia e antroposofia in tempi passati è servita, soprattutto, a trasformare un ex-aviatore nazista in prodigio del mondo dell’arte. In realtà, il rapporto tra arte, liturgia e sacralità è faccenda ben più seria e che pone questioni serie: la rimozione dell’arte sacra contemporanea da buona parte dei manuali di storia dell’arte, il rapporto fra qualità e industria dei manufatti, fino alla questione più importante di tutte, e cioè quella delle committenze. Fa piacere che possano soccorrere, in tempi recenti, alcune pubblicazioni.
I limiti dell’edilizia liturgica postconciliare
 Il libro di Marco Sammicheli inizia ricordando che non sono mai state costruite così tante chiese in Italia come negli ultimi cinquant’anni. Centotrentacinque solo a Milano. Fu l’effetto concorrente dell’espansione delle periferie urbane e della riforma liturgica del Concilio vaticano II. Non poche fra queste chiese appaiono come dei pandori in cemento armato. Irriducibili a uno stile, indistinguibili per le loro funzioni (niente navate, absidi, cappelle riconoscibili come tali), si presentano come “spazi” che ambiscono a essere comunicativi (e comunicativi del sacro), ma che non di rado oscillano tra la palestra e il ricreatorio, tra il garage e il magazzino, con tabernacoli in monoblocco minimalista e confessionali che ricordano il vespasiano. Il tratto comune e condivisibile delle chiese-fabbrica postbelliche parrebbe essere, quando c’è, l’attiguo campetto di calcio. Lì, almeno, le regole sono abbastanza precise. In tutti gli altri casi prevale la confusione stilistica di un’edilizia liturgica che ha provato frettolosamente ad adeguarsi allo spirito postconciliare. Senza peraltro che questo spirito si fosse dotato di indicazioni concrete. Come capita spesso, insomma, una riforma senza sufficienti attuazioni. Sono mancati, ammette Sammicheli, il Borromeo e il Paleotti contemporanei: cioè una classe prelatizia in grado di far seguire alle intenzioni dei proclami la realtà dei fatti, facendo convergere l’autentica testimonianza spirituale con l’impegno culturale. Né l’anarchia ruspante delle parrocchie, né lo zelo di preti operai che tiravano su capannoni di putrelle cementizie, né il divismo di alcuni parroci hanno compensato la mancanza di un’effettiva guida spirituale e artistica a un tempo. Restano ovviamente episodi di grande rilievo, ascrivibili a partire da quei sommi (Gio Ponti, Figini e Pollini, Carlo Scarpa) che hanno saputo coniugare le rinnovate esigenze degli spazi liturgici con il vocabolario contemporaneo. Senza tuttavia ricusare le forme della tradizione, rivisitate di volta in volta in soluzioni vernacolari e moderne a un tempo. Oppure attingendo con libertà e intelligenza al lessico del passato, dal romanico padano al bizantino veneziano. Con risultati più sobri, eloquenti e funzionali dei più recenti esiti di certe archistar (e basterebbe, per questo, il referto di quanto edificato in occasione del Giubileo del millennio).
Il libro di Marco Sammicheli inizia ricordando che non sono mai state costruite così tante chiese in Italia come negli ultimi cinquant’anni. Centotrentacinque solo a Milano. Fu l’effetto concorrente dell’espansione delle periferie urbane e della riforma liturgica del Concilio vaticano II. Non poche fra queste chiese appaiono come dei pandori in cemento armato. Irriducibili a uno stile, indistinguibili per le loro funzioni (niente navate, absidi, cappelle riconoscibili come tali), si presentano come “spazi” che ambiscono a essere comunicativi (e comunicativi del sacro), ma che non di rado oscillano tra la palestra e il ricreatorio, tra il garage e il magazzino, con tabernacoli in monoblocco minimalista e confessionali che ricordano il vespasiano. Il tratto comune e condivisibile delle chiese-fabbrica postbelliche parrebbe essere, quando c’è, l’attiguo campetto di calcio. Lì, almeno, le regole sono abbastanza precise. In tutti gli altri casi prevale la confusione stilistica di un’edilizia liturgica che ha provato frettolosamente ad adeguarsi allo spirito postconciliare. Senza peraltro che questo spirito si fosse dotato di indicazioni concrete. Come capita spesso, insomma, una riforma senza sufficienti attuazioni. Sono mancati, ammette Sammicheli, il Borromeo e il Paleotti contemporanei: cioè una classe prelatizia in grado di far seguire alle intenzioni dei proclami la realtà dei fatti, facendo convergere l’autentica testimonianza spirituale con l’impegno culturale. Né l’anarchia ruspante delle parrocchie, né lo zelo di preti operai che tiravano su capannoni di putrelle cementizie, né il divismo di alcuni parroci hanno compensato la mancanza di un’effettiva guida spirituale e artistica a un tempo. Restano ovviamente episodi di grande rilievo, ascrivibili a partire da quei sommi (Gio Ponti, Figini e Pollini, Carlo Scarpa) che hanno saputo coniugare le rinnovate esigenze degli spazi liturgici con il vocabolario contemporaneo. Senza tuttavia ricusare le forme della tradizione, rivisitate di volta in volta in soluzioni vernacolari e moderne a un tempo. Oppure attingendo con libertà e intelligenza al lessico del passato, dal romanico padano al bizantino veneziano. Con risultati più sobri, eloquenti e funzionali dei più recenti esiti di certe archistar (e basterebbe, per questo, il referto di quanto edificato in occasione del Giubileo del millennio).
Le eccezioni storicamente furono poche: la Milano del cardinale Montini fu la più luminosa: un “deserto terribilmente materialista” da cui si vollero far sbocciare chiese come “fiori di spiritualità”. Una comunità che già per il concorso della quinta porta del Duomo (1950) era stata capace di chiamare, a fianco di scultori più tradizionali come Manzù, Marini e Messina anche Lucio Fontana. Dimostrando così che una strenua ricerca formale non era in alcun modo incompatibile con le esigenze di spiritualità. E facendo anche capire, en passant, come per ogni grande artista il dialogo con il divino non esigeva necessariamente una restaurazione della cristianità ierocratica del medio evo, o la ripetizione pressoché seriale di iconografie stinte. Implicava piuttosto la ricerca di un punto di equilibrio tra invenzione formale, governo delle tecniche e delle materie, libertà creativa e ricerca di trascendenza. Ma tutte queste, in fin dei conti, furono eccezioni, un po’ come lo furono Le Corbusier a Ronchamp o a La Tourette, Matisse a Vence, o anche solo Jean Bazaine per le vetrate parigine di Saint-Séverin o, per venire a tempi più recenti, Gerhard Richter per quelle di Colonia. In realtà, ciò che è storicamente in atto è il divorzio tra arte e fede. E per comprendere qualcosa di questo importante fenomeno, credenti e non credenti (anzi, direi, soprattutto questi ultimi, e soprattutto quando continuano a credere a un po’ troppe cose), è bene rivolgersi a libri seri.
Ricucire il rapporto tra arte e spazio liturgico
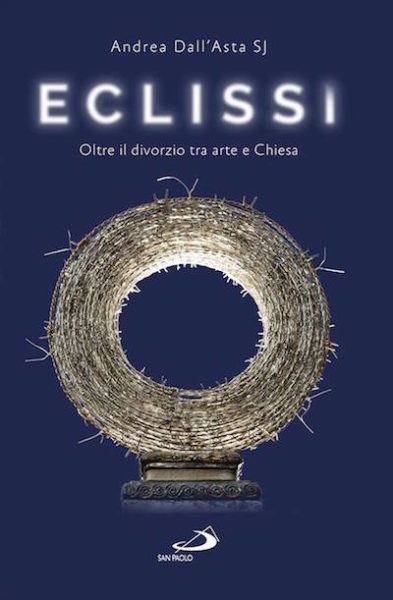 Quello di Andrea Dall’Asta è il più intelligente che io abbia letto su questi argomenti, per tre buoni motivi: l’autore è un gesuita con pregressi studi di architettura, ed è in grado di misurarsi alla pari con i temi dell’estetica quanto con quelli della liturgia; secondo, sa che cosa è il mondo dell’arte, avendo diretto la Galleria san Fedele e organizzato il padiglionClaudioe del Vaticano per la Biennale di Venezia; terzo, scrive quello che pensa (una rarità, almeno nel campo della critica d’arte, in altri non saprei) e non fa sconti a nessuno. Al punto di fare i nomi e i cognomi degli artisti che hanno riempito le chiese della nazione di una “svenevole immagine di cartapesta” pretesa raffigurazione di modernità, ma senza una reale misura della sua complessità e delle sue contraddizioni. Una produzione artistica, fa capire l’autore senza alcuna reticenza, che si appoggia su pochi nomi protetti da circuiti di committenze rigidamente controllate, poco informate e chiuse alle novità, impaniate in uno spaventoso quanto disinvolto eclettismo stilistico.
Quello di Andrea Dall’Asta è il più intelligente che io abbia letto su questi argomenti, per tre buoni motivi: l’autore è un gesuita con pregressi studi di architettura, ed è in grado di misurarsi alla pari con i temi dell’estetica quanto con quelli della liturgia; secondo, sa che cosa è il mondo dell’arte, avendo diretto la Galleria san Fedele e organizzato il padiglionClaudioe del Vaticano per la Biennale di Venezia; terzo, scrive quello che pensa (una rarità, almeno nel campo della critica d’arte, in altri non saprei) e non fa sconti a nessuno. Al punto di fare i nomi e i cognomi degli artisti che hanno riempito le chiese della nazione di una “svenevole immagine di cartapesta” pretesa raffigurazione di modernità, ma senza una reale misura della sua complessità e delle sue contraddizioni. Una produzione artistica, fa capire l’autore senza alcuna reticenza, che si appoggia su pochi nomi protetti da circuiti di committenze rigidamente controllate, poco informate e chiuse alle novità, impaniate in uno spaventoso quanto disinvolto eclettismo stilistico.
L’elenco è spietato. Un chiassoso neobizantinismo che procede per metri quadri di mosaici rutilanti. Un compunto primitivismo umbro-toscano che pare esaurire, nelle sue tonalità esangui, tutto il misticismo possibile. Oppure, ancora, uno sfrontato neomichelangiolismo che sfocia in un imbarazzante groviglio di corpi, tra Pierre e Gilles e Tom of Finland (quest’ultimo termine di paragone, per chiarezza, è mio). Così ad esempio si scrive delle pitture di Oleg Supereko nella cattedrale di Noto: “occasione per ostentare nerboruti e accattivanti nudi maschili, usciti da qualche palestra trendy ed esclusiva”. E ancora, per recenti dipinti in una chiesa all’Aquila: “Kitsch, pessimo gusto, chiari riferimenti alla sfera sessuale, morbosità voluttuosa, carattere estenuato e artificiale di volti languidi ed esangui, tutto concorre a creare l’atmosfera irreale di una discoteca che voglia rimandare a mondi antichi decadenti in uno stile un po’ porno”. Quando si dice parlare chiaro.
Come se ne può uscire? Con i buoni esempi, innanzitutto. I lavori di Claudio Parmiggiani, Jannis Kounellis e Mimmo Paladino per la chiesa di San Fedele; l’Evangeliario Ambrosiano di Nicola De Maria; e poi molte cose ormai storicizzate: la Salle du Départ di Ettore Spalletti (uno spazio laico, certo: ma di maggiore sacralità di tante chiese e sagrestie), la cappella sul monte Tamaro di Mario Botta, con le pitture di Enzo Cucchi, eccetera.
Prendiamo questi esempi per quello che sono (buone pratiche, come si usa dire) e per quello che possono insegnare. Cioè il rapporto infrangibile tra l’opera d’arte e lo spazio concreto della sua esperienza; il valore dell’opera non come rappresentazione, ma come ri-presentazione del non visibile. Di quanto cioè, nonostante tutto, abbiamo ancora voglia di accettare come mistero. Soprattutto in tempi in cui il lettore del “Sole 24 Ore” apprende che il responsabile del progetto di digitalizzazione di Google Art&Culture (“Indiano, 42 anni, cosmopolita”) assicura di voler “annullare la distanza tra percezione e consumo della cultura”. Mi ci vuole molto meno, per aver voglia di andare a studiare dai gesuiti.
alessandro.delpuppo@uniud.it
A Del Puppo insegna storia dell’arte contemporanea all’Università di Udine
I libri
Andrea Dall’Asta, Eclissi. Oltre il divorzio tra arte e Chiesa, San Paolo, 2016
Marco Sammicheli, Disegnare il sacro, Rubbettino, 2016
Manzù. Dialoghi sulla spiritualità, con Lucio Fontana, a cura di Barbara Cinelli e Davide Colombo, Electa, 2016
Aaron Rosen, Art+Religion in the 21st Century, Thames and Hudson, 2015
Mark C. Taylor, Refiguring the Spiritual. Beuys, Barney, Turrell, Goldsworthy. Religion, Culture, and Public Life, Columbia University Press, 2012


