Che cosa hai portato al mondo?
recensione di Luigi Marfè
dal numero di maggio 2017
Franco Moretti
IL BORGHESE
Tra storia e letteratura
ed. orig. 2013, trad. dall’inglese di Giovanna Scocchera
pp. 200, € 24
Einaudi Torino 2017
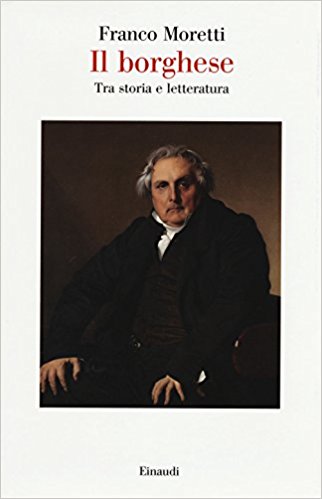 “L’odio del Borghese è l’inizio della virtù”, scriveva Flaubert a George Sand nel 1867. E dopo di lui, per più di un secolo, la borghesia è stato l’idolo polemico di un lungo dibattito storico e politico. Da qualche tempo, tuttavia, non suscita più molto interesse: in una società in cui le tradizionali opposizioni di classe appaiono come svuotate, anche la cultura borghese sembra aver lasciato pochi ricordi di sé. Per questo Franco Moretti presenta questo suo ultimo libro – Il borghese, uscito in inglese nel 2013 e ora proposto da Einaudi nella traduzione di Giovanna Scocchera – come un’opera di “ingegneria inversa” che nella letteratura cerca tracce di ciò che non esiste più: il saggio, come sostiene l’autore, è una sorta di catabasi, un itinerario in “un regno di ombre, dove il passato riacquista la sua voce e continua a parlarci”.
“L’odio del Borghese è l’inizio della virtù”, scriveva Flaubert a George Sand nel 1867. E dopo di lui, per più di un secolo, la borghesia è stato l’idolo polemico di un lungo dibattito storico e politico. Da qualche tempo, tuttavia, non suscita più molto interesse: in una società in cui le tradizionali opposizioni di classe appaiono come svuotate, anche la cultura borghese sembra aver lasciato pochi ricordi di sé. Per questo Franco Moretti presenta questo suo ultimo libro – Il borghese, uscito in inglese nel 2013 e ora proposto da Einaudi nella traduzione di Giovanna Scocchera – come un’opera di “ingegneria inversa” che nella letteratura cerca tracce di ciò che non esiste più: il saggio, come sostiene l’autore, è una sorta di catabasi, un itinerario in “un regno di ombre, dove il passato riacquista la sua voce e continua a parlarci”.
“Ogni forma d’arte è definita dalla dissonanza metafisica della vita”: come nel Romanzo di formazione (1986) e in Opere mondo (1994), punto di partenza di Moretti è ancora il giovane Lukács di Teoria del romanzo (1920). L’assunto è che la cultura borghese sia segnata da una profonda “dissonanza” tra gli imperativi di giustizia, temperanza e laboriosità e la “struttura di potere” celata dietro tali slanci. Il linguaggio letterario cercherebbe disperatamente di ritrovare un equilibrio – la sua “vocazione più profonda”, scrive Moretti, “sta nel forgiare compromessi tra sistemi ideologici diversi” –, ma inavvertitamente porta allo scoperto questa ambiguità. Il sottotitolo del volume, Tra storia e letteratura, vuole indicare in questo senso sia il metodo di lavoro sia l’obiettivo del saggio. Se le forme letterarie sono come i “fossili” di un passato che un tempo è stato vivo, il loro esame può far luce su dimensioni altrimenti inattingibili. Moretti fa giocare dialetticamente close e distant reading: le spie stilistiche sono nel suo saggio paradigmi indiziari, rivelatori di fenomeni generali. La scommessa del libro è quella di provare che lo studio della lingua letteraria possa avere il significato di una ricerca sociale, e che proprio in questo stia “il suo possibile contributo alla conoscenza storica”. Del resto, già nelle Conjectures on World Literature (2000) si osservava come nelle forme letterarie si condensassero tracce di strutture sociali; nell’analisi linguistica, sarebbe possibile verificare le variazioni più impercettibili che segnano continuità e discontinuità nell’immaginario di un’epoca. Il linguaggio, secondo la lezione di Reinhart Koselleck e di Raymond Williams, non è soltanto un modo di rappresentare la realtà, ma un vero e proprio fattore di cambiamento, “strumento”, nelle parole di Émile Benveniste citate da Moretti, “per dare un assetto al mondo e alla società”.
Le zone d’ombra della cultura borghese
Da questa dialettica di lontano e vicino deriva la struttura del libro, suddiviso in cinque capitoli che seguono un percorso storico, e sono inframezzati dallo studio di alcune parole chiave della cultura borghese: “utile”, “efficienza”, “comfort”, “serio”, “influenza”, “roba”. Dopo un’introduzione sul metodo di indagine impiegato, il libro prende le mosse dal Robinson Crusoe (1719) di Defoe, in cui Moretti vede la prima rappresentazione del passaggio weberiano dall’“avventuriero capitalistico” al “padrone lavoratore”. Nel secondo capitolo, rielaborazione di un saggio sul “secolo serio” già pubblicato nel primo volume di Il romanzo (2001), sono prese in esame le strategie retoriche con cui di alcuni romanzi inglesi e francesi producono il proprio “effetto di realtà”, intercalando il racconto con dei “riempitivi”, vale a dire episodi narrativi di poco conto, che non avrebbero altro scopo che produrre il “ritmo di continuità” essenziale alla rappresentazione della quotidianità borghese. A questo punto, il saggio si addentra nelle zone d’ombra della cultura borghese, che rifiuta sistematicamente di autoriconoscersi come tale; l’indagine di un vasto corpus di romanzi ottocenteschi mostra come le attestazioni del termine “borghese” siano per quasi tutto l’Ottocento sporadiche, ben più rare di definizioni come “ricco”, “agiato”, “benestante”, quasi per distogliere sottilmente il lettore da ogni possibile giudizio. Il discorso si sposta quindi verso testi e zone geografiche ai margini della seconda rivoluzione industriale – il Brasile di Memorie dall’aldilà (1881) di Machado de Assis, la Sicilia di Mastro-don Gesualdo (1889) di Verga, la Polonia di La bambola (1890) di Prus, la Spagna della tetralogia di Torquemada (1889-96) di Pérez Galdós –, laddove l’arrivo del progresso in contesti ancora preborghesi esaspera le contraddizioni. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato al teatro di Ibsen, grazie al quale la cultura borghese farebbe finalmente i conti con il suo essere anche “struttura di potere”: “Ibsen è l’unico scrittore che guarda il borghese in faccia e gli chiede: Allora, dopotutto, che cosa hai portato al mondo?”
“Le minutiae della lingua rivelano segreti che le grandi idee spesso mascherano: l’attrito tra nuove aspirazioni e vecchie abitudini, le false partenze, le esitazioni, i compromessi”, scrive Moretti. Il suo saggio esamina le tracce letterarie della cultura borghese e delle sue ambiguità, alternando osservazioni linguistiche sottili – per fare appena qualche esempio: l’uso dei tempi verbali in Defoe; le storia delle trasformazioni semantiche di parole come “industria”; la connotazione morale che assumono coppie di parole formate da un sostantivo concreto e un aggettivo astratto –, con analisi statistiche e riflessioni sul dibattito storiografico e sociologico sulla figura del borghese. Il vero protagonista del saggio, tuttavia, è la prosa, in quanto “ritmo della continuità”: “La prosa come lo stile borghese per eccellenza, nel suo senso più ampio; un modo per stare al mondo, non solo un modo per rappresentarlo”. In Illusioni perdute (1839) di Balzac, c’è un passo in cui il giornale per cui sta per scrivere il protagonista si trova a corto di argomenti e occorre buttare giù un articolo in fretta e furia.
Queste “parole scritte per colmare uno spazio vuoto” sono immagine metaletteraria dell’espediente retorico del “riempitivo”: come l’articolo, molti episodi dei romanzi ottocenteschi non avrebbero una funzione strutturale all’interno delle rispettive trame, essendo piuttosto un discorso sul tempo. Come aveva già osservato Auerbach a proposito di Madame Bovary (1857), ci sono scene in cui “non accade nulla di straordinario. È un momento qualsiasi di un’ora che ritorna regolarmente. Non accade nulla, ma il nulla è diventato qualche cosa di pesante, di oscuro, di minaccioso”.
Fog, (nebbia), è la metafora che dà il titolo al capitolo sulle zone d’ombra della cultura borghese. Tra i romanzi che meglio descrivono la dissonanza borghese, c’è senz’altro Cuore di tenebra (1899) di Conrad. Quando all’inizio, sul Tamigi, rievoca il suo viaggio africano, Marlow osserva che la verità di un racconto è come l’alone soffuso di nebbia rivelato dalla luna. In risposta alla domanda di Ibsen alla borghesia – “che cosa hai portato al mondo?” – il romanzo offre una storia incontrovertibile: tra le imprese più redditizie del capitalismo fin-de-siècle c’era quanto di più abietto si potesse pensare. Eppure, una volta tornato a casa, Marlow, nel salotto borghese della fidanzata di Kurtz – le finestre alte, il camino, il pianoforte a coda –, non sa più ripetere ciò che ha visto: “La verità profonda rimane nascosta – per fortuna, per fortuna”.
luigi.marfe@unito.it
L Marfè è dottore di ricerca in letterature comparate e traduttore
Sul saggio Il borghese hanno scritto sul numero di maggio 2017 anche Mariolina Bertini, Francesco de Cristofaro e Paolo Tripodi.


