Tra davidie, tarassachi e malvoni
di Luca Terzolo
dal numero di luglio-agosto 2016
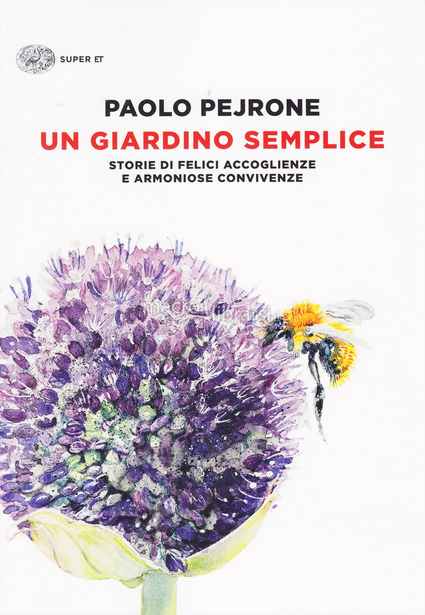 Paolo Pejrone, nel suo nuovo libro intitolato Un giardino semplice, impreziosito dalle splendide tavole di Anna Regge (penalizzate dalla sconsiderata impaginazione), va precisando con la consueta nonchalance una sua estetica, che è anche etica, del giardinaggio. O meglio del vivere nel e per il giardino. Nulla di strutturalmente sistematico e di dogmatico ma tanti tasselli accostati quasi casualmente che vanno a comporre un discorso molto ben leggibile. La classica e in fondo banale organizzazione per stagioni non riesce infatti a dissimulare come alcuni temi ricorrano costanti: la raffinatezza e l’esotismo (la Magnolia delavayi, la Davidia involucrata sulla quale torneremo più avanti) devono poter coesistere con la semplicità e la tradizione (il malvone, le giuseppine, le monete del papa, i mughetti…). Pejrone in sostanza caldeggia un giardino “fusion” (siamo sicuri che il termine gli farebbe orrore), lontano da omologazioni internazionali, non fondato sull’apartheid ma sull’armoniosa convivenza. Un esempio illuminante è nella sua definizione del prato vivo: “Un prato con trifogli, margheritine, tarassachi, ecc. è un prato all’italiana: sopporta il secco, è robusto alle malattie e, a mio giudizio, ha pure un’aria casuale, decisamente gradevole, casereccia e nostrana”. Anche l’infestante tarassaco vi è accettato.
Paolo Pejrone, nel suo nuovo libro intitolato Un giardino semplice, impreziosito dalle splendide tavole di Anna Regge (penalizzate dalla sconsiderata impaginazione), va precisando con la consueta nonchalance una sua estetica, che è anche etica, del giardinaggio. O meglio del vivere nel e per il giardino. Nulla di strutturalmente sistematico e di dogmatico ma tanti tasselli accostati quasi casualmente che vanno a comporre un discorso molto ben leggibile. La classica e in fondo banale organizzazione per stagioni non riesce infatti a dissimulare come alcuni temi ricorrano costanti: la raffinatezza e l’esotismo (la Magnolia delavayi, la Davidia involucrata sulla quale torneremo più avanti) devono poter coesistere con la semplicità e la tradizione (il malvone, le giuseppine, le monete del papa, i mughetti…). Pejrone in sostanza caldeggia un giardino “fusion” (siamo sicuri che il termine gli farebbe orrore), lontano da omologazioni internazionali, non fondato sull’apartheid ma sull’armoniosa convivenza. Un esempio illuminante è nella sua definizione del prato vivo: “Un prato con trifogli, margheritine, tarassachi, ecc. è un prato all’italiana: sopporta il secco, è robusto alle malattie e, a mio giudizio, ha pure un’aria casuale, decisamente gradevole, casereccia e nostrana”. Anche l’infestante tarassaco vi è accettato.
 Bene ha fatto la Elliot a stupirci ripubblicando due celebri libri di Gertrude Jekyll: Il giardino dei colori e Bambini e giardini. È a quest’ultimo che ci dedicheremo: lo merita per un approccio pedagogico assai libertario per l’epoca in cui è stato scritto. L’autrice (1843-1932), mitica esperta di giardinaggio citata con altissimo rispetto da Pejrone e da chiunque scriva seriamente di giardini, vera e propria autrice di centinaia di parchi e giardini, nata in una famiglia altolocata (Stevenson era un amico di famiglia: pare che il nome del celebre dottor Jekyll venga di qui…) ha scritto un libro in cui parla ai bambini invitandoli all’osservazione naturalistica (geniale il capitolo in cui propone una sorta di leggibilissima tassonomia botanica semplificata) e al giardinaggio giocoso ma serio. Interessante e divertente notare come alla pedagogia d’avanguardia (via calze e scarpe e tutti a sguazzare nello stagno; bellissima e commuovente una delle fotografie dell’autrice che costellano il testo: una panchetta di legno su cui sono orgogliosamente buttate calze e scarpe) faccia da controcanto una assoluta e feroce ottocentesca rigidità nei confronti delle erbacce infestanti del prato. Per la Jekyll per esempio il tarassaco è un nemico e va estirpato senza pietà: “Se non riuscite a estrarre la radice del tarassaco dovrete grattare via un po’ di terra (…) e tagliare la radice più in profondità possibile con la lama del coltello”.
Bene ha fatto la Elliot a stupirci ripubblicando due celebri libri di Gertrude Jekyll: Il giardino dei colori e Bambini e giardini. È a quest’ultimo che ci dedicheremo: lo merita per un approccio pedagogico assai libertario per l’epoca in cui è stato scritto. L’autrice (1843-1932), mitica esperta di giardinaggio citata con altissimo rispetto da Pejrone e da chiunque scriva seriamente di giardini, vera e propria autrice di centinaia di parchi e giardini, nata in una famiglia altolocata (Stevenson era un amico di famiglia: pare che il nome del celebre dottor Jekyll venga di qui…) ha scritto un libro in cui parla ai bambini invitandoli all’osservazione naturalistica (geniale il capitolo in cui propone una sorta di leggibilissima tassonomia botanica semplificata) e al giardinaggio giocoso ma serio. Interessante e divertente notare come alla pedagogia d’avanguardia (via calze e scarpe e tutti a sguazzare nello stagno; bellissima e commuovente una delle fotografie dell’autrice che costellano il testo: una panchetta di legno su cui sono orgogliosamente buttate calze e scarpe) faccia da controcanto una assoluta e feroce ottocentesca rigidità nei confronti delle erbacce infestanti del prato. Per la Jekyll per esempio il tarassaco è un nemico e va estirpato senza pietà: “Se non riuscite a estrarre la radice del tarassaco dovrete grattare via un po’ di terra (…) e tagliare la radice più in profondità possibile con la lama del coltello”.
 Non è lecito sapere se nei prati dei giardini all’inglese amati da Rousseau e da George Sand fossero presenti molte infestanti. Évelyne Bloch-Dano nel suo Giardini di carta (bel titolo, con sottotitolo Da Rousseau a Modiano) ci dice molto, forse troppo, sul rapporto dei letterati francesi coi giardini, ma ovviamente non questo. E non si può nemmeno imputarglielo a colpa. Non questo. Il suo libro è ben scritto, abbastanza ben documentato, ma alla lettura dà una sensazione di futilità. In totale franchezza: leggere che Simone de Beauvoir amava il parco del nonno nel Limousin (“Cedri, wellingtonie, faggi violacei, alberi nani del Giappone, salici piangenti, araucarie”) mentre per Sartre l’unica natura accettabile era quella dei Giardini del Luxembourg fa sbottare in un franco e sonoro “Chissenefrega”. Forse non è un caso ma un segno di totale assenza di ironia, il fatto che Flaubert venga citato con Madame Bovary nel capitolo intitolato L’amore in giardino e mai con Bouvard et Pécuchet che sul mito tutto urbano dei giardini e degli orti molto avrebbero ancora da dire e insegnare.
Non è lecito sapere se nei prati dei giardini all’inglese amati da Rousseau e da George Sand fossero presenti molte infestanti. Évelyne Bloch-Dano nel suo Giardini di carta (bel titolo, con sottotitolo Da Rousseau a Modiano) ci dice molto, forse troppo, sul rapporto dei letterati francesi coi giardini, ma ovviamente non questo. E non si può nemmeno imputarglielo a colpa. Non questo. Il suo libro è ben scritto, abbastanza ben documentato, ma alla lettura dà una sensazione di futilità. In totale franchezza: leggere che Simone de Beauvoir amava il parco del nonno nel Limousin (“Cedri, wellingtonie, faggi violacei, alberi nani del Giappone, salici piangenti, araucarie”) mentre per Sartre l’unica natura accettabile era quella dei Giardini del Luxembourg fa sbottare in un franco e sonoro “Chissenefrega”. Forse non è un caso ma un segno di totale assenza di ironia, il fatto che Flaubert venga citato con Madame Bovary nel capitolo intitolato L’amore in giardino e mai con Bouvard et Pécuchet che sul mito tutto urbano dei giardini e degli orti molto avrebbero ancora da dire e insegnare.
Quello che è certo è che sul tema dei praticelli e della loro manutenzione il meglio lo dice Michael Pollan in Una seconda natura. Lo dice applicando ovviamente la sua analisi al contesto americano, ma considerata la potentissima influenza visiva (si pensi anche solo a Paperino alle prese con la falciatrice) del colonialismo culturale statunitense, il discorso assume un valore quasi universale; certo molto più ampio di un qualunque approccio strettamente antropologico-culturale.
 Pollan scrive: “Il manto erboso ha un grande fascino, soprattutto per gli americani. Ha un’aria più o meno naturale – è verde; cresce – ma di fatto rappresenta un assoggettamento totale e completo della foresta, alla pari di un parcheggio. Tutte le specie ne sono escluse a viva forza: tutte tranne una, e anche a questa è vietato diventare più lunga del dito mignolo del proprietario. Questa è la natura sotto un regime totalitario”. Pollan poi racconta esilaranti aneddoti su proprietari trascurati redarguiti dai vicini (“Siete pregati di falciare il prato” scritto su un biglietto). O addirittura su vicini che intervengono di persona con la falciatrice (il reprobo si vide costretto a piantare un cartello che diceva: “Questo prato non è un esempio di indolenza. È un prato naturale che cresce nel modo inteso da Dio”). Esilarante. L’approccio di Pollan, sempre molto leggero e spiritoso anche quando tocca temi che non sarebbe fuori luogo considerare filosofici (e il richiamo a Thoreau ne è un segno), dà un’ottima prova quando tocca il tema dell’inverno. È quasi una tradizione per i libri sul giardinaggio articolarsi seguendo il fluire delle stagioni (così anche il libro di Pejrone). Pollan invece di diffondersi sulle rare e preziose fioriture invernali o sui lavori tipici dei mesi freddi (manutenzione degli attrezzi ecc.) descrive con grande realismo e acume la principale attività invernale del giardiniere dilettante: la lettura dei cataloghi di florovivaistica. E il successivo inevitabile acquisto di piante da mettere a dimora nella primavera veniente. Il titolo del capitolo non a caso è “Perdere la testa per i pretenziosi cataloghi”. Forse è un po’ troppo aderente alla sola realtà americana, l’analisi minuziosa del diverso stile dei cataloghi presi in esame, da quello estremamente snob a quello più concreto, ma è facilmente traducibile in analoghe italianissime tipologie.
Pollan scrive: “Il manto erboso ha un grande fascino, soprattutto per gli americani. Ha un’aria più o meno naturale – è verde; cresce – ma di fatto rappresenta un assoggettamento totale e completo della foresta, alla pari di un parcheggio. Tutte le specie ne sono escluse a viva forza: tutte tranne una, e anche a questa è vietato diventare più lunga del dito mignolo del proprietario. Questa è la natura sotto un regime totalitario”. Pollan poi racconta esilaranti aneddoti su proprietari trascurati redarguiti dai vicini (“Siete pregati di falciare il prato” scritto su un biglietto). O addirittura su vicini che intervengono di persona con la falciatrice (il reprobo si vide costretto a piantare un cartello che diceva: “Questo prato non è un esempio di indolenza. È un prato naturale che cresce nel modo inteso da Dio”). Esilarante. L’approccio di Pollan, sempre molto leggero e spiritoso anche quando tocca temi che non sarebbe fuori luogo considerare filosofici (e il richiamo a Thoreau ne è un segno), dà un’ottima prova quando tocca il tema dell’inverno. È quasi una tradizione per i libri sul giardinaggio articolarsi seguendo il fluire delle stagioni (così anche il libro di Pejrone). Pollan invece di diffondersi sulle rare e preziose fioriture invernali o sui lavori tipici dei mesi freddi (manutenzione degli attrezzi ecc.) descrive con grande realismo e acume la principale attività invernale del giardiniere dilettante: la lettura dei cataloghi di florovivaistica. E il successivo inevitabile acquisto di piante da mettere a dimora nella primavera veniente. Il titolo del capitolo non a caso è “Perdere la testa per i pretenziosi cataloghi”. Forse è un po’ troppo aderente alla sola realtà americana, l’analisi minuziosa del diverso stile dei cataloghi presi in esame, da quello estremamente snob a quello più concreto, ma è facilmente traducibile in analoghe italianissime tipologie.
 D’altra parte, a dimostrazione che anche nel mondo del giardinaggio la globalizzazione è esistita da sempre (da ben prima che esistesse la parola), basta aprire I cacciatori di piante di Michael Tyler Whittle, un libro formidabile, che DeriveApprodi molto opportunamente ripesca dalla collana Rizzoli diretta negli anni settanta dal grande Ippolito Pizzetti. Cronologicamente strutturato inizia raccontando dell’antichità e poi del medioevo e del Rinascimento. Ma il massimo di interesse e di fascino lo raggiunge quando si avvicina al diciottesimo secolo, alla grande epoca del colonialismo (e del collezionismo) inglese. La Royal Horticultural Society, i Kew Gardens, il grandissimo Banks, inesausto organizzatore di spedizioni mirate alla ricerca di piante ancora sconosciute, il geniale e modesto dottor Ward inventore delle omonime cassette (prima attrezzatura atta a portare in Inghilterra piante esotiche riducendone l’altissima mortalità: si ricorda che il famoso ammutinamento del Bounty avvenne su una nave carica di alberi del pane: l’acqua veniva lesinata ai marinai per tenere in vita le piante). Whittle, con quello che si usa definire umorismo inglese, scrive che Ward, un naturalista dilettante, medico di professione, “trattandosi di una persona che si divertiva a studiare i bruchi e a metterli in bottiglia, doveva essere con ogni probabilità scapolo o vedovo”.
D’altra parte, a dimostrazione che anche nel mondo del giardinaggio la globalizzazione è esistita da sempre (da ben prima che esistesse la parola), basta aprire I cacciatori di piante di Michael Tyler Whittle, un libro formidabile, che DeriveApprodi molto opportunamente ripesca dalla collana Rizzoli diretta negli anni settanta dal grande Ippolito Pizzetti. Cronologicamente strutturato inizia raccontando dell’antichità e poi del medioevo e del Rinascimento. Ma il massimo di interesse e di fascino lo raggiunge quando si avvicina al diciottesimo secolo, alla grande epoca del colonialismo (e del collezionismo) inglese. La Royal Horticultural Society, i Kew Gardens, il grandissimo Banks, inesausto organizzatore di spedizioni mirate alla ricerca di piante ancora sconosciute, il geniale e modesto dottor Ward inventore delle omonime cassette (prima attrezzatura atta a portare in Inghilterra piante esotiche riducendone l’altissima mortalità: si ricorda che il famoso ammutinamento del Bounty avvenne su una nave carica di alberi del pane: l’acqua veniva lesinata ai marinai per tenere in vita le piante). Whittle, con quello che si usa definire umorismo inglese, scrive che Ward, un naturalista dilettante, medico di professione, “trattandosi di una persona che si divertiva a studiare i bruchi e a metterli in bottiglia, doveva essere con ogni probabilità scapolo o vedovo”.
Pejrone descrive con amore le sue davidie: la storia dell’arrivo in Occidente del meraviglioso “albero dei fazzoletti” è un’epopea rappresentativa di tante altre che videro all’opera botanici, avventurieri, dilettanti, missionari, affaristi (l’importazione, l’acclimatazione, la riproduzione e la vendita di piante rare ed esotiche – si pensi alle orchidee o ancor prima ai tulipani – era una fiorente industria). Il primo a identificare e a descrivere questo meraviglioso albero fu Armand David (da lui il nome: Davidia involucrata), un missionario francese con una particolare vocazione per gli studi naturalistici. Ma il primo a portarne i semi in Inghilterra fu, anni dopo, Ernest H. Wilson. Rischiò la vita arrampicandosi fra le gole dello Yunnan, fu travolto da torrenti in piena, affrontò pericoli imprevisti (molti di questi avventurosi cercatori non tornarono in patria) ma ce la fece. Da allora le davidie sono anche nostre e campeggiano nei più raffinati giardini. Tra tutti, in quello piemontese di Paolo Pejrone.
Nessuna pretesa di esaustività in questa piccola rassegna. Solo il tentativo un po’ impressionistico di mostrare come si stia sviluppando una sorta di subcategoria merceologica nell’ambito dell’editoria di giardinaggio: quella che evade dalle costrizioni del tecnicismo esasperato per tentare, con risultati quasi sempre più che convincenti, di ibridarsi con altre discipline: dalla ecologia e gastronomia (ed è facile…) alla storia, dalla letteratura alla pedagogia, dalla sociologia alla filosofia.
Il tutto in perfetta e pacifica convivenza con gli svariati ottimi manuali presenti anche in edicola (soprattutto nella bella stagione) o coi lussuosi libri fotografici e le preziose ristampe anastatiche di antichi erbari (ideali come coffee table books).
luca.terzolo@alice.it
L Terzolo è lessicografo


