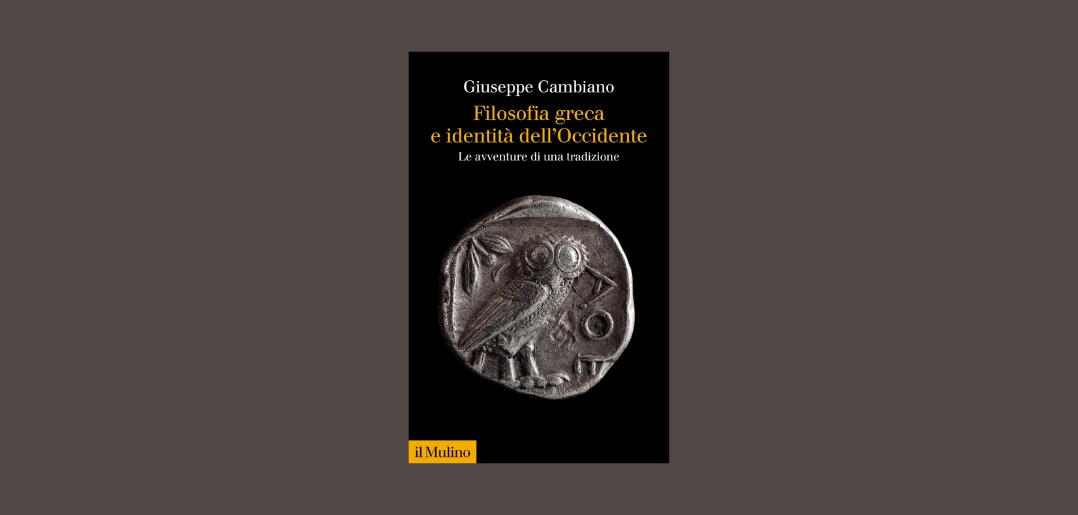Un salutare antidoto culturale
di Luciano Canfora
Giuseppe Cambiano
Filosofia greca e identità dell’Occidente
Le avventure di una tradizione
pp. 800, € 50,
il Mulino, Bologna 2022
Che l’“Occidente” abbia delle “radici” è un discutibile concetto a carattere sommario, che per giunta presuppone che esista l’“Occidente” in quanto tale. Una dimenticata vittima di Auschwitz, Kadmi Cohen, distingueva tra Occidente (l’Europa) e il suo mostruoso “doppione” (gli USA) da lui definito “Occidente estremo”. In momenti di spiccato “lasciarsi andare” retorico si dice – o meglio si diceva – che la Grecia fosse “la culla” dell’Occidente. Si intendeva la Grecia antica. Ma si trascurava la frammentazione di essa in tante realtà particolari: la “culla” sarà stata Atene? O l’intellettualmente poco produttiva Sparta? O l’Elide, o la Tessaglia? O magari la Macedonia con la sua travolgente monarchia militare? Tutte domande imbarazzanti, rispetto alle quali già il mondo romano, almeno al tempo del vecchio Catone, dava una risposta sprezzante, consistente nel considerare un disvalore la realtà greca nel suo insieme. Col tempo la Grecia, o meglio alcune sue città, divennero un giardino esornativo all’interno della compagine ferocemente militarizzata dell’impero romano: un po’ come l’attuale compagine di stati europei nella gabbia dell’impero statunitense. Poi la penisola greca fu a lungo realtà marginale all’interno dell’impero bizantino: con peculiarità “locali” come la Mistrà di Gemisto Pletone. E quando finì sotto il governo turco-ottomano, la “culla” connotò sé stessa essenzialmente in termini religiosi: aggrappata a una “identità” che si identificava con una ortodossia avversa, al tempo stesso, alla chiesa dei “latini” (Roma) e all’Islam. Così finì la “culla”.
Che poi, anche grazie alla ricezione araba del pensiero greco (Platone, Aristotele), le filosofie fiorite tra medioevo, umanesimo e Rinascimento abbiano tratto ispirazione e feconda materia dall’opera di quei due prosatori (cui nel Seicento si affiancò con difficoltà Epicuro) non significa certamente che l’“Occidente” (la monarchia francese? Il Regno Unito? La Spagna di Filippo II?) abbia cavato da quei filosofi la sua “identità”. Ammesso che ne abbia una.
Il recente grande lavoro di Giuseppe Cambiano contribuisce ora, in modo analitico e con molta dottrina, a vanificare quel banale cortocircuito. E lo fa attraverso lo studio approfondito di singole tappe dello sviluppo del pensiero filosofico-scientifico: a partire dall’affermarsi del cristianesimo in area mediterranea e approdando alla svalutazione, da parte di Nietzsche, della figura di Socrate. Abbiamo, in questo volume, una storia della filosofia considerata dal punto di vista del “corpo a corpo” dei pensatori – maggiori e minori – con Platone, Aristotele ed Epicuro. E poiché i pensatori greci di cui abbiamo direttamente o indirettamente nozione hanno riservato particolare attenzione al problema delle “forme di governo” – problema che interferisce in modo immediato con la prassi – ben si comprende come una storia come quella che Cambiano ricostruisce sconfini spesso in analisi storico-politiche concrete. Questo accade, ad esempio, nelle pagine dedicate alla sintonia tra George Grote, banchiere e grande storico dilettante, con John Stuart Mill a proposito della “democrazia ateniese”. Dalle pagine di Cambiano emerge, col rispettoso garbo che gli è caratteristico, come di fatto l’idealizzazione del modello “democratico” ateniese da parte di Grote fosse debitrice della immagine strettamente ideologica di quel modello tratteggiata in un “discorso di apparato” (e dunque intrinsecamente seduttivo) quale il celebrato “epitafio” pericleo rielaborato da Tucidide. Quanto quel discorso fosse – agli occhi di Tucidide – lontano dalla realtà effettuale si evince agevolmente se si considera che lo stesso Tucidide fa dire altrove, al nipote di Pericle, Alcibiade, leader in disgrazia della sua città, che la “democrazia” (ateniese e non solo) è “una pazzia universalmente riconosciuta come tale” (VI, 89, 6). Ma Grote “ritagliava” le fonti in funzione della lotta politica inglese, nella quale egli era schierato contro i tories. E giungeva a tratteggiare una sorta di armonia tra critica socratica e prassi democratica ateniese trascurando di ricordare le parole dell’Apologia in cui Socrate dice, ai giudici popolari che stanno per mandarlo a morte, che, se lui si fosse dedicato alla lotta politica nella sua città, sarebbe già morto da tempo.
Bene Cambiano nota come nell’idealizzazione di quel modello (largamente immaginario) Grote e Mill “addolcissero” il fenomeno molto ingombrante della schiavitù (“la schiavitù, indubbiamente una istituzione odiosa” ma “per certi aspetti migliore di quella americana”). Fenomeno e istituzione che il pensatore forse tra i più influenti, Aristotele, difese e teorizzò senza risparmio. In realtà andrebbe osservato che la posizione moderna armonico-irenica, mirante a lasciare nell’ombra la questione, costituiva un bel passo indietro rispetto alla lucidità con cui esponenti della cultura termidoriana, in primo luogo Costantin-François Volney, avevano declassato a modello negativo le cosiddette “repubbliche antiche” proprio in ragione della “macchia” gigantesca rappresentata dalla condizione delle masse di schiavi. Volney ne parlava con duri toni polemici nelle sue lezioni di storia all’École Normale nell’anno III della Repubblica (1795), e contemporaneamente (o poco prima) ne parlava, con implicita polemica antigiacobina, il poligrafo Agricole Fortia d’Urban nella Vie de Xénophon propiziata da Jean Baptiste Gail, ormai docente al Collège de France.
Questa acuta tradizione termidoriana riemerge, anni dopo (1840), nel II tomo della Démocratie en Amérique di Tocqueville, che felicemente definiva “il popolo ateniese” una aristocrazia piuttosto ampia parassitariamente sorretta da una massa di non-persone, le centinaia di migliaia di schiavi. (Della questione delle cifre demografiche ateniesi, contestate a torto da David Hume, si occupò Cambiano nel volume Polis, un modello per la cultura europea, Laterza, 2000). E sappiamo come la discussione sull’entità e il ruolo della schiavitù greca e romana si sia ravvivata, sempre in funzione della politica vivente, nel Novecento, tra storiografia marxista e neoumanesimo dolcificante alla Joseph Vogt (Sklaverei und Humanität). Ma mette conto soggiungere che l’immagine tocquevilliana ritorna, con ulteriore forza, in Max Weber quando definisce la “democrazia” della città antica “una Gilda che si spartisce il bottino”.
Il modello ateniese (democrazia che si poggia su un grande basamento schiavistico) tornò attuale negli Stati Uniti d’America al tempo della feroce e prolungata guerra civile (1861-1865), il cui risultato fu l’abrogazione, sul piano legale, dell’istituto della schiavitù (istituto che i “padri fondatori” della “democrazia americana” avevano considerato del tutto naturale). I politici, anche di alto livello, e propugnatori sudisti della schiavitù invocarono allora il modello ateniese; ed ebbero anche qualche freccia nell’arco quando controbattevano agli abrogazionisti che la condizione dell’operaio “libero” in fabbrica era all’epoca di gran lunga peggiore rispetto a quella degli schiavi delle piantagioni. Intervennero, allora, nella discussione che accompagnò il conflitto, personalità rilevanti a sostegno della durevolezza e attualità del “modello ateniese” (democrazia schiavistica) come ad esempio John Caldwell Calhoun (su cui vanno viste pagine importanti nel bel volume di Massimo L. Salvadori, L’Europa degli Americani, Laterza, 2005). E sappiamo quanto sia stata, e continui ad essere, ardua la strada che avrebbe dovuto condurre a una effettiva, non ancora pienamente accettata, convivenza razziale in quel paese.
Abbiamo ricordato qui soltanto alcuni dei motivi e dei temi che percorrono questo imponente volume di Cambiano. Esso è un buon antidoto contro le semplificazioni in tema di “radici” e di “Occidente”. Antidoto culturale, fittamente documentato, quanto mai salutare nell’ora presente.