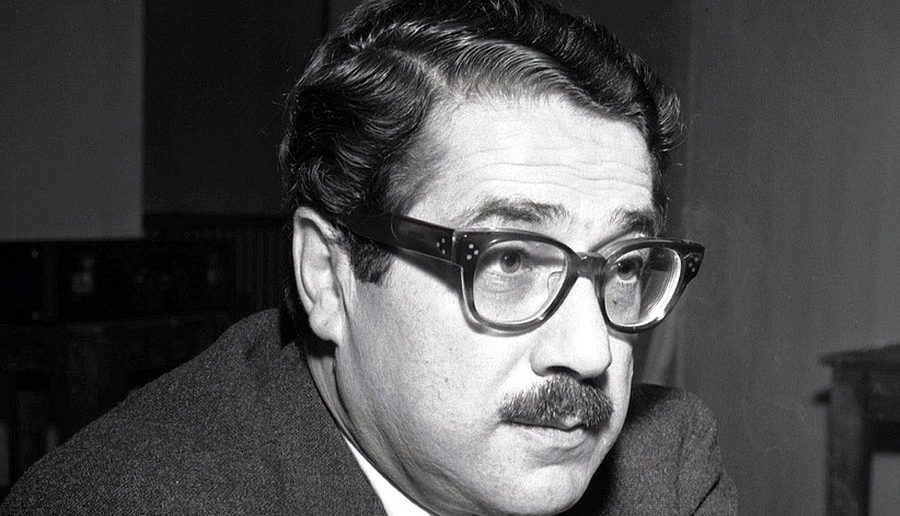Una scrittura giornalistica e giornaliera
di Antonio Castronuovo
“Sono un anarchico senza bombe”, diceva di se stesso Bino Sanmniatelli, delineando con un solo colpo di pennello un’intrigante figura di uomo, ma anche quella di uno spirito libero, scettico e irrequieto. Soltanto se è senza bombe l’anarchico sa guardare con triste garbo alla “civiltà” e diventarne critico affilato. Lo era anche Ennio Flaiano, che in uno dei suoi amari epigrammi, l’Inno per pochi, dichiara di far parte della congrega: “Siamo anarchici a domicilio / bombe scariche fabbrichiamo / spesse volte ci addormentiamo / sul più bello dell’attentato”.
È tutta qui l’essenza del “redattore cupo”, nome che lui stesso si era dato quando, nel 1949, era diventato redattore capo del settimanale “Il Mondo” di Pannunzio; o del “cinghialotto”, come lo chiamava Fellini alludendo a quel suo aspetto da animale irsuto e dalle spalle insaccate: anarchico che scaglia bombe scariche, e che semmai s’addormenta proprio nel momento culminante. Ma ciò non significa che quelle bombe non facciano centro, anche perché sono dotate di aculei: le punte dell’ironia leggera, la più affusolata, la più pungente. Ecco una bomba scarica di Flaiano, tratta dal Taccuino del marziano: “Conoscere se stesso. Dopodiché diventa impossibile vivere insieme con se stesso”.
Ciò non equivale ad affermare che Flaiano fosse un inventore di motti di spirito – come troppo spesso lo descrive una leggenda creatasi attorno a lui – quanto produttore di una scrittura che funziona come contenitore di brani aforistici: la sua non è insomma un’opera fatta di motti e aforismi, ma un’opera aforistica, che è cosa differente. Amatore della forma del diario o della breve commedia, è facile restare punti in questi generi letterari da quei numerosi aforismi che vi affiorano.
Essendo l’ironia un prodotto che sorge miscelando diffidenza e tragedia, essa fu ben presto materia della sua vita: nato a Pescara nel 1910, era sbarcato a Roma a dodici anni, il 28 ottobre 1922. Non un giorno qualunque ma, caso volle, proprio quello in cui si consumò la marcia su Roma, con frotte di camicie nere che sciamavano per le vie, stringendo in mano pagnotte e fiaschette di vino: era tutto un via vai – ricordò più tardi Flaiano – tra il Corso e piazza di Spagna, là dove s’affacciavano i più noti bordelli dell’urbe.
Quell’episodio, l’aver visto squadristi con fiasco e panino scorrazzare verso i casini, non fu evento marginale nella vita di Flaiano: lo salvò da ogni possibile illusione in un fascismo rigeneratore. Altri invece, chi più chi meno, ci cascarono: accadde a Maccari (cui Flaiano dedicò nell’almanacco Antipatico 1960 di Vallecchi i versi in cui ricorda l’amico, maggiore di una decina d’anni, entrare quel giorno a Roma: “Avevi il gagliardetto / il teschio bianco, il pugnale tra i denti”), come anche accadde a un Brancati o a un Longanesi.
Ma da quell’episodio prese anche forma il tono del suo stile, una fusione tra farsa e sconcerto, tra ilarità e turbamento perplesso. Se una cosa Flaiano ha nitidamente delineato, pur senza mai dirlo in maniera diretta e porgendolo a noi sul piatto dell’allusione intelligente, è che il Novecento è stato la fiera delle bufale politiche da parte degli intellettuali. Consapevolezza che, oltre ad averlo salvato dal fascismo, gli permise di scansare anche le promesse rigenerazioni del secondo dopoguerra e porsi non solo come antifascista ma come antitutto. Non facile in questa nostra Italia.
Forse, però, la tenuità dell’ironia si acquista meglio mediante i drammi della vita, cui Flaiano non fu esente: una grave encefalite colpì ancor piccola l’unica figlia Luisa, l’amata Lè-lè, lasciandole gravi sequele. Cose che poi si scontano – pur senza alcuna colpa – per tutta la vita, ma si sa che la vita ama fare, a caso, di questi bei doni. C’è chi pensa che alle spalle di questi accadimenti ci sia una volontà metafisica. Flaiano no.
Un particolare non secondario ci colpisce: che buona parte della scrittura di Flaiano sia confluita in libri postumi, a dimostrazione che la sua fu una scrittura squisitamente giornalistica e giornaliera, un perenne diario della vita, e dunque, inevitabilmente, un diario degli errori, come correttamente è stata intitolata una collezione di suoi scritti. Resta a parte il clamoroso caso del suo romanzo, Tempo di uccidere, reclamato da Longanesi che aveva appena fondato la propria casa editrice e scritto da Flaiano in pochi mesi, uscito nel 1947 e subito baciato dall’esordiente Premio Strega, prima ancora che lo vincesse (l’anno seguente) una figura straordinariamente calata nell’aria di Roma come Vincenzo Cardarelli.
E così come era stato involontario osservatore della marcia su Roma, Flaiano fu disincantato osservatore di una più moderna marcia romana: quella del benessere folleggiante e alienato lungo la serpentina di via Veneto nei primi anni sessanta, gli anni della “dolce vita”, trasposta in un celeberrimo film di Fellini di cui Flaiano fu sceneggiatore. Vi arrivava a piedi, ogni mattina, dalla sua casa in fondo a via Nomentana, e la vetrina di quello smodato benessere si dischiude nei Fogli di via Veneto, apparsi a luglio 1962 su “L’Europeo” e poi inclusi postumi in La solitudine del satiro. Sono fotografie essenziali per intuire un mondo e per capire il senso del lavoro intellettuale di Flaiano: non a caso con l’analisi di quei fogli si apre il volume che Gino Ruozzi ha voluto dedicare a Flaiano nei quarant’anni dalla scomparsa, avvenuta nel novembre 1972 (Ennio Flaiano. Una verità personale, pp. 302, € 25, Carocci, Roma 2012). Uno studio biografico e critico che rende viva la figura dello sceneggiatore, il quale con La dolce vita ebbe il suo successo più clamoroso, e ce ne svela i tanti volti – letterato, critico cinematografico, poeta, soggettista, commediografo – mediante un saggio che, saldamente fondato nel metodo scientifico, è comunque di stile delizioso. E soprattutto, il saggio collega la produzione intellettiva di Flaiano allo spirito aforistico ed epigrammatico di cui Ruozzi, curatore della nota antologia Scrittori italiani di aforismi per i “Meridiani” Mondadori, è studioso esperto, e ce ne fa riscoprire una vena lirica entro i cui confini Flaiano accoglieva la propria satira.
La “dolce vita” proviene da quegli anni cinquanta che avevano rappresentato per l’Italia il momento della radicale trasformazione in nazione industriale di massa. In questa nuova realtà, la nazione subito si frazionò: la produzione industriale e l’editoria furono aspetti predominanti al Nord; politica e cinema fiorirono invece a Roma, e il luogo in cui prese vita quel cromatico teatrino di vita – fatto di dive e paparazzi, di giornalisti e borghesi arricchiti – fu via Veneto: un mondo emergente e convulso, cui si contrapponeva l’immota figura di scrittore che viveva nel pieno di quello svolazzante trambusto: Cardarelli appunto, “ultimo guardiano di una Roma che scompare”.
E Flaiano si collocò nel bel mezzo di questi poli contraddittori ma non incompatibili, due opposti modelli di vita che per una decina di anni riuscirono a convivere lungo la stessa movimentata arteria: “Da un lato la frenesia e la volgarità, la corsa al successo, 1’ostentazione mondana e consumistica, dall’altro l’intelligenza raffinata e tagliente, il primato della letteratura, la riduzione all’essenziale, l’indignazione intellettuale, un’orgogliosa povertà”, scriv
e Ruozzi. Flaiano scrisse e sceneggiò quel mondo, senza mai illudersi – così come non aveva avuto illusioni sul ventennio – su quale sarebbe stato il modello prevalente: ovviamente quello dell’isteria febbrile del boom economico. Ma l’aria di via Veneto, che sebbene degradata era comunque quella dei caffè e della società di conversazione che vi passava le proprie ore, non la rinnegò mai: “I caffè sono le vere case degli artisti, gli unici luoghi ove essi pensano realmente, discutono e vivono la loro esistenza più intima”, aveva scritto già nel 1935 in un articolo per “Quadrivio”. Ed è infatti da quegli ambienti che viene stimolata, nella tradizione letteraria italiana, la forma breve della scrittura, l’elzeviro, l’articolo satirico, anche l’insofferenza al lieto fine delle cose, quella “pornografia rosa” che Flaiano detestava.
Fu da quell’aria, come anche dall’esperienza presso i tanti periodici cui collaborò, che apprese ad apprezzare il valore di ogni genere di scrittura “indipendentemente dal contesto di pubblicazione”, come fa notare Ruozzi al termine della sua disamina: il merito stava insomma per Flaiano non tanto in un genere specifico, e semmai giudicato nobile, di scrittura, ma nella qualità della stessa. E forse è questa la ragione per cui scrisse un solo romanzo, e abortirono i tentativi di farne altri. E tutto ciò, inoltre, ne delinea il fondamento illuminato e relativistico, quello di chi pensava che non ci siano verità assolute, solo parziali, se non addirittura nessuna verità. Aveva visto giusto: nessuna verità era ed è data alla povera Italia, destinata al perenne errore.
castronuovo.antonio@libero.it
A. Castronuovo è scrittore e traduttore