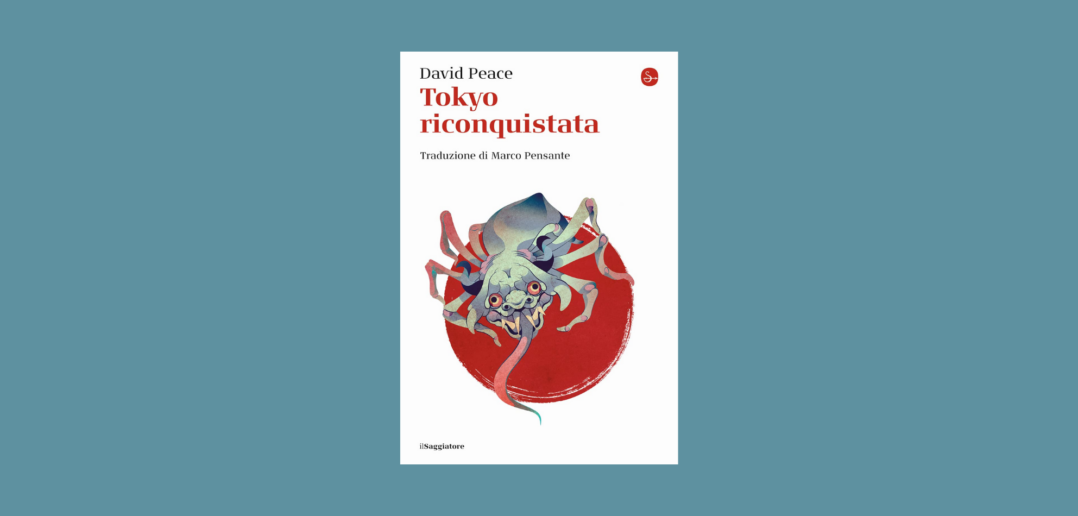Conversazione con David Peace di Davide Orecchio
 David Peace, che con Tokyo riconquistata (ed. orig. 2020, trad. dal giapponese di Marco Pensante, pp. 512, € 18, il Saggiatore, Milano 2021) conclude la sua trilogia giapponese, non è semplicemente un meraviglioso scrittore. È qualcosa di più. È uno scrittore ponte. Dal Giappone, terra e cultura che ha eletto a propria residenza da molti anni, si è proteso verso i suoi lettori occidentali per offrire storie di un mondo e un tempo lontani. Operazione coraggiosa perché, nel porgere queste storie, Peace ha rischiato di non essere accettato da nessuno. Non dai giapponesi, che avrebbero potuto rifiutare l’intrusione di un autore britannico. Né dagli occidentali, per banale disinteresse o pigrizia mentale. È il rischio che ogni mediatore sa di correre. Peace lo ha però corso con una tale profusione di studio e talento, insomma avendo a disposizione così tanti mezzi (o doni), che l’impresa non solo gli è riuscita ma, si potrebbe dire, sembrava quasi ritagliata su di lui e per lui. Dicevamo della trilogia e del volume che ora la completa. Chi abbia già letto i due precedenti romanzi – Tokyo anno zero (il Saggiatore, 2008) e Tokyo città occupata (il Saggiatore, 2010), riproposti dall’editore assieme al nuovo, e tutti nella traduzione di Marco Pensante – ritroverà molti personaggi e temi. Ritroverà detective americani, poliziotti, scrittori fuori di testa, ambigui editori, un traduttore che è, in realtà, una spia, e in tarda età per il senso di colpa non fa che scoppiare a piangere. Ritroverà il paesaggio storico – la capitale giapponese nel secondo dopoguerra, un paese sconfitto e controllato dai nordamericani –, ritroverà le parole, i suoni, l’angoscia. L’indimenticabile e insopportabile ton-ton che scandiva il sottofondo del primo volume, quel frastuono esalato dai cantieri dove si ricostruiva una città: ritroverà anche quello. E ritroverà il cattivo odore di un passato che non si cancella se non l’hai risolto. Peace ha completato un impressionante progetto letterario: raccontare fatti realmente accaduti rinnovando le potenzialità espressive del romanzo storico e del romanzo criminale nello stesso tempo. Al centro di Tokyo riconquistata la morte di Sadanori Shimoyama: 1949, presidente delle ferrovie nazionali giapponesi, in procinto di ristrutturarle e di licenziare centomila lavoratori. Il suo cadavere fu ritrovato sui binari. Per dare un’idea di cosa significhi questo episodio per i giapponesi, potremmo paragonarlo al delitto Matteotti o al sequestro di Aldo Moro. Il caso non fu mai risolto e incise sul destino politico del Giappone. Peace lo racconta in tre sezioni temporali che attraversano la storia del paese (1949, 1964, 1988) e corrispondono a tre parti stilisticamente l’una diversa dall’altra, ma tutte colme dei registri cui l’autore ci ha abituati. Ogni sezione del libro svela una parte di verità in un lavoro più tradizionale rispetto ai precedenti. Qui Peace corteggia il noir, il giallo, la spy story, ma non smette di proporci con forza la sua visione morale della storia. Il caso criminale, non risolto né sopito, si trasforma in una malattia politica, in una infezione civile trasmessa da una generazione all’altra senza requie. Peace ha tante frecce nell’arco del suo stile quanto innumerevoli sono i suoi maestri. In una recente intervista al Guardian li ha elencati, gli autori che gli hanno “cambiato la vita”. Sono Oscar Wilde, Lu Xun, Nâzim Hikmet, Christopher Hill, Albert Camus, Eileen Chang, Paul Celan, James Baldwin, Frantz Fanon, Ingeborg Bachmann, Heiner Müller, Michail Bulgakov e Angela Carter. Lasciamo invece da parte, e in evidenza, il fondamentale Ryūnosuke Akutagawa (al quale Peace ha dedicato il suo penultimo lavoro, il romanzo biografico Patient X) e Jean-Patrick Manchette. Su questi nomi torneremo tra poco insieme all’autore britannico che, dal Giappone, ha accettato di rispondere alle nostre domande intorno alla Trilogia e a temi più generali del suo lavoro.
David Peace, che con Tokyo riconquistata (ed. orig. 2020, trad. dal giapponese di Marco Pensante, pp. 512, € 18, il Saggiatore, Milano 2021) conclude la sua trilogia giapponese, non è semplicemente un meraviglioso scrittore. È qualcosa di più. È uno scrittore ponte. Dal Giappone, terra e cultura che ha eletto a propria residenza da molti anni, si è proteso verso i suoi lettori occidentali per offrire storie di un mondo e un tempo lontani. Operazione coraggiosa perché, nel porgere queste storie, Peace ha rischiato di non essere accettato da nessuno. Non dai giapponesi, che avrebbero potuto rifiutare l’intrusione di un autore britannico. Né dagli occidentali, per banale disinteresse o pigrizia mentale. È il rischio che ogni mediatore sa di correre. Peace lo ha però corso con una tale profusione di studio e talento, insomma avendo a disposizione così tanti mezzi (o doni), che l’impresa non solo gli è riuscita ma, si potrebbe dire, sembrava quasi ritagliata su di lui e per lui. Dicevamo della trilogia e del volume che ora la completa. Chi abbia già letto i due precedenti romanzi – Tokyo anno zero (il Saggiatore, 2008) e Tokyo città occupata (il Saggiatore, 2010), riproposti dall’editore assieme al nuovo, e tutti nella traduzione di Marco Pensante – ritroverà molti personaggi e temi. Ritroverà detective americani, poliziotti, scrittori fuori di testa, ambigui editori, un traduttore che è, in realtà, una spia, e in tarda età per il senso di colpa non fa che scoppiare a piangere. Ritroverà il paesaggio storico – la capitale giapponese nel secondo dopoguerra, un paese sconfitto e controllato dai nordamericani –, ritroverà le parole, i suoni, l’angoscia. L’indimenticabile e insopportabile ton-ton che scandiva il sottofondo del primo volume, quel frastuono esalato dai cantieri dove si ricostruiva una città: ritroverà anche quello. E ritroverà il cattivo odore di un passato che non si cancella se non l’hai risolto. Peace ha completato un impressionante progetto letterario: raccontare fatti realmente accaduti rinnovando le potenzialità espressive del romanzo storico e del romanzo criminale nello stesso tempo. Al centro di Tokyo riconquistata la morte di Sadanori Shimoyama: 1949, presidente delle ferrovie nazionali giapponesi, in procinto di ristrutturarle e di licenziare centomila lavoratori. Il suo cadavere fu ritrovato sui binari. Per dare un’idea di cosa significhi questo episodio per i giapponesi, potremmo paragonarlo al delitto Matteotti o al sequestro di Aldo Moro. Il caso non fu mai risolto e incise sul destino politico del Giappone. Peace lo racconta in tre sezioni temporali che attraversano la storia del paese (1949, 1964, 1988) e corrispondono a tre parti stilisticamente l’una diversa dall’altra, ma tutte colme dei registri cui l’autore ci ha abituati. Ogni sezione del libro svela una parte di verità in un lavoro più tradizionale rispetto ai precedenti. Qui Peace corteggia il noir, il giallo, la spy story, ma non smette di proporci con forza la sua visione morale della storia. Il caso criminale, non risolto né sopito, si trasforma in una malattia politica, in una infezione civile trasmessa da una generazione all’altra senza requie. Peace ha tante frecce nell’arco del suo stile quanto innumerevoli sono i suoi maestri. In una recente intervista al Guardian li ha elencati, gli autori che gli hanno “cambiato la vita”. Sono Oscar Wilde, Lu Xun, Nâzim Hikmet, Christopher Hill, Albert Camus, Eileen Chang, Paul Celan, James Baldwin, Frantz Fanon, Ingeborg Bachmann, Heiner Müller, Michail Bulgakov e Angela Carter. Lasciamo invece da parte, e in evidenza, il fondamentale Ryūnosuke Akutagawa (al quale Peace ha dedicato il suo penultimo lavoro, il romanzo biografico Patient X) e Jean-Patrick Manchette. Su questi nomi torneremo tra poco insieme all’autore britannico che, dal Giappone, ha accettato di rispondere alle nostre domande intorno alla Trilogia e a temi più generali del suo lavoro.
Il primo libro è del 2007, il secondo del 2009, l’ultimo del 2020. Aveva in mente una trilogia sin dall’inizio: come mai l’ultimo tassello del progetto ha preso più dieci anni?
Molti aspetti – alcuni personali, altri no – hanno reso più difficile scrivere Tokyo riconquistata. Confesso che dopo aver finito Tokyo città occupata per la prima volta mi sono sentito stanco di scrivere storie di crimine, di omicidio e di morte. Sono anche tornato temporaneamente in Gran Bretagna, il che ha rallentato le ricerche. Poco dopo, il mio agente William Miller è morto. Così nel mio periodo creativamente più fragile ho perso il mio più caro amico. Ma non ho mai smesso di cercare la forma corretta per raccontare questa storia, e ho steso diverse bozze complete, credo quattro o cinque, tutte poi abbandonate o scartate.
Nel frattempo ci sono stati altri due romanzi.
Esatto. Red or Dead (2013) e Patient X (2018). Penso che scriverli mi abbia aiutato a completare Tokyo riconquistata. Ma la ricerca è stata davvero soverchiante, a causa del numero di libri e materiali scaturiti in Giappone da questo caso. I due capitoli precedenti della trilogia (anche se io preferisco parlare di “trittico”) erano stati meno impegnativi, qui invece letture e traduzioni hanno portato via molto più tempo. E a un certo punto mi sono ammalato.
Spero nulla di grave.
Ho contratto quello che qui in Giappone chiamano “morbo di Shimoyama”. Mi interessava più risolvere il mistero del caso che scrivere il romanzo. E i ritardi si sono accumulati.
Parlando di malattia, immagino che abbia scritto Tokyo riconquistata durante la pandemia. Che esperienza è stata? Ha aumentato la temperatura di angoscia connaturata alla trilogia?
In realtà il libro era pronto già nell’estate del 2019, e programmato per uscire a maggio 2020 in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo. Quando le Olimpiadi sono state rinviate, Faber & Faber ha deciso di rimandare anche la pubblicazione del romanzo. La cosa buona, però, è che a causa del ritardo le edizioni tedesca, spagnola, italiana e giapponese escono nello stesso periodo di quella britannica e statunitense. Ma “l’angoscia connaturata” già c’era a prescindere dalla pandemia, solo che era causata dal “morbo di Shimoyama”.
I tre romanzi mettono il lettore di fronte alla storia del Giappone postbellico (1946-1949). Un paese imperialista, sconfitto, domato, sotto occupazione, ricostruito su fondamenta marce, nell’oblio dei crimini di guerra e nell’impunità di nuovi e futuri crimini. La soluzione narrativa adottata è quella di raccontare casi di cronaca nera irrisolti, o ambiguamente e parzialmente risolti, storicamente avvenuti, e di darne una lettura romanzesca ma non per questo non veritiera. Si avverte una tensione continua verso una verità che tuttavia in una forma oggettiva sembra irraggiungibile. In base a quali criteri ha scelto le storie della trilogia?
Ho scelto i casi che mi sembravano più adatti a comprendere il periodo dell’occupazione, sia dal punto di vista degli occupati che da quello degli occupanti. Ogni crimine fa storia a sé. In Tokyo anno zero il caso è, come dire, “aperto e chiuso”. Kodaira, l’assassino, viene catturato e poi giustiziato, sebbene restino insoluti alcuni aspetti; in particolare, e tragicamente, il numero effettivo delle vittime. Ma la natura dell’uomo e dei suoi crimini è strettamente legata al periodo immediatamente successivo alla sconfitta. Kodaira, ex soldato imperiale, macchiatosi di atrocità in Cina e insignito di medaglie per questo, ora, tra le rovine di Tokyo, preda donne adescandole col cibo o offrendo lavoro. Mi affascinava, poi, raccontare la polizia giapponese del 1946: come loro stessi fossero sospettati e indagati dagli americani, quanto scarso equipaggiamento e poche risorse avessero, come fossero spesso ridotti alla fame. Eppure continuavano a lavorare, a cercare di catturare uno stupratore e assassino. La voce narrante in prima persona del detective Minami – intensa, frammentata e incalzante – è lo strumento per illuminare un popolo spezzato, sconfitto e in rovina in un ambiente spezzato, sconfitto e in rovina.
In Tokyo città occupata la storia si complica, però.
Ma l’avvelenamento di dodici persone nella filiale della banca Teikoku sarebbe potuto accadere solo durante l’occupazione. I dipendenti si fidano dell’assassino semplicemente perché indossa sul braccio una fascia delle forze di occupazione. Seguono le sue istruzioni, bevono il veleno (un falso vaccino contro la dissenteria, e qui potremmo divagare a lungo sui molti parallelismi con la nostra attuale era pandemica). Anche questo caso è legato all’eredità dei crimini di guerra commessi dall’esercito imperiale giapponese in Cina, in particolare quelli dell’Unità 731 e gli esperimenti di guerra batteriologica sui prigionieri cinesi. Hirasawa, l’uomo che inizialmente confessò e fu condannato a morte, e che in seguito cambiò la sua dichiarazione senza essere mai giustiziato, secondo me era manifestamente non colpevole. È un altro tema che entra nel libro: il senso di ingiustizia, un caso e un passato irrisolti, aperti, che ancora perseguitano il presente. Speravo poi che la struttura del romanzo, ispirata al racconto Nel bosco di Ryūnosuke Akutagawa, avrebbe reso evidente l’enorme difficoltà insita nella ricerca di una “verità storica”: non che sia impossibile raggiungerla, ma è davvero molto difficile.
E veniamo a Tokyo riconquistata, dove il mistero, mi scuso per la contraddizione, è invece perspicuo.
Forse perché la morte di Sadanori Shimoyama, al centro del romanzo, è inestricabilmente connessa con le politiche delle forze americane. Siamo nel 1949. L’occupazione ha perso da tempo gli ideali ispirati al New Deal ed è entrata nella fase della “rotta inversa”: impone un drastico giro di vite al movimento sindacale e alla sinistra giapponese (che aveva inizialmente incoraggiato), esige sacrifici economici e, soprattutto, licenziamenti di massa. Quel cadavere trovato sui binari della ferrovia spalanca la scena di un radicale conflitto politico. Il Giappone si divide tra chi ritiene che Shimoyama si sia suicidato, tra chi parla di omicidio, tra chi incolpa la sinistra e chi la destra, e chi teorizza il coinvolgimento degli americani. Nel corso del tempo, inoltre, le posizioni, sia a destra che a sinistra, cambieranno fino a invertirsi, e questo è stato uno dei motivi che mi hanno convinto a sviluppare il libro su almeno tre tempi narrativi diversi.
Chi era Sadanori Shimoyama? Lei lo racconta come una figura tragica e isolata, paragona l’impatto della sua morte sui giapponesi a quello dell’omicidio Kennedy negli Stati Uniti. L’affare Shimoyama ha cambiato il corso della storia in Giappone?
Per me Sadanori Shimoyama è una figura in qualche modo tragica. Un uomo dedito ai treni, che aveva amato fin dall’infanzia, nominato primo presidente delle nuove ferrovie nazionali giapponesi semplicemente perché nessun altro voleva un incarico che avrebbe comportato la responsabilità di licenziare centomila lavoratori, con lo stress, le minacce, e la violenza che ne sarebbero conseguiti. In un certo senso la sua morte era prevedibile, e ha certamente cambiato il corso della storia giapponese: ha causato in buona sostanza la fine del movimento sindacale giapponese come forza politica di cambiamento, e ha anche arrestato l’ascesa del Partito comunista. Si può dire che la sinistra giapponese non si sia mai veramente ripresa dagli eventi di quell’estate del 1949, iniziata con la morte di Sadanori Shimoyama.
Resta un caso irrisolto. In Tokyo riconquistata ogni ipotesi viene messa in scena e valutata: omicidio, suicidio, omicidio camuffato da suicidio. Lei ha studiato tutte le fonti disponibili. Allude anche, in appendice, a documenti ancora secretati dalla Cia, lasciando intuire quale sia la sua opinione sul ruolo delle forze di occupazione nordamericane. Il romanzo si prende la responsabilità di dare una risposta. Affiora lo “scheletro” di quella che, in Italia, conoscendola molto bene purtroppo, definiremmo una “strategia della tensione”: scatenare la morte e poi far ricadere la colpa su una parte politica o sociale, in questo caso i sindacati, così da scatenare un’ondata contro le sinistre e trascinare il Giappone lontano da tentazioni filocomuniste. È questa la sua teoria, se si può parlare di teoria? E come l’hanno presa i suoi interlocutori e collaboratori giapponesi?
Sì, la mia convinzione personale è che in Giappone fosse in atto “una strategia della tensione” molto simile, se non esattamente la stessa, a quella adottata in Italia e altrove – l’importante saggio di Leonardo Sciascia su L’affaire Moro è stato un testo chiave per me. Strumentalizzarono la morte di Shimoyama – un omicidio, ne sono assolutamente convinto – insieme ad altri episodi di sabotaggio e terrorismo per screditare e infine distruggere la sinistra giapponese. E i giapponesi che mi hanno aiutato nella ricerca sarebbero ampiamente d’accordo con questa osservazione, credo. Le nostre opinioni potrebbero invece differire quanto al grado di coinvolgimento diretto degli americani nella morte di Shimoyama.
In che senso?
Resto convinto che alcune agenzie americane abbiano fornito informazioni e supporto finanziario e tecnico segreto ai gruppi nazionalisti giapponesi di estrema destra. Gruppi nati prima della guerra e che si macchiarono di assassinii e sabotaggi sia in Giappone che in Cina durante gli anni della Valle Oscura, come i giapponesi definiscono il periodo storico militarista che va dalla fine degli anni venti fino alla sconfitta del 1945. E che continuarono a operare anche nel dopoguerra, in particolare a partire dal 1948. Negli ambienti della sinistra giapponese è invalsa la tendenza ad accusare gli Stati Uniti di aver esercitato un ruolo diretto, di avere partecipato in prima persona a questi atti più di quanto io creda sia davvero avvenuto. Ma penso sinceramente che alcuni americani sapessero cosa stava succedendo, e che molto probabilmente incoraggiarono e agevolarono il rapimento di Shimoyama, e non fecero nulla per impedire il suo assassinio, usandolo anzi a loro vantaggio per combattere la sinistra giapponese e il comunismo internazionale.
Ogni volume della trilogia presenta innovazioni formali o strutturali. Il primo ha lo stile claustrofobico, ripetitivo, percussivo tipico di David Peace. Il secondo ha una struttura meravigliosa, ispirata come si diceva all’opera di Ryūnosuke Akutagawa. Il terzo romanzo appare più “sereno” nell’esposizione (non certo nei temi), più classico nell’uso dei dialoghi, nell’intenzione di mostrare i personaggi attraverso quello che fanno e dicono. La scelta di uno stile e di una struttura nasce da una sua esigenza interna, autonoma, corrispondente a una fase creativa, o è funzionale alla storia e al libro che si prepara a scrivere?
Direi: entrambe le cose. Ho sempre avuto un forte senso visivo riguardo alle opere del trittico. Tokyo anno zero guida il lettore attraverso le sue parti: si entra dalla porta del corpo, si attraversa il ponte delle lacrime prima di salire sulla montagna delle ossa. Qui, in cima alla montagna delle ossa, si trova la Città occupata con le sue porte nere, ed è ancora qui che si fa ritorno in Tokyo riconquistata, ripartendo dalla montagna delle ossa, scendendo e attraversando il ponte delle lacrime fino ad arrivare di nuovo alla porta del corpo. Questo è il paesaggio, l’architettura. Ma all’interno di ogni opera ciascun caso esigeva una forma narrativa e uno stile. In Tokyo riconquistata è stato anche importante per me “tornare a”, “recuperare”, “rivisitare” modelli di crime fiction, dato che in Giappone il caso Shimoyama è diventato presto il soggetto di un ampio filone narrativo e saggistico. Così la prima sezione è un dichiarato omaggio al noir americano di Dashiell Hammett. Hammett, insieme a Leonardo Sciascia e Jean-Patrick Manchette, forma una “santissima trinità” di scrittori di gialli di sinistra: loro continuano a ispirarmi. La seconda sezione, invece, attinge a due forze concorrenti all’interno del genere poliziesco giapponese. Il racconto dell’investigatore privato Murota deve molto a La mappa bruciata di Kōbō Abe, che a sua volta attinge ai primi romanzi di Robbe-Grillet. Mentre il secondo filone di questa parte riguarda lo scrittore scomparso Kuroda Roman, un personaggio che si ispira alla giallistica più classica di Edogawa Rango. In questa sezione affiorano anche elementi del grande scrittore di gialli di sinistra Seichō Matsumoto, un’altra importante influenza. Infine, la terza sezione si muove dal noir e dal crime al romanzo di spionaggio, così come l’orizzonte del caso stesso si allarga per abbracciare la storia della Guerra fredda e la fine dell’Unione sovietica. La terza sezione è qualcosa di completamente originale nella struttura del mio lavoro, e spero che sia un sintomo di percorsi futuri.
Parliamo di letteratura e fonti. Ogni documento (libro, giornale, fonte d’archivio, lettera, diario, materiale audiovisivo) ha una sua voce e un suo stile: come interagiscono col suo stile e con la sua voce di scrittore? Li modificano e condizionano? O riesce a mantenere la sua autonomia?
È difficile generalizzare perché dipende da ogni singola fonte, ma certamente spero che nel loro insieme formino l’arazzo di un testo più ampio dal quale, in misura diversa, cerco poi di estrarre il romanzo. Per esempio, il linguaggio dei rapporti del Ghq (il quartier generale nordamericano, ndr) sulla scomparsa di Shimoyama ha certamente influenzato il linguaggio della prima sezione di Tokyo riconquistata. Piccoli frammenti di articoli di giornale aggiungono una parola qua o là e spero possano dare al lettore il senso del tempo e del luogo. Anche la letteratura, la musica e il cinema fanno la loro parte. Ma l’auspicio è che ogni fonte mi aiuti a illuminare e poi esporre la verità attraverso la finzione.
Il suo metodo implica un rapporto molto accurato, quasi ossessivo, con le fonti. Mi sembra che questa accuratezza entro un lavoro narrativo, che implica un dialogo continuo tra documento storico e invenzione, accompagnato all’interesse per la storia del Novecento, riguardi un numero significativo di autori appartenenti a una generazione a cavallo tra i due secoli. Tutti loro probabilmente istruiti alla scuola di W. G. Sebald. Tutti loro impegnati nella creazione di un “nuovo romanzo storico” che da un lato mette a tema il passato prossimo, dall’altro combina letteratura e storia delineando con precisione e trasparenza ciò che è fonte e ciò che è invenzione, e infine sperimenta nuove strutture formali. Lei si sente parte di questo scenario?
In breve, sì. Dal 2011 ho iniziato a insegnare a tempo parziale all’Università di Tokyo. Uno dei miei primi corsi, mentre lavoravo su Tokyo riconquistata, si intitolava Scrivere storia (The writing of history), e comprendeva Sebald tra gli altri. Quindi per molti anni mi sono occupato molto consapevolmente di come “scriviamo la storia”, sia nei romanzi che nella saggistica letteraria. Credo di avere raggiunto questo livello di riflessione abbastanza naturalmente dopo avere scritto i libri del ciclo Red Riding (1999-2002) e soprattutto GB84 (2004), che racconta in modo dettagliato un evento storico, lo sciopero dei minatori britannici del 1984-85, che riguardò centinaia di migliaia di persone. La domanda che mi pongo continuamente è: come possiamo raccontare nel modo migliore queste storie del nostro passato recente? La fiction è la forma più adatta e corretta? E se è così, allora quali sono le strutture che più di altre mettono in discussione la “verità ufficiale” e riescono a illuminare “l’altra verità”?
Quanto al genere – il noir, il romanzo criminale – si ha l’impressione che lei lo adotti anche come passepartout per raccontare temi fondamentali come l’impossibilità di verità e giustizia. L’essere privi di una verità da rivelare è forse il tratto principale, la ragione d’essere, della letteratura. Ed è una ferita aperta in tutte le pagine della trilogia. Il noir, la crime story, sono al servizio di questa tensione, assolvono meglio di altre forme romanzesche il compito di raccontare l’ambiguità, il cinismo e l’immoralità dei comportamenti umani?
Per citare Manchette, il romanzo poliziesco o noir è “la grande letteratura morale del nostro tempo”, o almeno ha il potenziale per essere il genere narrativo più appropriato al racconto del cinismo e dell’immoralità nel comportamento umano. Anzi, per essere ancora più precisi, è la forma più adatta per esporre il male e la corruzione nel cuore del nostro sistema capitalista, e condannarli. Naturalmente la maggior parte degli autori di crime fiction rifiuta tale responsabilità e opportunità; preferiscono ritagliarsi il ruolo di pornografi, e arricchirsi con fantasie sadiche e voyeuristiche.
Le pagine della trilogia sono intrise di violenza. Sono violenti tutti i personaggi, i gruppi sociali o professionali. Come se la violenza pubblica e alla luce del sole di una nazione militarista, dopo la fine della guerra, nella sedazione della sconfitta, fosse migrata nei comportamenti “notturni”, nascosti, patologici delle vite individuali e private. Non so se è d’accordo. E, di questa violenza irredenta, c’è ancora traccia nel Giappone di oggi?
Sono d’accordo. In Tokyo riconquistata ci sono molti passaggi al riguardo. Ma non lo vedo come un problema unicamente giapponese. Anzi, direi che questa violenza si percepisce forse meno nel Giappone odierno che altrove. Piuttosto, ripeto, vedo la violenza del nostro tempo come una logica conseguenza delle società capitaliste, aggravata dal fatto che il divario tra chi ha e chi non ha, a livello locale e globale, continua ad aumentare. “Cane mangia cane” significa che ci mangiamo a vicenda. Siamo tutti cannibali.
(Una versione ridotta di questo articolo è uscita su “Internazionale.it” il 4 luglio 2021)