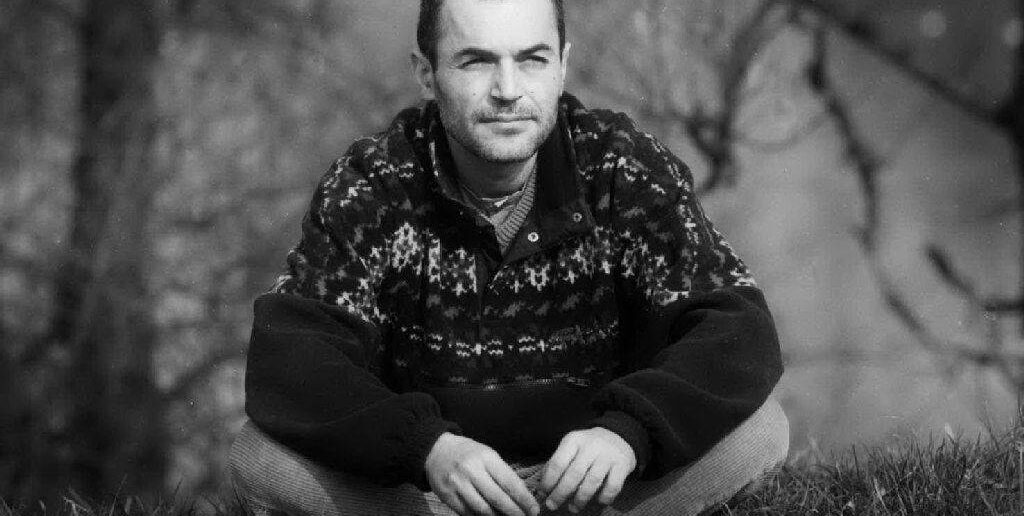di Alice Pisu
 Nella vasta produzione critica intorno all’opera di Sergio Atzeni si staglia il contributo offerto da Franciscu Sedda con Il sogno del falco. Con lo sguardo del semiologo, Sedda si mette sulle tracce di segni palesi e tuttavia nascosti per offrire un’inedita lettura dell’intera produzione letteraria atzeniana e indagare gli esiti della costruzione del suo mito. L’intento è cogliere aspetti ignorati nell’opera-vita di Atzeni. Per farlo, sostiene l’autore, bisogna tornare ad ascoltare la voce dei testi, al di là del filtro interpretativo della critica. Un tentativo che si giustifica anche attraverso quanto lo stesso Atzeni sosteneva in chiusura del noto intervento Nazione e Narrazione del 19 novembre 1994: “la risposta è nelle narrazioni”. La ricerca parte dunque dal particolare “trittico” conclusivo composto da Il quinto passo è l’addio, Passavamo sulla terra leggeri e Bellas Mariposas, considerato come l’esito di un progetto organico e di un discorso unitario. Identificando simboli-chiave ricorrenti, rimandi analogici e potenti allegorie, il saggio evidenzia una coincidenza interna alle opere, rivelatrice di un percorso esistenziale legato a una doppia conversione, a una “identificazione a cui votarsi”. Attraverso la definizione del Codice Atzeni, Sedda compie una sorta di anamnesi in modo da far emergere, e lasciar intravedere, quel che di politico si cela dietro e dentro al poetico, in un continuo gioco di allusioni tra parola individuale e voce collettiva. Il Codice individuato proietta una luce nuova sulla natura ibrida insita nell’intera produzione di Atzeni, consentendo al lettore di analizzare e comprendere in termini nuovi le fedi, le scelte personali e le identificazioni, la pluralità di radici e la concezione di una singolarità storica nazionale.
Nella vasta produzione critica intorno all’opera di Sergio Atzeni si staglia il contributo offerto da Franciscu Sedda con Il sogno del falco. Con lo sguardo del semiologo, Sedda si mette sulle tracce di segni palesi e tuttavia nascosti per offrire un’inedita lettura dell’intera produzione letteraria atzeniana e indagare gli esiti della costruzione del suo mito. L’intento è cogliere aspetti ignorati nell’opera-vita di Atzeni. Per farlo, sostiene l’autore, bisogna tornare ad ascoltare la voce dei testi, al di là del filtro interpretativo della critica. Un tentativo che si giustifica anche attraverso quanto lo stesso Atzeni sosteneva in chiusura del noto intervento Nazione e Narrazione del 19 novembre 1994: “la risposta è nelle narrazioni”. La ricerca parte dunque dal particolare “trittico” conclusivo composto da Il quinto passo è l’addio, Passavamo sulla terra leggeri e Bellas Mariposas, considerato come l’esito di un progetto organico e di un discorso unitario. Identificando simboli-chiave ricorrenti, rimandi analogici e potenti allegorie, il saggio evidenzia una coincidenza interna alle opere, rivelatrice di un percorso esistenziale legato a una doppia conversione, a una “identificazione a cui votarsi”. Attraverso la definizione del Codice Atzeni, Sedda compie una sorta di anamnesi in modo da far emergere, e lasciar intravedere, quel che di politico si cela dietro e dentro al poetico, in un continuo gioco di allusioni tra parola individuale e voce collettiva. Il Codice individuato proietta una luce nuova sulla natura ibrida insita nell’intera produzione di Atzeni, consentendo al lettore di analizzare e comprendere in termini nuovi le fedi, le scelte personali e le identificazioni, la pluralità di radici e la concezione di una singolarità storica nazionale.
Sergio Atzeni scompare il 6 settembre 1995 nelle acque dell’Isola di San Pietro lasciando un’eredità complessa. A cosa stava approdando il suo lavoro di ricerca bruscamente interrotto? In quali termini si può parlare di un “Codice Atzeni” e in che modo tale definizione può aprire nuovi scenari interpretativi sull’opera-vita?
Per sintetizzare senza troppo svelare, dato che tanto l’opera di Atzeni quanto la mia lettura si presentano come un percorso da fare prima che un risultato da cogliere, si può dire che Sergio con la sua opera stava facendo i conti con le sue fedi e cercando di reintrodurre del sacro nella storia e nei vissuti della Sardegna. Si tratta in realtà di una doppia fede-sacralità, religiosa e laica, spirituale e politica. L’indissolubilità di questa relazione è il Codice Atzeni: una volta che se ne coglie la presenza attraverso piccoli segni-chiave ricorrenti ci si rende conto che esso attraversa tutta l’opera atzeniana aprendola ad un livello di significazione secondo. Il falco, che rimanda in modo peculiare al medioevo e al regno sardo di Arbaré/Arbarei, è la figura al centro di questo codice allegorico. Per una serie di “casualità incatenate”, per dirla con Marquez, questa falchitudine si associa anche alla vita di Atzeni: “lungo il viaggio cantarono un lungo canto che soltanto chi capiva la lingua dei falchi comprese, giunti alle Colonne si lasciarono cadere in mare come pietre e morirono affogati. Da allora i falchi custodiscono quel luogo, lo reputano sacro”. Siamo alla fine di Passavamo e ad un passo dal luogo in cui morirà Sergio. Una coincidenza perturbante, una chiave che per motivi personali mi ha accompagnato per ventiquattro anni, fin quando non ho trovato le giuste porte da aprire.
Tra gli aspetti cruciali evidenziati ne Il sogno di falco vi è quello della doppia conversione, riconosciuta attraverso simbologie celate nelle due ultime opere Passavamo sulla terra leggeri e Bellas Mariposas ma riconoscibili nell’intera produzione. Segnali che in particolare nell’ultima opera risultano totalizzanti, al punto da considerare Bellas Mariposas un racconto che si rivela integralmente come simbolo, una “gigantesca allegoria arborense”. È in tale dualismo la chiave per intravedere una comunanza formale e tematica propria di un discorso unitario atzeniano?
Bellas mariposas è esplosivo. Sembra una storiella o al più una sperimentazione sul linguaggio e invece è una rivoluzione. Il racconto si presenta come la cronaca di una morte annunciata, che alla fine però non si realizza. Perché? Perché Cate, l’adolescente protagonista, per due volte chiama la Madonna e per due volte questa si materializza: solo che una volta lo fa sotto le vesti di una coga/maga che di nome fa Aleni e danza “le antiche danze di Arbarei”, la seconda volta sotto le spoglie di un quasi invisibile Uomo-falco il cui sacrificio cambia il destino della storia, dei bambini, della città. Dopo avercela presentata in modo più esplicito in Passavamo torna anche qui l’inscindibile doppia sacralità atzeniana, il Codice. Ma non si tratta solo della ripetizione di una struttura valoriale, sono interi pezzi di storia che saltano da un libro all’altro. Come Ulisse torna a Itaca da mendicante, così in Aleni dobbiamo saper cogliere una regina-fondatrice che da Passavamo ritorna a completare una storia di libertà: Karale diviene Casteddu, è finalmente conquistata alla Sardegna. Passavamo sta a Mariposas come il vecchio testamento con le sue antiche leggi e una libertà incompiuta sta al nuovo testamento atzeniano con un sacrificio fondante e la sua lieta novella.
Nel gioco di rimandi e riferimenti da decodificare a cui il lettore è chiamato a partecipare, lo studio insiste sul significato di nomi-memoria. Come quello di Ruggero Gunale, protagonista de Il quinto passo è l’addio, che cerca strenuamente di eludere una responsabilità collettiva insita in quell’attribuzione natale. Un desiderio di fuga da un destino imperscrutabile che segna anche Itzoccor nell’Apologo del giudice bandito. In che senso l’analisi semiotica intuisce nell’“occasione di una volontà” il mezzo per rompere la “circolarità dell’eterno addio e dell’eterno ritorno”?
Sì, c’è una memoria che Atzeni fa scorrere attraverso i nomi. E quando anche i nomi sono stati confusi fa passare attraverso i corpi, come accade ne Il figlio di Bakunìn. La storia distopica di Ruggero Gunale nel Quinto passo porta all’estremo l’idea di fuga dalla memoria collettiva che i nomi-corpi atzeniani custodiscono. È il vertice di un delirio che scinde il soggetto fra megalomania e nullificazione e pone l’umano sempre fuori dal soggetto e dalla Sardegna: “Sarò libero. La maschera che mi cuciranno addosso, lo straniero, l’isolano, il mendicante, mi nasconderà, occulterà il nome, sarò uomo fra uomini…”. Ma è una finzione. Ruggero stesso ammette di essere già tornato. Di non poterne fare a meno perché è lui per primo a sentirsi straniero fuori dalla Sardegna. Questo delirante andirivieni, dentro il testo trova una via d’uscita grazie alle “parole antiche” di una canzone in sardo (cantate da una madonna con bambino!) che riattivano una volontà: non fuggire più, prendersi delle responsabilità, divenire partecipe di una nuova storia collettiva. Fuori dal testo è il canto nella “lingua dei falchi” che Atzeni compone con le sue opere, a essere questa nuova storia. Narrare diviene allora volontà e cura. L’analisi semiotica raddoppia questo gesto e traducendolo in un altro linguaggio lo svela o lo rende più esplicito. Fa vedere, per dirla con Deleuze e Guattari lettori di Kafka, che davanti ad una coscienza nazionale inattiva o in disgregazione l’opera si pone come enunciazione collettiva che la riscatta e riattiva, offre questa coscienza tradotta e ritrovata come strumento di solidarietà a favore di una comunità futura.
Che ruolo assume la memoria nel discorso sull’identità storica e in che modo si relaziona alla parte che Atzeni assegna all’immaginario nella rielaborazione del passato per rivolgersi al presente?
Se guardiamo all’opera di Atzeni come un tutto salta all’occhio come egli stia cercando di comporre un’unica grande storia della Sardegna. Opera dopo opera è come se Atzeni componesse un puzzle al fine di ricostruire una visione d’insieme, con le sue coerenze e i suoi sincretismi, con le sue discontinuità apparenti e con le continuità invisibili. Atzeni traduce e cuce. È come un patchwork temporale che opera dopo opera compone un nuovo abito. Il secondo aspetto è il cortocircuito che Atzeni compie fra “antico” e “futuro”. Nei momenti topici delle sue narrazioni calate nei drammi del presente è il manifestarsi di “antiche leggi”, “antiche danze”, “antiche parole” che salva i protagonisti aprendo squarci verso un tempo diverso. Infine, una linea narrativa importante, che ritorna creando connessioni meravigliose, è quella della profezia, della capacità degli antichi di predire il futuro. Il punto dunque non è la memoria ma pre-dire il futuro attraverso il racconto di una storia condivisa, la ricostruzione di un immaginario collettivo, la capacità dell’antico di (ri)sacralizzare il presente aprendolo alla speranza.
Come evidenziato nell’analisi dell’Apologo del giudice bandito, uno dei cardini della prosa atzeniana è il valore e il significato dell’ibridità. In che modo tale carattere permea la visione politica di chi come Atzeni rivendica di non voler essere “giudice ma poeta”?
L’ibridità è un tratto importante della poetica di Atzeni ma è un dato più problematico di quanto non si pensi. Non c’è una visione stereotipata, eudemonica dell’ibridità, sia essa propria o altrui, individuale o sociale. L’ibridità è travaglio saturo di rischi e di potenzialità. In tal senso, più che l’ibridità la questione è l’alterità, soprattutto quella che ciascuno si porta dentro o che ci vive affianco. Io la chiamo l’alterità del proprio. Atzeni ci parla della paura dei sardi per l’alterità: quella che i suoi protagonisti sardi sopravvalutano negli altri, ancor più quella che sottovalutano in se stessi. La mia ipotesi è che Atzeni fa sottilmente a pezzi lo stereotipo contemporaneo del sardo forte e consapevole di sé e ne svela l’anima impaurita e immemore. Da qui l’esigenza di riconoscere il giusto peso di alterità e ibridità mentre le si porta a sintesi positiva attraverso nuove narrazioni. Per questo, dalla metà degli anni Ottanta, nel pieno del suo processo di conversione, Atzeni assume il narrare come il suo modo di fare politica.
Proprio a un’ibridità da non sacrificare risultano strettamente connessi la questione dell’alterità e il significato di nazione. Quale potenziale attribuire in tale prospettiva al ruolo della narrazione?
Più Atzeni avanza nel suo percorso più diviene consapevole di un problema: come narrare una nazione, ridarle immaginario e presenza, in un tempo in cui il mito dell’omogeneità culturale della nazione è tramontato o addirittura si associa a fantasmi di violenza? Da qui una sfida: tenere insieme, attraverso una scrittura creativa e comunicativa al contempo, la pluralità di radici di cui ogni individuo è portatore e la singolarità della nazione come fatto collettivo. Ecco allora Atzeni che dice di sentirsi segnato da tre radici-tradizioni: l’etnicità sarda, la tradizione linguistico-letteraria italiana, l’identità religiosa giudaico-cristiana. Il suo riferimento alla triade “sardo, italiano, europeo” non è una triade politica, del tipo regionale-nazionale-sovranazionale, ma rimanda alle radici culturali che a livello personale egli sente di dover mettere in gioco. Per fare cosa? Per raccontare la nazione, che è una ed è la Sardegna.