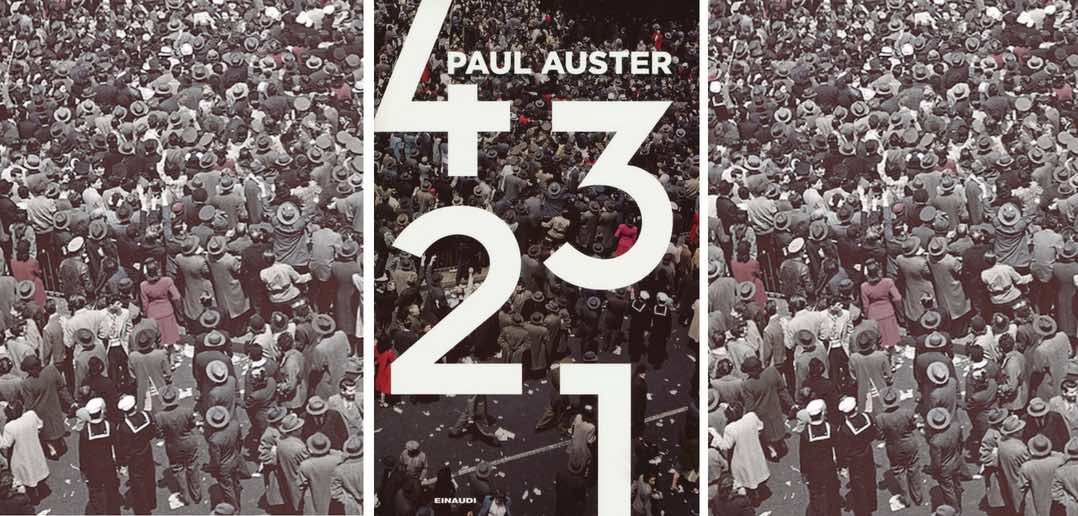Sliding doors e strade non prese
di Cinzia Scarpino
dal numero di maggio 2018
“Secondo la leggenda di famiglia, il nonno di Ferguson partì a piedi da Minsk, sua città natale, con cento rubli cuciti nella fodera della giacca, viaggiò a ovest fino ad Amburgo passando per Varsavia e Berlino, comprò il biglietto per una nave chiamata Empress of China che attraversò l’Atlantico in mezzo a violente tempeste invernali ed entrò nel porto di New York (…). Nome?, chiese il funzionario. Battendosi la fronte indispettito, lo stanco immigrato se ne uscì in yiddish, Ikh hob fargessen (Non me lo ricordo più)! E fu così che Isaac Reznikoff cominciò la sua nuova vita in America come Ichabod Ferguson”.
 L’incipit di 4321 (ed. orig. 2016, trad. dall’inglese di Cristiana Mennella, pp. 944, € 25, Einaudi, Torino 2017 acquista su IBS.it), lancia segnali inequivocabili al lettore: la voglia di chi narra di ritornare all’etnogenesi di una nazione (Ellis Island, la storia dell’immigrato) e la voglia di chi scrive di misurarsi con il “grande romanzo americano”, ippogrifo con il quale finora Paul Auster (sempre più narratore e autore in questo libro scopertamente autobiografico) non si era mai cimentato. Grande è la distanza con l’attacco di Città di vetro (1985), felicissimo (quasi) esordio austeriano e pezzo migliore della Trilogia di New York: “Cominciò con un numero sbagliato, tre squilli di telefono nel cuore della notte e la voce dell’apparecchio che chiedeva di qualcuno che non era lui”. Dalla reticenza à la Hammett alle lunghe subordinate di 4321, dall’eleganza di quell’intarsio metanarrativo che decostruiva la detective story alla macchinosità ingombrante di un romanzo di formazione che promette un respiro narrativo dickensiano ma pare ridursi, per citare Holden Caulfield di Salinger, in “tutte quelle baggianate alla David Copperfield”. Certo restano molte delle ricorrenti – in anni recenti un po’ fruste – ossessioni di Auster: il doppio (che qui letteralmente raddoppia), il peso del destino, il dubbio, l’introspezione, l’eredità, i “taccuini” di uno scrittore. Motivi riconoscibili ma polverizzati nello sprawl dei quattro sentieri narrativi delle altrettante possibili Bildungen di Archibald Isaac Ferguson.
L’incipit di 4321 (ed. orig. 2016, trad. dall’inglese di Cristiana Mennella, pp. 944, € 25, Einaudi, Torino 2017 acquista su IBS.it), lancia segnali inequivocabili al lettore: la voglia di chi narra di ritornare all’etnogenesi di una nazione (Ellis Island, la storia dell’immigrato) e la voglia di chi scrive di misurarsi con il “grande romanzo americano”, ippogrifo con il quale finora Paul Auster (sempre più narratore e autore in questo libro scopertamente autobiografico) non si era mai cimentato. Grande è la distanza con l’attacco di Città di vetro (1985), felicissimo (quasi) esordio austeriano e pezzo migliore della Trilogia di New York: “Cominciò con un numero sbagliato, tre squilli di telefono nel cuore della notte e la voce dell’apparecchio che chiedeva di qualcuno che non era lui”. Dalla reticenza à la Hammett alle lunghe subordinate di 4321, dall’eleganza di quell’intarsio metanarrativo che decostruiva la detective story alla macchinosità ingombrante di un romanzo di formazione che promette un respiro narrativo dickensiano ma pare ridursi, per citare Holden Caulfield di Salinger, in “tutte quelle baggianate alla David Copperfield”. Certo restano molte delle ricorrenti – in anni recenti un po’ fruste – ossessioni di Auster: il doppio (che qui letteralmente raddoppia), il peso del destino, il dubbio, l’introspezione, l’eredità, i “taccuini” di uno scrittore. Motivi riconoscibili ma polverizzati nello sprawl dei quattro sentieri narrativi delle altrettante possibili Bildungen di Archibald Isaac Ferguson.
Gioco di specchi
Il gioco di specchi tra l’autore Paul Auster e i suoi quattro alter-ego Ferguson affiora di continuo: Archie Ferguson nasce il 3 marzo 1947, Auster il 3 febbraio dello stesso anno (il 3 febbraio ricorre anche nelle ultime pagine del romanzo, destinate allo svelamento del meccanismo che ne sorregge la struttura narrativa), entrambi a Newark (New Jersey); entrambi di famiglia ebreo-americana (di provenienza russa e polacca); entrambi cresciuti in un contesto medioborghese come tipici babyboomers dei suburbs americani. Un territorio già noto al lettore che conosca il memoir del 1997, Sbarcare il lunario, in cui Auster scriveva con stringatezza e ironia mirabili: “Provenivo da una famiglia medioborghese. Ho trascorso l’infanzia nel benessere, senza mai conoscere la scarsità e le privazioni che assillano gran parte degli esseri umani viventi sulla terra”. E comuni all’autore e ad alcune varianti-Ferguson saranno anche i possibili apprendistati universitari newyorchesi e la vita bohémienne parigina. Un autobiografismo nostalgico e tirannico, di cui Auster sembra voler scartabellare ogni dettaglio restituendo un enciclopedico diario di vita che contenga tutte le proliferanti ramificazioni del caso, “le strade non prese” – per citare il celebre poema di Robert Frost – o le Sliding doors dell’omonimo film con Gwyneth Paltrow del 1998.
Dopo una sorta di prologo (“1.0”) in cui al lettore vengono dati tutti i dettagli del corteggiamento fra Stanley Ferguson e Rose Adler, e della nascita del loro unico figlio Archie, i sentieri narrativi si “quadriforcano” in parallelo presentando ognuno una variante di Archie Ferguson (chiamiamoli per comodità Ferguson-1, Ferguson-2, Ferguson-3, Ferguson-4). Seminale in questa prima parte è la vicenda dell’emporio di elettrodomestici di Stanley Ferguson e di Stanley Ferguson stesso, una riscrittura parodica di trame che richiamano i romanzi di James M. Cain (su tutti Double Indemnity): in una è svaligiato da uomini pagati dallo zio, in un’altra viene dato alle fiamme per riscattare l’assicurazione, in un’altra ancora è “rilevato”. Nella variante dell’incendio doloso, Stanley muore tragicamente perché si addormenta nel suo ufficio mentre attende che gli scagnozzi prezzolati da lui e dai fratelli vengano ad appiccare il fuoco. È la variante Ferguson-3. A questo punto si hanno quindi quattro versioni del giovane Archie, tre suburbane e una newyorchese. Di quelle suburbane – quasi identiche nella grigia omologazione paesaggistica e culturale che le contraddistingue – una verrà meno al capitolo 2.2., quando Ferguson-2 sarà schiacciato, appena tredicenne, da un ramo durante un nubifragio in campeggio (trauma infantile di Auster a cui era capitato di assistere allo stesso tipo di morte di un amico). Ecco allora che la sezione successiva, arrivata al capitolo 3.2, presenterà una pagina bianca. Restano comunque ancora tre Ferguson. Uno che cresce a Montclair in circostanze economiche non floride ma con una famiglia unita; uno che cresce a Maplewood in un contesto ricco ma con i genitori sulla via della separazione; e uno che, dopo la morte del padre, cambia vita trasferendosi a Manhattan con la amatissima madre Rose. Il Ferguson di Montclair andrà alla Columbia per diventare un giornalista, quello di Maplewood a Princeton per dedicarsi a scritture più letterarie, quello di Manhattan, Ferguson-3, morirà ventenne in un’incidente autostradale a Londra (da cui la pagina bianca 7.3). Le varianti investono anche gli altri personaggi: genitori, zii, cugini e amici – su tutti la strepitosa Amy Schneiderman, di volta in volta, fidanzata, cugina, sorellastra, a seconda della piega che prendono gli sviluppi coniugali di Rose.
Sullo sfondo la Storia americana
A fare da sfondo alcuni degli eventi più importanti del secondo dopoguerra americano: la guerra fredda, il caso Rosenberg, l’ascesa e l’assassinio di JFK, la leva per il Vietnam, il massacro di My Lai, la sparatoria della Kent State, le proteste studentesche alla Columbia University. L’insistita inclusività dei riferimenti storici privi di una reale funzione narrativa se non una elementare collocazione cronologica sfinisce però il lettore medio, irritando quello più preparato. Si tratta di lunghi pezzi che sembrano stralciati da un libro di testo, interludi documentaristici che vorrebbero offrire una cronaca romanzata della storia americana degli anni cinquanta e sessanta ma non riescono a interagire sul piano del racconto. Niente di paragonabile alle soglie di attraversamento storico ricreate da Don DeLillo in Underworld o da Philip Roth in quasi tutti i suoi affreschi romanzeschi (da Pastorale americana a Il complotto contro l’America).
Quanto alla/e trama/e, invece, vi si ritrovano tutti gli snodi dei Bildungsroman maschili orientati al secondo dopoguerra: la famiglia, gli amici, la scuola (Archie è uno studente dotato e con una coscienza sociale che si aprirà a interessi quali il cinema, la musica classica e la letteratura), lo sport (Archie è un bravo atleta, a volta gioca a baseball altre a basket), il sesso (profuso e precoce), la politica. Dalle tre varianti “quasi ventenni” che sopravvivono di Archie, si staglia quella newyorchese, capace di una curiosità sessuale spregiudicata e una moralità che si discosta dalla rettitudine da boy-scout dei due Ferguson suburbani. Non da ultimo, sul piano del tedio narrativo, il Ferguson di Manhattan si professa estraneo alla passione politica e questo risparmia al lettore le zeppe storiche di cui soffrono gli altri racconti. Il finale rivela l’incastro narrativo dell’intero romanzo, purtroppo prevedibile e deludente, con l’ennesimo esercizio narcisistico di uno scrittore che si contempla fare lo scrittore: “Così finisce il libro, con Ferguson che si accinge a scriverlo. Carico di due pesanti valigie e uno zaino, partì da New York il 3 febbraio”. Un ripiegamento solipsistico stridente per un romanzo che si apre su un rito di passaggio fondativo della storia americana e ha l’ambizione di espandersi per oltre novecento pagine. Così, l’aneddoto del cambio di nome a Ellis Island è ricondotto alla “battuta finale di una barzelletta sugli ebrei polacchi e russi che avevano preso una nave ed erano venuti in America”, spogliato della sua valenza archetipica per essere appiattito a consunto divertissement postmoderno.
Al di là tanto delle influenti pagine culturali americane (che lo hanno stroncato) quanto di un successo di pubblico di tutto riguardo (complice anche il digiuno di sette anni dall’ultima pubblicazione dell’autore), Auster può fare molto meglio di così. Lo dimostrano con nitore fulminante le pagine – splendide – in cui lo storyteller prende il sopravvento e dimentica la costruzione elefantiaca della sua creatura. “Sono i desideri su larga scala a fare la storia” dice il narratore del prologo di Underworld. Non per tutti. Sicuramente questa volta non per Auster.
cinz.scarpino@gmail.com
C Scarpino insegna letteratura nord-americana all’Università Statale di Milano