Occhi bianchi sul pianeta Moresco
recensione di Filippo Polenchi
dal numero di maggio 2016
Antonio Moresco
L’ADDIO
pp 288, € 15
Giunti, Firenze 2016
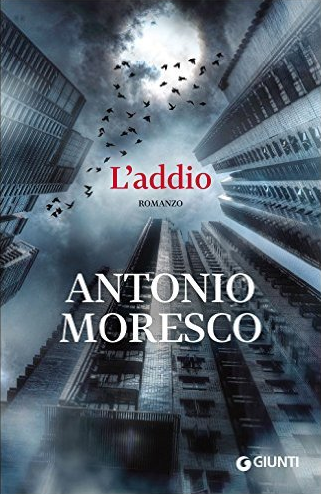 L’addio è una cometa disincagliata dalla costellazione degli Increati (Mondadori, 2015). È un pianto creaturale, una mostra delle atrocità. È una scrittura eventuale, probabilistica, condotta per quanti di energia. Sull’orizzonte degli eventi le forze piegano il diagramma cartesiano del mondo, gli opposti trovano una cucitura, fra arte popolare e arte sacra, fra Grand Guignol e le efferatezze di Francis Bacon, fra noir e arte marziale, surrealismo fauve e manga. Il dagherrotipo che emerge ha il bianco e nero dei sogni e dei capolavori del cinema muto, come La passione di Giovanna d’Arco di Dreyer (1928), nel quale recitava Antonin Artaud, il padre del “teatro della crudeltà”. Oggi nelle stesse fosforescenze brillano i nervi di Antonio Moresco.
L’addio è una cometa disincagliata dalla costellazione degli Increati (Mondadori, 2015). È un pianto creaturale, una mostra delle atrocità. È una scrittura eventuale, probabilistica, condotta per quanti di energia. Sull’orizzonte degli eventi le forze piegano il diagramma cartesiano del mondo, gli opposti trovano una cucitura, fra arte popolare e arte sacra, fra Grand Guignol e le efferatezze di Francis Bacon, fra noir e arte marziale, surrealismo fauve e manga. Il dagherrotipo che emerge ha il bianco e nero dei sogni e dei capolavori del cinema muto, come La passione di Giovanna d’Arco di Dreyer (1928), nel quale recitava Antonin Artaud, il padre del “teatro della crudeltà”. Oggi nelle stesse fosforescenze brillano i nervi di Antonio Moresco.
In questo suo ultimissimo romanzo esistono due città: quella dei vivi e quella dei morti. La polizia dei vivi ha una linea speciale con quella dei morti e quest’ultima aiuta la prima nel risolvere i casi, interrogando direttamente le vittime precipitate nell’altro mondo. D’Arco è uno “sbirro morto”, la cui missione è ritornare nella “città dei vivi” per indagare su una terribile mattanza. Ad aiutarlo un bimbo muto, con una cicatrice intorno al collo, a forma di collana di spine.
Il nome D’Arco richiama certo la pulzella d’Orléans, la guerriera in ascolto privilegiato del Divino (l’acustica è centrale nella vicenda: i bimbi della città dei morti, infatti, intonano un canto ultrasonico, udibile solo all’iniziato D’Arco), ma anche, per assonanza fonetica, l’aggettivo dark, quell’oscuro scrutare che domina la messinscena moreschiana.
Siamo intorno a un romanzo ossessionato dal rovesciamento, dai prototipi fotografici (quelli che colleziona uno degli assassini), dal negativo e positivo, dalla “visione”: “La luce di questa città è diversa da quella della città dei vivi (…) In quella dei morti ti sembra che non ci sia la luce ma ci vedi, in quella dei vivi ti sembra che ci sia la luce ma non ci vedi”.
Questa chimica dell’esposizione riecheggia negli occhi bianchi di D’Arco, residui adamantini di un incendio di fotoni, nella pelle bianca del bimbo-Virgilio che lo accompagna, nell’Uomo di Luce e nella mirabile epifania del teatro lirico. Il romanzo inizia con un prologo nel quale Antonio Moresco si rivolge al lettore e illustra la genesi e la missione di questa sua opera. Fin dall’esordio, insomma, siamo ben consapevoli di essere di fronte a un’enunciazione, a “colui che prende la parola”, come il biblico Qohèlet: “Ve l’ho già detto, io non mi sento tenuto a dire tutto, a raccontare tutto (…). Sono io che decido cosa voglio e posso raccontare (…) e non profanare”. “E anche questo racconto dove sta andando? Sta andando verso la fine o verso l’inizio?”.
Di fatto, però, il racconto tradizionale, che Moresco dileggia in continuazione, è insufficiente a descrivere il fato dell’uomo nell’abisso del cosmo: ogni progressione aristotelica e narratologica è altrettanto fallimentare e a essa si sostituisce la reiterazione. Nel nome della replica le crudeltà e i corpi martoriati cessano di colpire lo stomaco dopo poche pagine, in virtù di un dispositivo di rappresentazione che imita il diaframma totalmente aperto di certi banchi ottici. Queste immonde visioni alla Bosch si fanno prestissimo tableaux fissi e spietati, ma anche inerti. E di nuovo appare l’abbaglio della visione, l’accecamento dello sguardo inabissato, la danza macabra di un armamentario di rappresentazioni che non riesce a impedire la propria sconfitta.
La ripetizione, invece, appartiene alla fiaba (Fiaba d’amore di Moresco è del 2014, e del 2007 sono Le favole della Maria) e al mito, vitale e citatissimo: da Medea al Saturno che mangia i suoi figli. Saturno-Crono, appunto, figura disperante nella simmetria di uno specchio che non riflette ma divide due galassie. Saturno-Crono, infanticida come l’Uomo di Luce; divinità del tempo, che innesca una vera e propria febbre di domande, selvaggia e ritornante, nel fraseggio di dubbi agostiniani sul “male” e il peccato fondativo. Saturno-Crono, insomma: cruenta inquisizione sulla natura del tempo, naturale e narrativo, poiché senza elemento temporale non c’è narrativa.
Destino e racconto sono cuciti insieme. E non potrebbe essere altrimenti. Ma se è vero che un nucleo sorgivo di questo libro si chiamava Romanzo di fuga, dobbiamo pensare che la fuga ora si sia congelata in un addio, in una stasi definitiva? Eppure l’episodio dell’ologramma lirico nel teatro è l’apertura di un varco verso un’ulteriore urgenza misteriosa; è l’emergenza di una parola primitiva e affidata all’oralità, forse in sintonia con le teorie sul “villaggio globale”, ma è anche tesa a un ignoto da esplorare, come il fotogramma di cinema delle origini. Segno che forse le visioni di Moresco non sono finite.
filippo.polenchi@gmail.com
F Polenchi è redattore editoriale


