Giocare senza sosta e suonare il flauto alle feste delle fate
di Paola Carmagnani
Pubblicato nel 1902, questo strano e sconosciuto romanzo di James Matthew Barrie, L’uccellino bianco (ed. orig. 1902, trad. dall’inglese di Carla Vannuccini, a cura di Giovanna Mochi, con un testo di Beatrice Masini, pp. 284, € 18, Marsilio, Venezia 2020) contiene la prima versione di Peter Pan: prima della pièce teatrale che segnerà il successo del personaggio e prima di Peter and Wendy, il grande classico per ragazzi che cristallizzerà definitivamente il mito del bambino che non voleva crescere. Fu proprio l’enorme successo della pièce (Peter Pan, or the Boy Who Wouldn’t Grow Up, appunto) a determinare l’operazione editoriale che estrasse questa prima versione della storia dal romanzo che la conteneva, pubblicandola autonomamente nel 1906 con il titolo di Peter Pan in Kensington Gardens, in un’edizione accompagnata dalle bellissime illustrazioni di Arthur Rackham. Numerose sono state le edizioni italiane di questo primo Peter Pan, che Marsilio ripropone ora in una nuova traduzione e restituito al romanzo di cui fa parte.
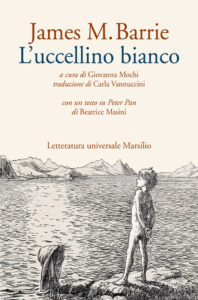 Situato nei sei capitoli centrali del romanzo, il primo Peter Pan assomiglia a una di quelle fairy tales tanto in voga in Inghilterra fra la metà del XIX secolo e i primi decenni del secolo successivo, ma la fiaba si costruisce qui intorno al nucleo di una vera e propria narrazione delle origini che offre al personaggio di Peter Pan gli elementi fondamentali del mito. “Domandate alla vostra mamma se quando era piccina conosceva Peter Pan, e vi dirà: ‘Diamine, tesoro mio, certo che lo conoscevo’”: così comincia il racconto, situando immediatamente il suo protagonista in un tempo che contiene passato, presente e futuro, all’interno del quale “la sua età non ha nessuna importanza, poiché in realtà è sempre la stessa”. In questa sua prima versione, Peter Pan è un neonato di una settimana appena, che inaugura la trasformazione della figura del dio Pan, simbolo dello spirito della natura estremamente popolare nella cultura tardo vittoriana ed edoardiana, nel mito moderno del dio bambino. Una notte dunque, il neonato Peter Pan fugge dalla finestra e se ne va volando dentro i cancelli chiusi dei Giardini di Kensington, dove resterà a vivere insieme agli uccelli e alle fate, nate dai frantumi della prima risata del primo bambino. “Se pensate che sia stato l’unico bambino a voler fuggire, significa che vi siete completamente dimenticati dei vostri primissimi giorni”, spiega il narratore: tutti i bambini infatti, desiderano volare via dalla finestra, perché prima di diventare umani tutti noi siamo stati uccelli e nelle prime settimane di vita conserviamo ancora un prurito là dove prima c’erano le ali. Quando i bambini piccoli riescono ad alzarsi in volo dalla loro culla però, c’è sempre una mamma pronta a riacciuffarli in tempo. “Tutti bambini tranne uno”, come reciterà poi il celebre incipit di Peter e Wendy, perché nessuna mamma del mondo avrebbe potuto trattenere l’“intrepido Peter Pan”, che nel momento stesso in cui vede gli alberi dei giardini dimentica completamente di essere un neonato, ritorna alla sua natura perduta di uccello e crede davvero di poter volare. È questa fede assoluta in una dimensione immaginaria, felicemente libera dal principio di realtà e dalle infinite frustrazioni che esso impone, a definire innanzi tutto l’infanzia del mito. “Chissà, forse saremmo tutti capaci di volare se confidassimo ciecamente nella nostra capacità di farlo”, dice qui il narratore, ed è a questa fede, che si perde crescendo, che fa appello anche il Peter Pan della pièce teatrale, rivolgendosi a un pubblico adulto e invitandolo a credere ancora: “Credete nelle fate? Dite in fretta che ci credete! Se ci credete, battete le mani!”.
Situato nei sei capitoli centrali del romanzo, il primo Peter Pan assomiglia a una di quelle fairy tales tanto in voga in Inghilterra fra la metà del XIX secolo e i primi decenni del secolo successivo, ma la fiaba si costruisce qui intorno al nucleo di una vera e propria narrazione delle origini che offre al personaggio di Peter Pan gli elementi fondamentali del mito. “Domandate alla vostra mamma se quando era piccina conosceva Peter Pan, e vi dirà: ‘Diamine, tesoro mio, certo che lo conoscevo’”: così comincia il racconto, situando immediatamente il suo protagonista in un tempo che contiene passato, presente e futuro, all’interno del quale “la sua età non ha nessuna importanza, poiché in realtà è sempre la stessa”. In questa sua prima versione, Peter Pan è un neonato di una settimana appena, che inaugura la trasformazione della figura del dio Pan, simbolo dello spirito della natura estremamente popolare nella cultura tardo vittoriana ed edoardiana, nel mito moderno del dio bambino. Una notte dunque, il neonato Peter Pan fugge dalla finestra e se ne va volando dentro i cancelli chiusi dei Giardini di Kensington, dove resterà a vivere insieme agli uccelli e alle fate, nate dai frantumi della prima risata del primo bambino. “Se pensate che sia stato l’unico bambino a voler fuggire, significa che vi siete completamente dimenticati dei vostri primissimi giorni”, spiega il narratore: tutti i bambini infatti, desiderano volare via dalla finestra, perché prima di diventare umani tutti noi siamo stati uccelli e nelle prime settimane di vita conserviamo ancora un prurito là dove prima c’erano le ali. Quando i bambini piccoli riescono ad alzarsi in volo dalla loro culla però, c’è sempre una mamma pronta a riacciuffarli in tempo. “Tutti bambini tranne uno”, come reciterà poi il celebre incipit di Peter e Wendy, perché nessuna mamma del mondo avrebbe potuto trattenere l’“intrepido Peter Pan”, che nel momento stesso in cui vede gli alberi dei giardini dimentica completamente di essere un neonato, ritorna alla sua natura perduta di uccello e crede davvero di poter volare. È questa fede assoluta in una dimensione immaginaria, felicemente libera dal principio di realtà e dalle infinite frustrazioni che esso impone, a definire innanzi tutto l’infanzia del mito. “Chissà, forse saremmo tutti capaci di volare se confidassimo ciecamente nella nostra capacità di farlo”, dice qui il narratore, ed è a questa fede, che si perde crescendo, che fa appello anche il Peter Pan della pièce teatrale, rivolgendosi a un pubblico adulto e invitandolo a credere ancora: “Credete nelle fate? Dite in fretta che ci credete! Se ci credete, battete le mani!”.
All’universo incantato dei giardini notturni il primo Peter Pan appartiene però solo a metà, perché è un “Betwixt-and-Between” (un Fraffrà, nella nuova traduzione), non più uccello e non più bambino. Condannato a un tragico senso di non appartenenza, Peter pensa di trascorrere momenti meravigliosi ai giardini (“e pensarlo è bello quasi come farlo”) ma gioca sempre da solo, raccogliendo i giocattoli abbandonati dai bambini veri, che conserva come tesori preziosi e non sa come usare. Oltre a giocare senza sosta e a suonare il flauto alle feste delle fate, Peter va in cerca dei bambini che sono caduti dalle carrozzine senza che nessuno se ne accorgesse, i bambini perduti che come lui sono rimasti nei giardini dopo l’ora di chiusura dei cancelli e che nel regno notturno delle fate potrebbero non riuscire a sopravvivere. Quando non riesce a salvarli scava per loro delle piccole fosse, usando una paletta abbandonata da qualche altro bambino: “È tutto molto triste”. Così si conclude la storia di Peter Pan, dove la felicità dell’eterna infanzia costantemente ribadita dal discorso è in realtà sempre intrisa dell’ombra della perdita. Notevolmente ridimensionata nelle versioni successive della storia, quest’ambivalenza riflette e condensa tutte le ambivalenze che pervadono il romanzo all’interno del quale il primo Peter Pan è contenuto. Un romanzo “senza né capo né coda”, lo definisce Giovanna Mochi nella sua bella Introduzione, un “caleidoscopio narrativo” dove “si avvicendano e si rifrangono tempi (passato presente e futuro), fatti e racconti, liste elenchi e filastrocche, sogni e fantasie, verità e bugie, animali e umani, la risata irrefrenabile dei bambini e l’umorismo caustico e cattivo dell’adulto”. Protagonista e narratore di questo romanzo è il capitano W., un bizzarro scapolo di mezza età (in cui è facile riconoscere la figura dello stesso Barrie) che fa amicizia con un bambino di nome David a cui racconterà la storia di Peter Pan. Lo spazio centrale di quest’amicizia sono gli stessi Giardini di Kensington, o meglio, la loro versione diurna: un mondo fatto di mamme, bambinaie e bambini veri, dove il capitano W. si avventura insieme a David e al fedele cane Porthos, lasciandosi felicemente alle spalle le stanze austere del suo club e la triste routine di una vita solitaria. Grazie a David, il capitano ritrova qui “i viali ridenti dell’infanzia, dove la memoria ci rammenta di aver corso una volta soltanto, un lungo giorno d’estate”, sperimentando allo stesso tempo la struggente nostalgia del tempo che passa, incombente come un’ombra minacciosa nell’incanto dei giardini, pronta a portarsi via David e tutti gli altri bambini per trasformarli in uomini e donne. Estensione immaginaria dei giardini diurni, quelli notturni si aprono così ad accogliere la storia del bambino che non cresce mai, figura del desiderio che riguarda non tanto l’infanzia quanto la sua perdita. C’è una scena fondamentale in questo primo Peter Pan, dove la storia notturna incontra quella diurna che la contiene nell’orizzonte comune della nostalgia. In questa scena, a cui faranno riferimento anche le versioni successive della storia, Peter ritorna a casa volando attraverso la stessa finestra da cui era fuggito e si siede sul letto della madre perduta, profondamente addormentata, triste e bellissima. Vorrebbe svegliarla, cancellare la sua tristezza e dirle che è tornato, ma la visione dei giardini attraverso la finestra aperta genera immediatamente un’altra nostalgia e Peter fugge di nuovo, perché c’è sempre tempo per smettere di giocare e rassegnarsi a essere un bambino come tutti gli altri. Quando torna a casa una seconda volta, però, la finestra è chiusa e da dietro le sbarre Peter guarda sua madre, di nuovo addormentata ma felice, che tiene fra le braccia un nuovo bambino. Nella vita, dice a Peter Pan il saggio corvo Salomone, non c’è mai una seconda occasione: “Quando raggiungiamo la finestra è ormai l’Ora di Chiusura. Le sbarre di ferro sono lì per tutta la vita”. Che siano quelle dei cancelli del giardino d’infanzia o quelle della finestra di casa, la vita ci conduce sempre di fronte a delle sbarre chiuse, e non solo ciò che è stato, ma anche ciò che avrebbe potuto essere e che non è stato, è definitivamente perduto. Dietro alla figura di Peter Pan emerge così quella di Timothy, il figlio che il capitano W. non ha mai avuto e che ha trasformato in un bambino immaginario. A questo bambino, che come Peter Pan “non era proprio come gli altri bambini”, il capitano dice addio nel momento stesso in cui compare David, il bambino in carne ed ossa “che mi chiama padre”. “Avrei tanto voluto che prima di andarsene potesse giocare una volta nei Giardini di Kensington”, dice il capitano lasciando volare via Timothy, che nei giardini giocherà allora sotto le sembianze di Peter Pan. È proprio Timothy l’“uccellino bianco” del titolo, e di questa prima figura del desiderio Peter Pan è l’espressione letterariamente compiuta: “gli uccellini bianchi sono quelli che non hanno mai avuto una madre” (o che l’hanno perduta), i bambini immaginari che non chiudono mai dietro di sé i cancelli del giardino d’infanzia e finiscono per andare a sbattere contro le sbarre di una finestra chiusa.
In un celebre saggio, Jacqueline Rose indicava in Peter Pan il paradigma dell’“impossibilità” della letteratura per l’infanzia, un genere dove il bambino (lettore, prodotto, destinatario) è in definitiva lo spazio di un’assenza sulla quale si proietta il desiderio dell’adulto (autore, narratore, creatore). Candidamente esposta nel primo Peter Pan e nella narrazione che lo contiene e lo produce, questa costruzione del desiderio assumerà l’aspetto “mistificatorio” della letteratura per l’infanzia soltanto nella successiva versione romanzesca del celebre Peter e Wendy, dove la natura profondamente tragica del ragazzo che non cresce mai è racchiusa e nascosta dentro l’estasi dell’avventura, insieme agli indiani e ai pirati dell’Isola-che-non-c’è. Qui invece, in quello che non è un romanzo per bambini, l’infanzia è esplicitamente una figura del desiderio, soprattutto nella misura in cui è il motore e la metafora della scrittura stessa. Motore della scrittura di un romanzo strampalato come i giochi e le storie dei bambini e di quella di Peter Pan, che si rivendica come un racconto a due mani idealmente capace di riempire lo spazio vuoto dell’incontro impossibile fra adulto e bambino di cui parlava Jacqueline Rose: “Prima io la racconto a lui, e poi lui la racconta a me, e siamo intesi che sarà una storia del tutto diversa; e poi io la racconto di nuovo con le sue aggiunte, e andiamo avanti così finché nessuno saprebbe dire se è la mia storia o la sua”. L’uccellino bianco del titolo è in definitiva il romanzo stesso che il capitano W. sta scrivendo, e che nell’ultimo capitolo presenta come finalmente concluso: non un “uccellino in carne e ossa”, il nuovo bambino che la madre di David sta aspettando, e in fondo nemmeno Timothy, l’uccellino immaginario, ma “il libro” di cui, dice il capitano, “io sono diventato il genitore”. È forse allora questo strano e dimenticato romanzo a offrire la risposta migliore alla presunta impossibilità della letteratura per l’infanzia, un genere dove l’infanzia (desiderata, rimpianta, assunta a modello di riferimento a cui guardare) è l’oggetto che apre lo spazio del desiderio da cui nasce la letteratura stessa, e che in questo spazio inventa linguaggi nuovi che appartengono tanto ai bambini quanto agli adulti che ricordano di essere stati bambini: uno spazio di mezzo, insomma, come quello in cui vive Peter Pan.
paola.carmagnani@unito.it
P. Carmagnani insegna letterature comparate all’Università di Torino


