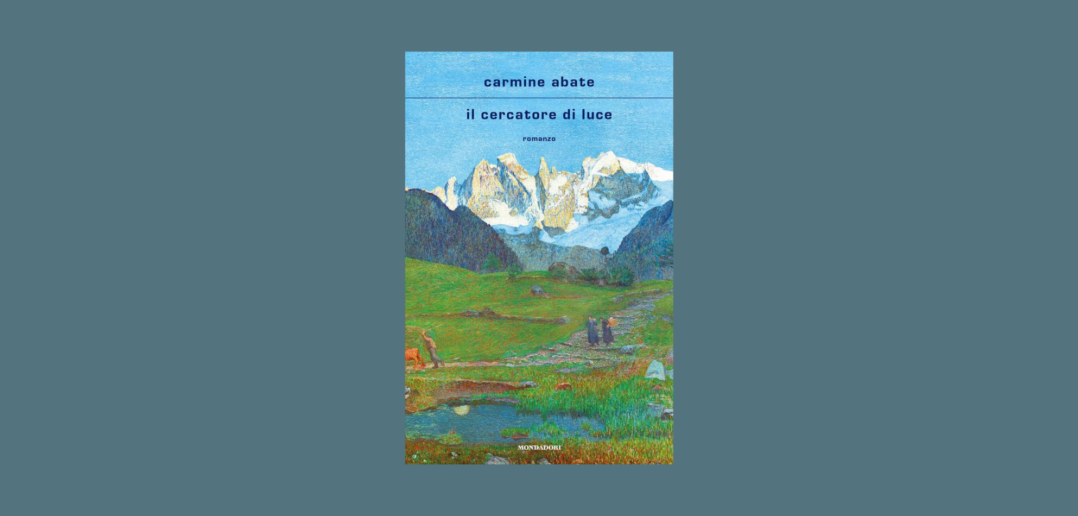recensione di Camilla Valletti
Carmine Abate
Il cercatore di luce
pp. 334, € 18,50,
Mondadori, Milano 2021
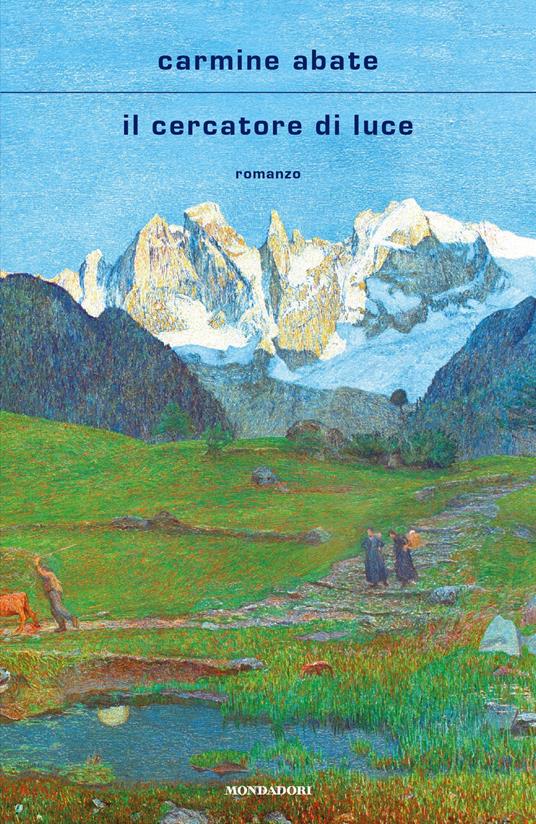 Carmine Abate, veterano delle nostre patrie lettere, esce con un lavoro a metà tra ricostruzione biografica e pura finzione. Residente ormai da molti anni in Trentino, dove ha affinato la sua militanza ambientale, proviene da Carfizzi, paese arberesh calabrese. Di tutta questa amalgama fatta di luoghi, di paesaggi e di percorsi umani, Il cacciatore di luce ne è lo specchio fedele. La vicenda si snoda su tre binari intrecciati attraverso momenti di raccordo: la formazione del giovane Carlo attraverso le sue estati a Scanuppia in Trentino, l’epopea del nonno ingegnere di cui il giovane porta il nome e la ricostruzione della carriera artistica e umana di Giovanni Segantini, il pittore che ha formalizzato l’idillio alpino innestandolo ad una vena scapigliata di fine secolo. Carlo, dodicenne, ha la grande fortuna di dormire nella baita di montagna davanti ad un quadro che gli muterà il corso della vita. Si tratta di una tela in cui Segantini ritrae una giovanissima madre con in braccio un neonato. I due sono immersi nel teatro di un alpeggio di alta quota, lei appare smarrita, forse è stata abbandonata dal marito. Carlo ne è subito attratto perché il quadro riflette, in parte, la sua condizione di figlio di una coppia in crisi profonda. Sarà la nonna Mona, originaria della Sila, a rimettere insieme la storia del quadro e quella della sua vita per trasmettere al nipote le basi su cui costruire una possibile identità di uomo futuro. Entrando nel regno della fiction, Abate immagina che il quadro sia stato donato da Segantini al nonno di Carlo, suo intimo amico ai tempi della residenza a Maloja, in Svizzera. Questo cortocircuito permette a Moma, in cui Abate pare volersi incarnare, di conciliare la sua vita di maestra e moglie emigrata in Trentino con quella di Giovanni Segantini, di cui l’anziana signora è diventata una grandissima esperta. La figura di Segantini, al tempo Giovanni Segante, si è nutrita di un vero e proprio processo di monumentalizzazione, iniziato proprio con la celebre Autobiografia corretta poi dalla sorella (un po’ come accade a Elizabeth Fortster-Nietzsche con gli scritti del fratello) in cui il mito di una nascita povera e errabonda è innalzato a postura e sguardo sul mondo. Abate se ne serve abbondantemente, lasciando che la lettura priva di malizia del giovane Carlo possa alimentare la sua immaginazione con quelle pagine così visionarie e improbabili.
Carmine Abate, veterano delle nostre patrie lettere, esce con un lavoro a metà tra ricostruzione biografica e pura finzione. Residente ormai da molti anni in Trentino, dove ha affinato la sua militanza ambientale, proviene da Carfizzi, paese arberesh calabrese. Di tutta questa amalgama fatta di luoghi, di paesaggi e di percorsi umani, Il cacciatore di luce ne è lo specchio fedele. La vicenda si snoda su tre binari intrecciati attraverso momenti di raccordo: la formazione del giovane Carlo attraverso le sue estati a Scanuppia in Trentino, l’epopea del nonno ingegnere di cui il giovane porta il nome e la ricostruzione della carriera artistica e umana di Giovanni Segantini, il pittore che ha formalizzato l’idillio alpino innestandolo ad una vena scapigliata di fine secolo. Carlo, dodicenne, ha la grande fortuna di dormire nella baita di montagna davanti ad un quadro che gli muterà il corso della vita. Si tratta di una tela in cui Segantini ritrae una giovanissima madre con in braccio un neonato. I due sono immersi nel teatro di un alpeggio di alta quota, lei appare smarrita, forse è stata abbandonata dal marito. Carlo ne è subito attratto perché il quadro riflette, in parte, la sua condizione di figlio di una coppia in crisi profonda. Sarà la nonna Mona, originaria della Sila, a rimettere insieme la storia del quadro e quella della sua vita per trasmettere al nipote le basi su cui costruire una possibile identità di uomo futuro. Entrando nel regno della fiction, Abate immagina che il quadro sia stato donato da Segantini al nonno di Carlo, suo intimo amico ai tempi della residenza a Maloja, in Svizzera. Questo cortocircuito permette a Moma, in cui Abate pare volersi incarnare, di conciliare la sua vita di maestra e moglie emigrata in Trentino con quella di Giovanni Segantini, di cui l’anziana signora è diventata una grandissima esperta. La figura di Segantini, al tempo Giovanni Segante, si è nutrita di un vero e proprio processo di monumentalizzazione, iniziato proprio con la celebre Autobiografia corretta poi dalla sorella (un po’ come accade a Elizabeth Fortster-Nietzsche con gli scritti del fratello) in cui il mito di una nascita povera e errabonda è innalzato a postura e sguardo sul mondo. Abate se ne serve abbondantemente, lasciando che la lettura priva di malizia del giovane Carlo possa alimentare la sua immaginazione con quelle pagine così visionarie e improbabili.
Fitte di episodi votivi, come quello in cui Segantini racconta l’esordio della sua arte, privo di qualsiasi orientamento di scuola, disegna il cadavere di una neonata per consolare la madre addolorata. Ai quadri strappalacrime dell’Autobiografia, Abate aggiunge il materiale ricavato dai moltissimi lavori critici dedicati al pittore tra cui quelli decisivi di Franz Servaes e Annie-Paule Quinsac. Ne emerge una ricostruzione molto dettagliata della vita di nomade a breve raggio del pittore, sempre inquieto, in moto per cercare tagli di luce e profili alpini che potessero offrire angolazioni inesplorate. Al seguito, la moglie, la bionda Bice Bugatti, sorella del celebre ebanista, conosciuta a Milano durante gli anni dell’accademia. Una donna colta, di maniere garbate che seppe addomesticare la parte torva di un personaggio cresciuto in un ambiente assai modesto, privo di istruzione ma dotato di un talento destinato ad emergere. Questa unione sentimentale e d’intenti, diviene anche il modello di amore compiuto per il giovane Carlo, il quale invece è stato testimone del disfacimento del patto matrimoniale dei genitori. Carlo, che elegge a modello di eroe personale il pittore tanto da tapparsi le orecchie per non ascoltare i commenti negativi di un professore di storia dell’arte – l’eccessivo panteismo, la raffigurazione della natura troppo idilliaca, la donna esalata solo come madre o condannata come lussuriosa, senza vie di mezzo – finirà per farne l’oggetto di studio della sua tesina per il diploma di maturità. Abate dunque si muove con disinvoltura dentro e fuori dal mito del pittore, e questo è forse uno dei maggiori pregi del romanzo. La capacità di raccontare il fascino di una figura del tutto priva di alfabetizzazione che assume i contorni di un modello etico spinto ben oltre il suo operato. Naturalmente molte pagine sono dedicate alla sua morte misteriosa, ai giorni che la precedettero, ai riti funebri ufficiali, e al compianto degli amici, dei colleghi. Sulla morte di Segantini, si innesta anche quella della novantenne Moma, circondata dagli affetti e ancora palpitante delle sue storie tramandate al nipote.
Romanzo articolato, ricchissimo di spunti, di dati, di siti, è una buona opportunità anche per i conoscitori di Segantini per avvicinare aspetti non così noti come quelli diffusi nei depliant turistici di Arco o di Zermatt che ancora insistono sulla bontà di matrice religiosa del pittore. Tra questi, le citazioni dalle lettere che Segantini scriveva a Bice. Per esempio, questa del 1 gennaio 1889: “Matino. Il primo giorno dell’anno e dunque oggi, credo che questo anno porterà un gran cambiamento nella mia vitta artistica. Speriamo sia in bene. Aprendo la finestra il Sole entrò involgendomi nella sua calda luce dorata, e tutto mi abbracio socchiusi gli occhi innebriato dal suo bacio di vita sentii che la vita è pur bella…il godimento della vita sta nel sapere amare, nel fondo dogni opera buona c’è l’amore”. Questa è la sua voce, fiduciosa nel cambiamento, involuta nella forma. Una voce che seppe infiammare anche una scrittrice della portata di Anna Maria Zuccari, in arte Neera, che vide nel pittore uno spirito affine, indomito, a caccia se non di luce, di una nuova forma espressiva.