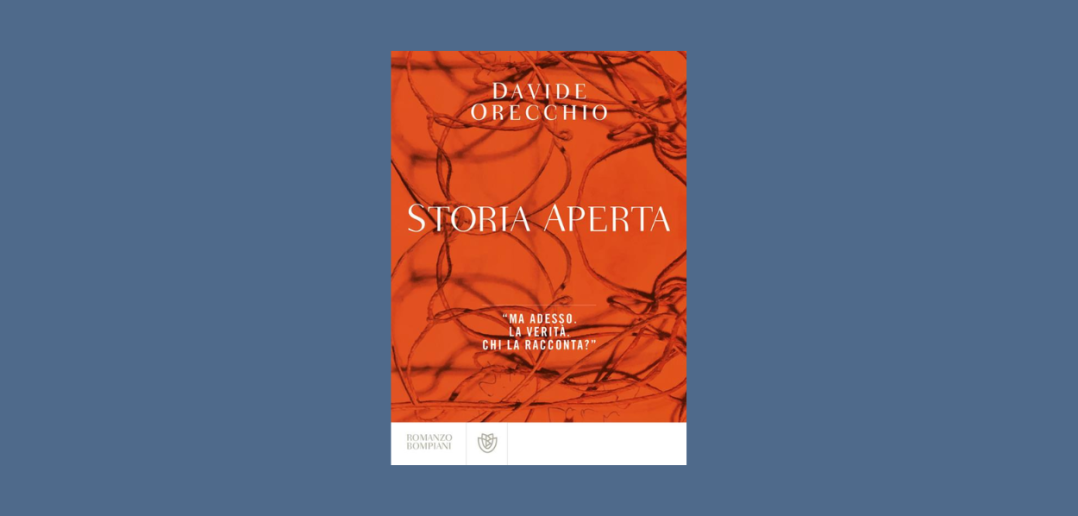L’invenzione delle vite
di Davide Orecchio
Dopo l’intervento di Giulia Caminito (cfr. “L’Indice” 2024, n. 9), riprendiamo con Davide Orecchio una nuova serie di interventi di scrittori e scrittrici sulle forme, i modi e gli intrecci di due tendenze centrali nella letteratura italiana contemporanea: le scritture del sé e le narrazioni storico-biografiche, tra fedeltà referenziale e invenzione fantastica.
Sistemi narrativi aperti
Una corrente serpeggia nella letteratura contemporanea. La potremmo definire la scuola dei sistemi narrativi aperti. Dotata di una forte vocazione all’accoglienza, esercita l’ospitalità. Dà voce alle voci degli altri, ma conserva l’arte di non perdere la propria. Sistemi narrativi aperti: ricorro a una formula che non ha cittadinanza narratologica ed è però utile a questo discorso. Si tratta di lingue autoriali che non sempre dicono “io”, ma che, anche quando lo fanno, inseriscono tessere esterne nel proprio racconto e sanno trasformarlo in polifonia. Potrei dire anche: sistemi onnivori, perché ciascuna fonte che si presenta può diventare una voce ospitata: dagli archivi, dai libri, dalle interviste, da un film, da una fotografia.
Le autrici e gli autori che praticano questa letteratura documentale si misurano spesso con la storia ma frequentano poco il romanzo storico tradizionale perché più portati (o costretti) a sperimentare architetture complesse che assumono, a volte, connotati barocchi. Domina il pastiche, la collazione, il coro. E l’autore, primus inter pares, governa il tutto.
Di solito, quando si traccia un identikit di questo genere letterario, è obbligatorio citare il “mostro sacro” che più di altri l’ha innescato a cavallo tra il secolo scorso e il nuovo. Lo farò anch’io, ovviamente: è W. G. Sebald; il Sebald di Gli emigrati e di Gli anelli di Saturno. Ma il canone è vivace, forse uno dei più fertili di questi anni. E annovera penne di altissima qualità. Si pensi a Svjatlana Aleksievič, premio Nobel nel 2015, che con Tempo di seconda mano e Preghiera per Černobyl’ (per citare solo due titoli) ha portato l’ascolto, la testimonianza, l’intervista a un livello di “persuasione” letteraria (e bellezza) mai visto prima. O al George Saunders di Lincoln nel Bardo, dove è la bibliografia a farsi letteratura entro uno schema a collage di citazioni che molti anni prima aveva adoperato un altro autore nordamericano, il William Least Heat-Moon di Prateria.
Per citare uno scrittore più giovane, in tempi recenti lo spagnolo Juan Gómez Bárcena (classe 1984) con Il resto è aria ha saputo creare un romanzo molto originale, dove la storia plurimillenaria di un villaggio cantabrico è affidata a un immenso racconto corale e sincronico nel quale tutti, ma proprio tutti prendono la parola: fossili, incisioni rupestri, documenti di archivio, memorie orali, lo stesso autore con la sua biografia.
Anche la narrativa italiana sta dando il suo contributo, e segue spesso le orme di un magistero, quello di Filippo Tuena, del quale non si può menzionare un singolo testo perché è l’opera omnia dello scrittore romano a indicare un metodo praticato con coerenza. Tra i titoli più recenti, direi quasi freschi di stampa, si può invece segnalare il Breviario delle Indie di Emanuele Canzaniello e Wilma, il romanzo a montaggio di testi dedicato al caso Montesi da Silvia Cassioli, un’autrice che è anche poetessa, e avrà forse presente la lezione di Charles Reznikoff.
Due generazioni e il mistero del passato
Se lo osserviamo come un fenomeno collettivo, possiamo azzardare un motivo comune: tra i più giovani e i più anziani abbiamo due generazioni che condividono l’attraversamento di due epoche, due secoli, forse due civiltà (anche riguardo all’uso delle fonti; non dimentichiamo che Internet ha stravolto il canone novecentesco filologico, ma questo tema merita una riflessione a parte), e camminano nel tempo storico con un occhio sulla nuca, rivolto al secolo della nascita, il Novecento, e con un occhio sulla fronte, per guardare avanti e non perdersi nel misterioso presente.
Ma anche il passato è misterioso. Ed è pesante. Sempre più pesante, con la sua mole documentale dalla inesorabile crescita. Si potrebbe dire, parafrasando un verso di Paul Celan, che il mondo non c’è più e lo si deve portare. Ma bisogna risvegliare la storia, raccontarla di nuovo, prestarle ascolto e darle voce. Discorso che vale per le percussioni ipnotiche tra Giappone e Regno Unito di David Peace o per i “vagabondaggi” nello spazio/tempo europeo di un altro premio Nobel, Olga Tokarczuk, così come per la “nostra” Helena Janeczek, solo per citare pochi nomi.
Costruirsi un metodo
È imbarazzante affermarlo così, all’improvviso, ma il discorso vale, si parva licet, anche per l’autore di questo articolo. Dopo avere tratteggiato un simile pantheon letterario, provare a salire sul carro può sembrare disdicevole, eppure l’“Indice”, offrendomi questo spazio, mi ha chiesto anche di aprire la porta del mio “laboratorio”, quindi proverò a farlo. Peccato che sia un esercizio estremamente faticoso: sempre, nel rivedere le pagine scritte in passato, mi accorgo di volerne salvare al massimo una su dieci.
In tre libri mi sono avvicinato al metodo dei sistemi narrativi aperti: Città distrutte, Mio padre la rivoluzione e Storia aperta. Due raccolte di racconti e un romanzo che seguono una lezione, come si sarà capito, che mi sembra tra le più innovative di questa stagione letteraria, dove il documento entra nello stile e lo modifica, e si fonde con l’invenzione in una combinazione di metodi, tradizioni e registri.
L’esordio di Città distrutte è stato l’innesco, ma era pur sempre una raccolta di biografie. Le “voci degli altri” – i testi, le fonti – entravano in singoli capitoli conclusi, appunto ritratti biografici. Con Mio padre la rivoluzione il metodo si è evoluto verso un concept più coeso, centrato sul mito della rivoluzione russa, filo conduttore che attraversa il volume. Anche in questo caso ho seguito la strada dell’ibridazione tra materiali storici e invenzione. Spesso ho affidato la narrazione a un “noi” che vuole rappresentare il punto di vista collettivo della posterità: noi tutti, i vivi, chiamati a confrontarci con un passato che continua a interrogare le nostre coscienze. Un esempio dal libro può essere Cast: pura collazione di citazioni. Ma è pur sempre un racconto. La breve storia di un’idea, l’utopia rivoluzionaria, e del suo fallimento nella messa in opera bolscevica. Si comincia col Manifesto di Marx (1848) e si conclude con un passo della storica Sheila Fitzpatrick (2017).
Come tradurre la storiografia in narrazione?
In Storia aperta, ultimo e più impegnativo lavoro della serie, ho usato lo stesso metodo ma in modo più pervasivo. Anche questa storia novecentesca di Pietro Migliorisi, alter ego di mio padre, è a lungo raccontata da un noi narrante. Ed è un sistema aperto che ospita innumerevoli fonti: le carte paterne, la memorialistica, documenti di archivio, carte dagli archivi militari per le campagne d’Africa, Grecia, Sicilia, diari di guerra, diari della Resistenza, storiografia. Ma queste voci devono diventare elementi narrativi, coagularsi nello stile e vivificarlo. Il noi che racconta nella prima parte e l’io che raccoglie il testimone nella seconda sono i “co-narratori” di un impasto di storie, in una polifonia che prova a essere omogenea nella sua eterogeneità.
Tra le complicazioni che ho dovuto affrontare c’è la seguente. La prima parte del romanzo si svolge durante l’epoca fascista e accompagna il percorso di un giovane intellettuale della “generazione del lungo viaggio”. È un “personaggio-tipo”, onerato dal compito di rappresentare molti giovani di quella leva. Cresce sotto la dittatura, educato nei suoi sistemi scolastici e culturali. Il suo cammino sembra avviato verso una piena adesione al fascismo, ma culmina in un rifiuto progressivo e consapevole, maturato attraverso esperienze cruciali che si concludono nella Resistenza. Da fascista, diventa antifascista.
Questo viaggio è individuale ma appunto tipico di una generazione. Per questo, narrarlo ha significato affrontare una complessità, quella di datare con precisione l’adesione all’antifascismo in un percorso che vuole essere paradigmatico. Le fonti autobiografiche (diari, memorie e interviste) spesso retrodatano la scelta di campo. Operazione che ha chiare motivazioni di “sopravvivenza” politica – visto che gran parte di quei testi risale agli anni successivi alla Liberazione – o di messa in posa della propria biografia. Davvero è una questione determinante. Nonostante la prossimità tra un anno e l’altro, diventare antifascista nel 1933, o nel 1935, o nel 1938, o nel 1943, o nel ’44, non è affatto la stessa cosa, com’è ovvio.
Ma nell’intero equivoco del “fascismo di sinistra” al quale quei giovani appartenevano c’è un di più: un’ambiguità di fondo che – anche riuscendo a individuare le più raffinate pratiche dissimulatrici, indispensabili per una vita in regime fascista – non si può proprio risolvere. Ogni loro parola scritta, letta, riverberata, ogni loro atteggiamento politico e culturale si potrebbe interpretare come “superfascista” (in senso sociale e antimonarchico) o come cripto-socialista o proto-comunista.
Nella narrazione, quindi, dovevo tenere conto di due letture: la classica impostazione dettata dalle memorie di Ruggero Zangrandi da un lato e, dall’altro, le revisioni storiche degli ultimi decenni, che hanno ridimensionato il coraggio e l’anticipazione di alcuni esponenti di quella leva. In più, dovevo fare emergere l’insolubile ambiguità accennata sopra. Ho provato a farlo trasformando le diverse interpretazioni storiografiche in personaggi, o meglio in “libri-personaggio” che intervengono nel romanzo e si prendono il compito di affermare una tesi, ma devono farlo seguendo schemi narrativi. L’Enciclopedia del fascismo o i Bestiari fascisti, per citare due esempi, prendono vita, parlano a voce alta, agiscono, si rincorrono e azzuffano. Ho adottato, insomma, una drammatizzazione delle fonti; ed è, evidentemente, una soluzione empirica.
Questo è quanto, dal “laboratorio”. Trovare la voce e lo stile più adatti alla resa di una storia è il problema principale che uno scrittore deve affrontare. Ed è sempre un problema pratico. Forse più complesso quando si vuole dare voce alle voci degli altri.
D. Orecchio è scrittore