Nome, luoghi, lingua e sapori: le metamorfosi necessarie
intervista a Monique Truong di Daniela Fargione
dal numero di dicembre 2016
Ospite speciale del primo festival culturale “Alla tavola dei migranti” è stata la scrittrice Monique Truong, una delle voci più significative e accreditate della letteratura asiatico-americana contemporanea. Rifugiata dal Vietnam del sud alla vigilia della caduta di Saigon, nel 1995 Truong ottiene una laurea in letteratura alla Yale University e successivamente un dottorato in giurisprudenza alla Columbia University School of Law. Tuttavia, la sua carriera di studi nell’ambito della proprietà intellettuale ha breve corso, poiché Truong decide di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura creativa. Autrice di numerosi saggi e contributi a riviste di gastronomia (“New York Times”, “T Magazine”, “Real Simple”, “Town & Country”, “Condé Nast Traveler”, “Allure”, “Saveur”, “Food & Wine”, “Gourmet”) e di due romanzi (il terzo, The Sweetest Fruits, è di imminente pubblicazione per i tipi della Viking), l’autrice ricorre spesso all’immagine del cibo per indagare la condizione dei rifugiati e le loro imprescindibili metamorfosi nella cultura di arrivo.
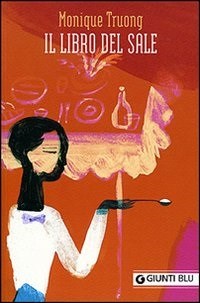 Se il cibo – come ben spiega Roland Barthes – è un sistema comunicativo, allora si può pensare che sia anche suscettibile di traduzione, vale a dire di un passaggio da un sistema codificato a un altro, che richiede necessariamente trasformazioni e adattamenti. È attraverso questo processo traduttivo che i vari personaggi delle storie riescono spesso a inventare per sé una nuova configurazione identitaria in grado di compensare l’imposta invisibilità di cui soffrono, nonostante l’evidente “asiaticità” impressa sui loro corpi. Succede, per esempio, a Binh, un giovane cuoco vietnamita alle dipendenze della famosa coppia letteraria formata da Gertrude Stein e Alice B. Toklas, e protagonista del pluripremiato The Book of Salt (Houghton Mifflin, 2003; Il libro del sale, Giunti, 2007). Siamo nella Parigi del 1934 e il romanzo si apre alla Gare du Nord, dove le due mesdames sono in procinto di intraprendere un lungo viaggio che le riporterà, dopo trent’anni di autoesilio, nel loro paese. Chef Binh, che ha lavorato nella loro cucina per cinque anni, si trova a dover prendere una decisione cruciale: seguirle in America, tornare in Vietnam da cui era stato espulso a causa della sua omosessualità, oppure fermarsi a Parigi. Prima di svelare la decisione finale, Truong coinvolge i suoi lettori in un viaggio à rebours nella memoria, ripercorrendo quegli ultimi cinque anni parigini e l’infanzia che Binh ha trascorso a Saigon.
Se il cibo – come ben spiega Roland Barthes – è un sistema comunicativo, allora si può pensare che sia anche suscettibile di traduzione, vale a dire di un passaggio da un sistema codificato a un altro, che richiede necessariamente trasformazioni e adattamenti. È attraverso questo processo traduttivo che i vari personaggi delle storie riescono spesso a inventare per sé una nuova configurazione identitaria in grado di compensare l’imposta invisibilità di cui soffrono, nonostante l’evidente “asiaticità” impressa sui loro corpi. Succede, per esempio, a Binh, un giovane cuoco vietnamita alle dipendenze della famosa coppia letteraria formata da Gertrude Stein e Alice B. Toklas, e protagonista del pluripremiato The Book of Salt (Houghton Mifflin, 2003; Il libro del sale, Giunti, 2007). Siamo nella Parigi del 1934 e il romanzo si apre alla Gare du Nord, dove le due mesdames sono in procinto di intraprendere un lungo viaggio che le riporterà, dopo trent’anni di autoesilio, nel loro paese. Chef Binh, che ha lavorato nella loro cucina per cinque anni, si trova a dover prendere una decisione cruciale: seguirle in America, tornare in Vietnam da cui era stato espulso a causa della sua omosessualità, oppure fermarsi a Parigi. Prima di svelare la decisione finale, Truong coinvolge i suoi lettori in un viaggio à rebours nella memoria, ripercorrendo quegli ultimi cinque anni parigini e l’infanzia che Binh ha trascorso a Saigon.
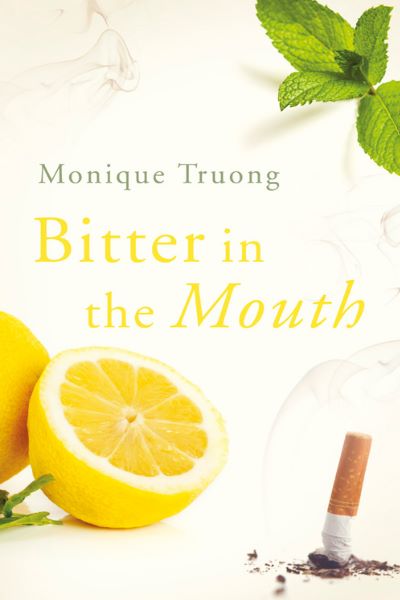 In Bitter in the Mouth (Random House, 2010), un romanzo di formazione non ancora tradotto in italiano, Truong esplora invece il concetto di straniamento in maniera del tutto inconsueta. Ambientato negli anni settanta a Boiling Springs, nella Carolina del nord, il libro narra le vicende di Linda, una ragazzina asiatica custode di numerosi segreti tra cui una violenza sessuale, la sua adozione e soprattutto la sinestesia, un disturbo neurologico che le provoca un’involontaria contaminazione dei sensi coinvolgendo, nel suo caso specifico, il linguaggio e il gusto. La casuale associazione di parole a cibi è per lei un’altra forma di “alterità” e dunque un’altra fonte di disagio, sebbene nella conclusione del romanzo, lungi dal dimostrarsi una disabilità, la sinestesia si riveli essere la chiave ideale per comprendere i rapporti conflittuali con le persone più importanti della sua vita: Kelly, l’amica del cuore turbata e sovrappeso; il prozio omosessuale; la madre distante e anaffettiva.
In Bitter in the Mouth (Random House, 2010), un romanzo di formazione non ancora tradotto in italiano, Truong esplora invece il concetto di straniamento in maniera del tutto inconsueta. Ambientato negli anni settanta a Boiling Springs, nella Carolina del nord, il libro narra le vicende di Linda, una ragazzina asiatica custode di numerosi segreti tra cui una violenza sessuale, la sua adozione e soprattutto la sinestesia, un disturbo neurologico che le provoca un’involontaria contaminazione dei sensi coinvolgendo, nel suo caso specifico, il linguaggio e il gusto. La casuale associazione di parole a cibi è per lei un’altra forma di “alterità” e dunque un’altra fonte di disagio, sebbene nella conclusione del romanzo, lungi dal dimostrarsi una disabilità, la sinestesia si riveli essere la chiave ideale per comprendere i rapporti conflittuali con le persone più importanti della sua vita: Kelly, l’amica del cuore turbata e sovrappeso; il prozio omosessuale; la madre distante e anaffettiva.
Rielaborando molte vicende autobiografiche, Monique Truong riesce ad offrire nuove riflessioni sugli intrecci di cibo, linguaggio e identità, come ben dimostra la conversazione avvenuta al Festival “Alla tavola delle migranti” di cui si propongono, di seguito, alcuni passaggi significativi.
Quando nel 2015 la Southern Foodways Alliance, un’istituzione accademica presso la University of Mississippi, ha invitato Monique Truong a inaugurare il Simposio annuale, la scrittrice ha aperto il suo intervento con una dichiarazione rivelatoria: “Sono nata a Saigon, nel Vietnam del sud, nel 1968. Sono rinata a Boiling Springs, nella Carolina del nord, nel 1975. Non si è trattato di una rinascita nel senso religioso che si dà al termine, bensì di quella trasformazione che rifugiati e immigrati si trovano a dover affrontare al momento del loro arrivo negli Stati Uniti, una trasformazione che richiede una nuova lingua, spesso un nuovo nome e certamente nuovo pane quotidiano. Per forza di cose, ci trasformiamo in qualcun altro, in un’altra persona”. Monique, può raccontarci la sua storia di rifugiata e le sue personali trasformazioni?
La mia famiglia e io siamo arrivati negli Stati Uniti nel 1975 come rifugiati dalla guerra del Vietnam. Io sono partita con mia madre una settimana prima della caduta di Saigon e successivamente anche mio padre è riuscito a lasciare il paese e a raggiungerci. Per molti versi, siamo stati fortunati perché siamo riusciti a fuggire con il primo flusso di rifugiati e siamo stati ospitati a Camp Pandleton, un campo profughi in California, in attesa di uno sponsor, di solito una chiesa, un’associazione o talvolta una famiglia. La sponsorizzazione sarebbe durata fino a quando non fossimo stati in grado di trovare un lavoro, di conoscere la lingua, insomma di diventare autosufficienti.
Mia madre e io abbiamo viaggiato in aereo, ma per molti altri rifugiati che sono venuti dopo di noi il viaggio in nave è stato pieno di insidie, talvolta fatale. Negli Stati Uniti ci si riferisce a questi profughi con l’appellativo boat people e mio padre è stato uno di questi. Un’altra fortuna è stata che i miei genitori sapessero parlare bene l’inglese e il francese, perciò l’arrivo negli Stati Uniti è stato per loro meno traumatico che per altri.
Il nostro sponsor era un conoscente di mio padre e faceva l’impresario in Vietnam. Viveva con la famiglia a Boiling Springs, una piccola cittadina della Carolina del nord, dove ho ambientato Bitter in the Mouth, il mio secondo romanzo. È lì che siamo vissuti una volta arrivati in America, un posto davvero minuscolo, al punto che spesso, quando scrivo della mia esperienza nel sud degli Stati Uniti, lo definisco “una lentiggine”. È lì che sono andata a scuola e ho imparato l’inglese, ma soprattutto è lì che ho capito di non essere più “normale”.
Lei ha esordito con una citazione che ci parla delle trasformazioni che molti emigrati e rifugiati sono costretti ad affrontare nel nuovo paese, così come ho dovuto fare io stessa: l’acquisizione di una nuova lingua, naturalmente, ma anche di un nome nuovo. Il mio nome in vietnamita ha una pronuncia tale da far supporre che cominci con la “Y”. In realtà si scrive “D-u-n-g”. Chi conosce l’inglese sa che questa parola si riferisce allo sterco degli animali e, come potete immaginare, non è certo con questo nome che i miei genitori volevano mandarmi a una scuola americana. Per fortuna, mi hanno permesso di usare il nome con cui ero stata battezzata, un nome cattolico: Monique. E così, all’improvviso, non ero più la stessa persona di prima: il nome di famiglia, il nome degli affetti e dell’amore era scomparso dalla mia vita e io, a mia volta, mi ero trasformata in un’altra.
Ecco l’inizio di una grande metamorfosi che coinvolge molti aspetti della vita di Monique: il luogo, il nome, la lingua. Essendo però questo un Festival sul cibo, vorrei anche chiederle se e in che modo il cibo abbia influito in questa sua trasformazione.
Sì, “il mio nuovo pane quotidiano”… Beh, prima di tutto devo ammettere di aver compreso fin troppo presto che il cibo con il quale ero cresciuta era introvabile. E dico “introvabile” perché nel 1975, in quella cittadina del sud rurale americano, quel cibo non lo si poteva comprare proprio da nessuna parte. Dovevamo guidare per una giornata intera per arrivare a Washington, D.C. e poter acquistare alcuni alimenti di base: il riso, per esempio. Ora, teniamo a mente che la Carolina del nord è uno stato in cui il riso viene coltivato da sempre. A quei tempi, però, era impossibile trovare del riso che non fosse semilavorato, una qualità che permette una cottura veloce, ma che ne modifica la consistenza.
Anche il cibo che mangiavano i miei compagni di scuola era completamente diverso dal cibo che mangiavo io. E di qui è nato il mio “pensiero magico”: ero convinta che se solo avessi potuto mangiare qualcosa di tipicamente americano – gli hamburger, per esempio, o quei dolci ricoperti di glassa, insomma tutti quei cibi così diversi da quelli che mi preparava mia madre, una cuoca eccellente ma che cucinava alla francese – allora anch’io, da un giorno all’altro, mi sarei trasformata in americana. Quel cibo era per me una pozione magica, qualcosa che desideravo con tutta me stessa.
In un’intervista rilasciata a “The PEN Ten” parla di cibo come di una vera e propria “ossessione”, ma dice anche: “non mi interessa particolarmente ciò che si trova nel piatto, bensì l’atto del cucinare e del consumare il cibo come in un rituale, il linguaggio segreto dei piatti e dei loro ingredienti, e ‘quella linea sottile che separa il lavoro dallo sfruttamento’”. Che cosa intendeva con quest’ultima frase?
Penso spesso a questo fenomeno perché nel mondo della ristorazione, e non mi riferisco ai grandi chef, osannati e riveriti in TV o sulla stampa bensì alle persone addette a lavare e tagliare le verdure, a occuparsi cioè della mise en place, provvede spesso la massa di immigrati sans papier che non ricevono un salario adeguato, ai quali non si garantisce un’assicurazione che copra le spese sanitarie, da cui ci si aspetta che lavorino anche quando si ammalano. Si tratta, secondo la grande industria del cibo negli Stati Uniti, di una tipologia di sfruttamento necessario, necessario ovviamente per il sistema, perché altrimenti i ristoratori sarebbero costretti a far lievitare i prezzi delle portate che vendono. È una forma di sfruttamento alla quale non sono disposta a partecipare, ma alla quale, volente o nolente, tutti noi partecipiamo sia in maniera inconsapevole, sia con la falsa convinzione che si tratta di una esigenza per potersi garantire cibo di qualità. Preferisco pagare dieci dollari in più per il pasto che consumo se sono certa che il personale di cucina è trattato con la dignità a cui ogni essere umano ha diritto.
Spesso afferma nei suoi scritti che “il passato si conserva in bocca”, ma allo stesso tempo ci ricorda che la nostalgia può essere una compagna di cui diffidare. Quale relazione esiste tra il cibo e la memoria?
La nostalgia è il desiderio del passato che a sua volta può essere provocato da un senso di insoddisfazione per il presente. Credo che bisognerebbe sempre vivere con i piedi ben piantati nel presente, ma si tratta di una condizione difficile per gli immigrati o i rifugiati o per chiunque viva lontano da casa. Ed è difficile perché il presente, per queste persone, equivale spesso a disagio. Si finisce così col creare un passato fantastico ed è il sapore di questa fantasia che suscita il mio interesse.
daniela.fargione@unito.it
D Fargione insegna letteratura angloamericana all’Università di Torino


