Romanzo melvilliano
di Daniela Fargione
Richard Powers
IL SUSSURRO DEL MONDO
ed. orig. 2018, trad. dall’inglese di Licia Vighi,
pp. 658, € 22,
La nave di Teseo, Milano 2019
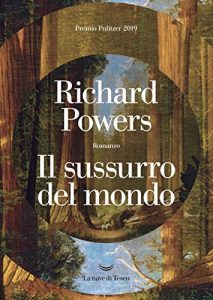 Il romanzo di Richard Powers e premio Pulitzer per la narrativa, è un ideale ritorno alla sua prima pubblicazione, Tre contadini che vanno a ballare (1985, Bollati Boringhieri, 1991), e all’omonima fotografia che August Sander scattò nel 1914. Si tratta, ricordiamo, dell’immagine di tre giovani in cammino verso un ballo campestre, immortalati nei loro improbabili vestiti della festa mentre rivolgono all’obiettivo uno sguardo compiaciuto e innocente, del tutto ignari che ad attenderli, al fondo del sentiero, vi sarebbe stata la danza sanguinosa e mortifera della Grande guerra. Il fotografo tedesco aveva incluso questo scatto in un progetto imponente (e mai completato) dal titolo Uomini del ventesimo secolo, un immenso archivio che offriva una sorta di mappatura della società tedesca ai tempi della repubblica di Weimar, un’impresa che Sander aveva perseguito facendosi guidare dal “fanatismo di chi insegue la verità”. Ora, se proviamo a sostituire la tipologia umana con la tipologia delle piante (se ne citano 17 solo nelle prime due pagine del libro), l’analisi fisiognomica con quella fitobiografica, il tempo degli uomini con il tempo degli alberi, possiamo cominciare a intuire la portata di The Overstory, titolo originale del libro che rimanda sia alla prospettiva dall’alto, sia alla “sovrastoria” del mondo, ovvero alla cornice temporale di circa quattro miliardi di anni in cui la specie umana non è che una comparsa e per giunta fugace.
Il romanzo di Richard Powers e premio Pulitzer per la narrativa, è un ideale ritorno alla sua prima pubblicazione, Tre contadini che vanno a ballare (1985, Bollati Boringhieri, 1991), e all’omonima fotografia che August Sander scattò nel 1914. Si tratta, ricordiamo, dell’immagine di tre giovani in cammino verso un ballo campestre, immortalati nei loro improbabili vestiti della festa mentre rivolgono all’obiettivo uno sguardo compiaciuto e innocente, del tutto ignari che ad attenderli, al fondo del sentiero, vi sarebbe stata la danza sanguinosa e mortifera della Grande guerra. Il fotografo tedesco aveva incluso questo scatto in un progetto imponente (e mai completato) dal titolo Uomini del ventesimo secolo, un immenso archivio che offriva una sorta di mappatura della società tedesca ai tempi della repubblica di Weimar, un’impresa che Sander aveva perseguito facendosi guidare dal “fanatismo di chi insegue la verità”. Ora, se proviamo a sostituire la tipologia umana con la tipologia delle piante (se ne citano 17 solo nelle prime due pagine del libro), l’analisi fisiognomica con quella fitobiografica, il tempo degli uomini con il tempo degli alberi, possiamo cominciare a intuire la portata di The Overstory, titolo originale del libro che rimanda sia alla prospettiva dall’alto, sia alla “sovrastoria” del mondo, ovvero alla cornice temporale di circa quattro miliardi di anni in cui la specie umana non è che una comparsa e per giunta fugace.
In molti hanno definito Il sussurro del mondo un esempio di grande romanzo americano, “melvilliano” secondo Margaret Atwood, un libro sulla transitorietà degli umani e sulla incessante attività di registrazione del tempo da parte degli alberi che, paradossalmente, il tempo lo svelano quando smettono di vivere: la dendrocronologia, che attraverso lo spessore degli anelli può risalire indietro di centinaia e a volte migliaia di anni, è infatti una pratica post-mortem. In una recensione di Gregory Day che apre con un’invettiva all’attuale “curva d’attenzione digitalmente aumentata” e alle costanti incursioni di ding elettronici nella quotidianità delle nostre esistenze, si legge che un antidoto è offerto dai grandi romanzi che garantiscono la longue durée: nel nostro caso 658 pagine di erudizione enciclopedica sapientemente distribuita in una narrazione “ossessionata dall’erotismo del sapere” a detta dello stesso autore. L’altra urgenza, di natura etica, è quella di imitare l’impresa di August Sander e di avviare così un processo di documentazione degli alberi, un archivio che si costruisce sui concetti di storia, verità, memoria, empatia, un’operazione dettata dall’ombra incombente della morte, dalla minaccia costante dell’estinzione: “L’arte” dichiara Powers in un’intervista “è un modo per spiegare cosa significa essere vivi, mentre il tratto più rilevante dell’esistenza è dato dalle inimmaginabili probabilità contrarie. Perché a ogni modalità dell’essere corrisponde un’infinità di modi del non essere”.
I nove personaggi umani della storia rappresentano nove archetipi dell’antropocene, ciascuno dei quali è accoppiato a un “tipo” arboreo: a Nicholas Hoel, artista ambientale di origini norvegesi, corrisponde il castagno americano, albero che sopravvive alla morìa che investe la fattoria di famiglia nell’Iowa; l’ingegnere Mimi Ma, per metà cinese, è legata al gelso, albero con due sessi che il padre pianta nel giardino dietro casa; ad Adam Appich, studente di psicologia, è assegnato l’acero; Douglas Pavlicek, pilota abbattuto nella guerra del Vietnam, si salva cadendo su un baniano; Neelay Mehta, figlio di un ingegnere della Sylicon Valley e genio dell’informatica a sua volta, è costretto su una sedia a rotelle dopo essere caduto da una quercia; a Patricia Westerford, botanica visionaria, si deve la scoperta di un sistema di comunicazione delle piante e di altri segreti inscritti sul tronco di un faggio. Esattamente come nell’archivio di Sander, queste combinazioni di umano e arboreo non hanno nulla di passivo; piuttosto, veicolando esperienza storica, conoscenza e significato, dimostrano di avere anch’esse una voce: come una sorta di canto spirituale che apre ciascuna delle quattro sezioni del libro – Radici, Tronco, Chioma e Semi – le voci coinvolgono i personaggi (e di conseguenza noi lettori) in un’esperienza di ascolto ben lontana dall’antropocentrismo che ci contraddistingue. Come nella scena di apertura, per esempio: una donna, seduta per terra con le spalle appoggiate al tronco di un pino, ascolta l’albero che “sta dicendo delle cose, in parole che precedono le parole (…). La tua specie non riesce mai a vederci nella nostra interezza. Vi manca la metà, e anche di più. C’è sempre tanto sottoterra quanto sopra la superficie (…) È questo il guaio con le persone, il problema delle loro radici. La vita scorre di fianco a loro, invisibile”.
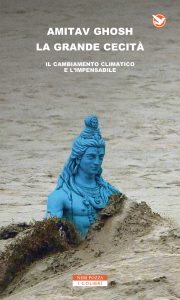 In una sorta di incontro sinergico con le piante, molti dei personaggi umani di Powers vivono ciò che nel saggio La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (Neri Pozza, 2017, cfr. “L’Indice, 2017, n. 7-8) Amitav Ghosh definisce “riconoscimento”, ovvero il passaggio dall’ignoranza alla conoscenza: “il riconoscimento avviene quando una consapevolezza anteriore balena dinanzi a noi, provocando un repentino mutamento nella comprensione di ciò che si ha davanti (…); deriva dal prendere coscienza di una potenzialità ancora inespressa”. Ghosh riconosce questa presenza che lo circonda mentre scrive della grande foresta di mangrovie che ricopre le Sundarbans, nel delta bengalese; in maniera molto simile Patricia Westerford (detta Patty-la-Pianta), studiando le foreste americane comprende che gli alberi “stanno cercando di attirare la nostra attenzione” e che, paradossalmente, è più facile sentirli piuttosto che vederli. In più di un’occasione Powers suggerisce che la nostra incapacità di vedere gli alberi ci rende specie “cieca” e non solo perché non sappiamo distinguere “un noce nero da un frassino bianco”, ma perché ci sfuggono le grandi complessità di interi biomi: anche gli alberi, come altre creature non umane, hanno capacità di azione, personalità e scopi che noi umani tendiamo a negare. Nelle storie intrecciate del libro, il personaggio di Adam Appich, accumulatore compulsivo e psicologo, offre insieme a Patricia il miglior contributo al processo di “rimozione della cecità”. Convinto sin da bambino che l’umanità sia “profondamente malata” e che “la specie non durerà molto”, si specializza nel bias (o pregiudizio) di conferma, l’errore cognitivo che ci porta a selezionare e interpretare informazioni in modo da attribuire maggiore credibilità a quelle che confermano la nostra convinzione iniziale, facendoci ignorare quelle che la contraddicono. In una delle scene finali del romanzo Adam, in compagnia di attivisti ambientali radunati intorno a un falò, afferma che persino le migliori argomentazioni al mondo non sono in grado di far cambiare idea alle persone. L’unica cosa che riesca a farlo è una buona storia che occasionalmente può persino essere scritta sulla corteccia di un albero come Patricia apprende dal padre il quale “le spiega come il termine beech, faggio, si trasforma nella parola book, libro, nel continuo evolversi del linguaggio. Come libro si sia sviluppato dalle radici del faggio, molto tempo addietro nella lingua madre. Come la corteccia del faggio ospitasse le prime parole sanscrite (…) Ma da dove proverrà la mole di un libro così voluminoso?” Libro, peraltro, che continuerà a scriversi da solo persino dopo che noi, umani, saremo estinti. Ecco allora che quando Douggie Pavlicek si chiede cosa sia andato storto con l’umanità – che è poi la questione centrale dell’intero romanzo – troviamo risposta proprio qui: dall’alto del nostro falso eccezionalismo, non siamo capaci di venirne a capo perché abbiamo smesso di prestare attenzione alle parole e alle storie. “Ascolta,” sussurra il pino alla donna seduta per terra e appoggiata al tronco, “c’è una cosa che devi sentire”.
In una sorta di incontro sinergico con le piante, molti dei personaggi umani di Powers vivono ciò che nel saggio La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile (Neri Pozza, 2017, cfr. “L’Indice, 2017, n. 7-8) Amitav Ghosh definisce “riconoscimento”, ovvero il passaggio dall’ignoranza alla conoscenza: “il riconoscimento avviene quando una consapevolezza anteriore balena dinanzi a noi, provocando un repentino mutamento nella comprensione di ciò che si ha davanti (…); deriva dal prendere coscienza di una potenzialità ancora inespressa”. Ghosh riconosce questa presenza che lo circonda mentre scrive della grande foresta di mangrovie che ricopre le Sundarbans, nel delta bengalese; in maniera molto simile Patricia Westerford (detta Patty-la-Pianta), studiando le foreste americane comprende che gli alberi “stanno cercando di attirare la nostra attenzione” e che, paradossalmente, è più facile sentirli piuttosto che vederli. In più di un’occasione Powers suggerisce che la nostra incapacità di vedere gli alberi ci rende specie “cieca” e non solo perché non sappiamo distinguere “un noce nero da un frassino bianco”, ma perché ci sfuggono le grandi complessità di interi biomi: anche gli alberi, come altre creature non umane, hanno capacità di azione, personalità e scopi che noi umani tendiamo a negare. Nelle storie intrecciate del libro, il personaggio di Adam Appich, accumulatore compulsivo e psicologo, offre insieme a Patricia il miglior contributo al processo di “rimozione della cecità”. Convinto sin da bambino che l’umanità sia “profondamente malata” e che “la specie non durerà molto”, si specializza nel bias (o pregiudizio) di conferma, l’errore cognitivo che ci porta a selezionare e interpretare informazioni in modo da attribuire maggiore credibilità a quelle che confermano la nostra convinzione iniziale, facendoci ignorare quelle che la contraddicono. In una delle scene finali del romanzo Adam, in compagnia di attivisti ambientali radunati intorno a un falò, afferma che persino le migliori argomentazioni al mondo non sono in grado di far cambiare idea alle persone. L’unica cosa che riesca a farlo è una buona storia che occasionalmente può persino essere scritta sulla corteccia di un albero come Patricia apprende dal padre il quale “le spiega come il termine beech, faggio, si trasforma nella parola book, libro, nel continuo evolversi del linguaggio. Come libro si sia sviluppato dalle radici del faggio, molto tempo addietro nella lingua madre. Come la corteccia del faggio ospitasse le prime parole sanscrite (…) Ma da dove proverrà la mole di un libro così voluminoso?” Libro, peraltro, che continuerà a scriversi da solo persino dopo che noi, umani, saremo estinti. Ecco allora che quando Douggie Pavlicek si chiede cosa sia andato storto con l’umanità – che è poi la questione centrale dell’intero romanzo – troviamo risposta proprio qui: dall’alto del nostro falso eccezionalismo, non siamo capaci di venirne a capo perché abbiamo smesso di prestare attenzione alle parole e alle storie. “Ascolta,” sussurra il pino alla donna seduta per terra e appoggiata al tronco, “c’è una cosa che devi sentire”.
daniela.fargione@unito.it
D. Fargione insegna lingua e letteratura angloamericane all’Università di Torino


