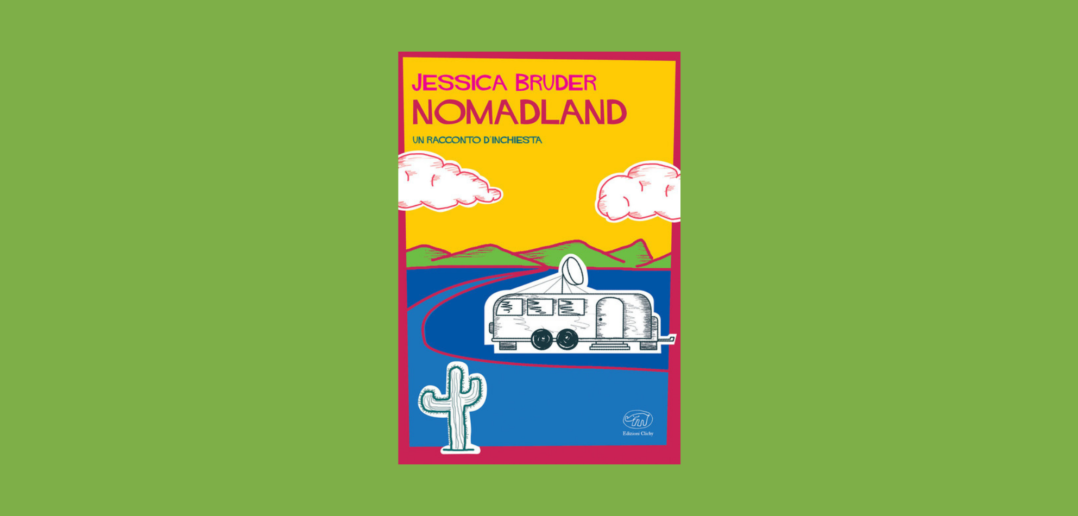Residenze mobili per sopravvivere all’America
di Cinzia Schiavini
Jessica Bruder
Nomadland
Un racconto di inchiesta
ed. orig. 2018, trad. dall’inglese di Giada Diano,
pp. 383, € 17,
Clichy, Firenze 2020
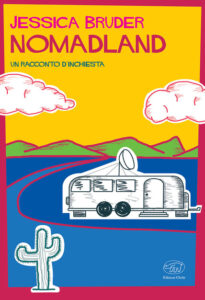 Cosa puoi fare in America quando arrivi a sessant’anni, scopri che hai diritto al massimo a un assegno mensile di cinquecento dollari, hai perso la casa di proprietà e i risparmi e devi trovare il modo di sopravvivere per il resto dei tuoi giorni? Non è un’ipotesi remota, ma una domanda drammaticamente attuale e diffusa, soprattutto dopo la crisi economica del 2008, che ha polverizzato i risparmi di milioni di famiglie della classe media e lasciato molti, spesso gli ultrasessantenni, senza un lavoro e senza la speranza di una pensione, costretti a reinventarsi una vita per non dover vivere accampati sui divani dei figli o da senzatetto. La risposta, per migliaia di loro, è stato tagliare la voce principale, l’affitto, e mettersi sulla strada vivendo in camper e furgoni, divenendo manodopera mobile, agile e a basso costo sfruttata da diverse economie, nazionali e non. Dalla gestione e pulizia di campeggi nell’Ovest a quella dei parchi giochi e a tema (il tutto meno divertente di quanto possa a prima vista apparire) alla raccolta e lavorazione della barbabietola da zucchero nei Dakotas, fino all’alienante stoccaggio nei grandi magazzini Amazon sparsi nel paese, appositamente dotati di distributori di antidolorifici gratuiti come palliativo per arrivare alla fine della giornata, o del mese. E per far quadrare i conti, scegliere il cibo più economico, o ancor meglio trovare pasti gratuiti; iscriversi alle palestre locali per usare le docce, costruire sistemi di riscaldamento sicuri per non morire di freddo, o di monossido, la notte; nascondersi bene per evitare le visite (il “colpetto”) della polizia con relativo allontanamento, continuando a resistere in case mobili che da scelta vacanziera si trasformano in unica possibilità per decine di migliaia di persone. Il numero è difficilissimo da quantificare: le aziende rifiutano spesso di fornire i numeri dei loro assunti stagionali; e visto l’obbligo di avere una residenza, i migranti ne devono indicare di fittizie. Un equilibrio sottile e fragile in cui la tregua è riposarsi a casa di qualche parente durante le feste, o trascorrere un paio di settimane in raduni nel deserto nei mesi invernali, in comunità di “senzacasa”, ma non di “senzatetto”, in cui necessità e scelta sono due lati della stessa medaglia: quella di un sistema in cui i margini si sono ispessiti, e ai margini non c’è più solo chi non si è conformato o è appena arrivato o fa parte di una minoranza, ma chi si è conformato ed è stato imbrogliato, dall’economia, dalla società, o per uno scherzo della vita. E che per “sopravvivere all’America” si affida, ancora una volta, alla speranza e alla possibilità della strada, in una nazione dove, avvisa l’autrice, l’ultimo luogo libero è un parcheggio.
Cosa puoi fare in America quando arrivi a sessant’anni, scopri che hai diritto al massimo a un assegno mensile di cinquecento dollari, hai perso la casa di proprietà e i risparmi e devi trovare il modo di sopravvivere per il resto dei tuoi giorni? Non è un’ipotesi remota, ma una domanda drammaticamente attuale e diffusa, soprattutto dopo la crisi economica del 2008, che ha polverizzato i risparmi di milioni di famiglie della classe media e lasciato molti, spesso gli ultrasessantenni, senza un lavoro e senza la speranza di una pensione, costretti a reinventarsi una vita per non dover vivere accampati sui divani dei figli o da senzatetto. La risposta, per migliaia di loro, è stato tagliare la voce principale, l’affitto, e mettersi sulla strada vivendo in camper e furgoni, divenendo manodopera mobile, agile e a basso costo sfruttata da diverse economie, nazionali e non. Dalla gestione e pulizia di campeggi nell’Ovest a quella dei parchi giochi e a tema (il tutto meno divertente di quanto possa a prima vista apparire) alla raccolta e lavorazione della barbabietola da zucchero nei Dakotas, fino all’alienante stoccaggio nei grandi magazzini Amazon sparsi nel paese, appositamente dotati di distributori di antidolorifici gratuiti come palliativo per arrivare alla fine della giornata, o del mese. E per far quadrare i conti, scegliere il cibo più economico, o ancor meglio trovare pasti gratuiti; iscriversi alle palestre locali per usare le docce, costruire sistemi di riscaldamento sicuri per non morire di freddo, o di monossido, la notte; nascondersi bene per evitare le visite (il “colpetto”) della polizia con relativo allontanamento, continuando a resistere in case mobili che da scelta vacanziera si trasformano in unica possibilità per decine di migliaia di persone. Il numero è difficilissimo da quantificare: le aziende rifiutano spesso di fornire i numeri dei loro assunti stagionali; e visto l’obbligo di avere una residenza, i migranti ne devono indicare di fittizie. Un equilibrio sottile e fragile in cui la tregua è riposarsi a casa di qualche parente durante le feste, o trascorrere un paio di settimane in raduni nel deserto nei mesi invernali, in comunità di “senzacasa”, ma non di “senzatetto”, in cui necessità e scelta sono due lati della stessa medaglia: quella di un sistema in cui i margini si sono ispessiti, e ai margini non c’è più solo chi non si è conformato o è appena arrivato o fa parte di una minoranza, ma chi si è conformato ed è stato imbrogliato, dall’economia, dalla società, o per uno scherzo della vita. E che per “sopravvivere all’America” si affida, ancora una volta, alla speranza e alla possibilità della strada, in una nazione dove, avvisa l’autrice, l’ultimo luogo libero è un parcheggio.
Con Nomadland, Jessica Bruder toglie il velo a una delle tante forme di povertà invisibile che da decenni pervadono la società statunitense; invisibile perché volutamente nascosta, in un paese dove il fallimento (sociale ed economico) è vissuto come una colpa del singolo e non come disfunzionalità del sistema. Invisibile anche perché il fatto stesso che una fetta significativa della classe media bianca (qui non si parla di neri o ispanici o asiatici, per cui troppo pericoloso sarebbe vivere per strada, e nemmeno di altre categorie più facili da associare alla povertà) possa trasformarsi in un insieme di individui senza più una casa e un reddito indica l’estrema fragilità del sogno americano, o di quello che ne rimane. Una nazione senza più vera mobilità sociale da almeno due generazioni e dove il mondo finanziario ha messo in salvo se stesso spostando il rischio economico sulle spalle dei singoli della ex classe media lasciando mutui, fondi pensione e contributi previdenziali in balia del sistema dei subprime. Jessica Bruder, giornalista e studiosa di sottoculture e temi sociali, è solo l’ultima delle penne di una tradizione importante e poco conosciuta in Italia di un giornalismo statunitense immersivo di inchiesta che cerca di fare affiorare le contraddizioni di un paese in cui, dalla fine degli anni settanta in avanti, neoliberismo, assenza di welfare e delocalizzazione hanno creato cortocircuiti nel tessuto sociale profondo, provocando un impatto profondamente disgregativo della composizione sociale, senza tuttavia trovare una voce collettiva, né un mondo disposto ad ascoltare. Antecedenti di Bruder sono Una paga da fame. Come (non) si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo di Barbara Ehrenreich (Feltrinelli 2002), in cui l’autrice prova a sopravvivere per alcuni mesi con i lavori più comuni (e sottopagati) dopo la riforma dello stato sociale del 1996; il libro inchiesta di David K. Shipler The Working Poor. Invisible in America (Knopf 2004), indagine su come si possa essere e rimanere poveri lavorando dieci e più ore al giorno; o ancora Someplace Like America. Tales from the Great Depression (University of California Press 2011) di Dale Maharidge (con fotografie di Michael S. Williamson) che come i precedenti libri di indagine si sofferma sulle nuove invisibili sacche di povertà statunitensi – qui focalizzandosi sulla working class dagli anni della deindustrializzazione fino alla grande recessione del 2008 (proprio a Dale Maharidge, il miglior amico di Bruder, il libro di quest’ultima è dedicato). Prima come intervistatrice, e poi sperimentando in prima persona i lavori per cui molti stagionali ultrasessantenni sono reclutati, Bruder ha viaggiato per mesi in tutta la nazione raccogliendo storie di vite che colpiscono per la loro apparente normalità e benessere economico. Non hoboes, ma ex esponenti della middle class con un impiego fisso e un buono, talvolta ottimo, stipendio, non di rado con proprietà immobiliari di centinaia di migliaia di dollari e mutui che con la crisi del settore hanno finito per superarne l’effettivo valore. Ex poliziotti, postine, general contractor, consulenti universitari, impiegate, contabili, insegnanti, tassisti: un intreccio di vite apparentemente solide che una malattia improvvisa, la perdita del lavoro, un divorzio, manda in crisi irreversibile. Individui o famiglie che si mettono in strada e gradualmente si incontrano e formano via via comunità fluide e transitorie, dove internet e i raduni (come il Rubbert Tramp Rendezvous) divengono luoghi reali e virtuali di incontro e supporto.
Porta di ingresso in quel mondo è per Bruder Linda May, sessantaquattro anni, una vita di lavori precari, una pensione quasi inesistente, una figlia e un genero e tre nipoti in grado solo di ospitarla su un divano (che a loro volta perderanno la casa e saranno costretti a vivere nell’ex camper di Linda) e la decisione di cercare di nuovo una indipendenza. E poi Bob Wells, uno dei pionieri di quel mondo, infaticabile dispensatore di consigli online, di raduni e seminari su come vivere in una manciata di metri quadri; l’amica Silvianne, e poi Swankie, e la comunità di vandweller che si dispiega gradualmente intorno a loro. Non è solo una storia di individui, quella intessuta da Bruder – è molto di più: è la storia di uno sgretolarsi del sistema e dell’identità sociale nella transizione tra diversi sistemi economici, dove cittadine aziendali modello come Empire vengono chiuse col filo spinato, gli abitanti costretti ad andarsene dopo decenni di vita e lavoro. E parallelamente vengono create e alimentate reti economiche globali del superfluo (gli oggetti che transitano dai magazzini Amazon hanno una durata di vita inferiore all’anno) grazie a programmi come Camperforce, che arruola solo persone che vivono in van e camper, sfruttandone l’indigenza economica, l’età e la conseguente difficoltà di trovare lavori meglio remunerati e protetti (totalmente assenti le tutele sindacali e mediche), oltre che la flessibilità logistica e le detrazioni fiscali che le loro temporanee assunzioni comportano.
Questo scenario di nuovi, improvvisi poveri in movimento evoca gli Oakies del periodo della Grande Depressione (epiteto con cui in diversi stati sono indicati peraltro i vandwellers). La differenza però c’è, ed è radicale: se negli anni trenta il movimento verso Ovest lasciava sperare in una povertà possibile da riscattare costruendosi una nuova vita altrove, ora, per le decine di migliaia di sessantenni, settantenni, ottantenni Wasp la strada è diventata una condizione permanente, in cui la decrescita, il “vivere felici con meno”, non è un fatto transitorio. Ridurre, comprimere, arrivare all’essenziale, che include non solo oggetti, ma anche la dignità e la voglia di continuare, è risorsa e necessità. Come lo è, sempre in piccola scala, riuscire a coltivare piccoli sogni: come Swankie che è riuscita ad attraversare tutti e cinquanta gli stati americani in kayak; come Linda, che arriverà a comprarsi un piccolo appezzamento di terra desertico per costruirci forse una Earthship, una casa di terra e scarti autosufficiente dove accogliere gli amici. Su tutto, riuscire a conservare una speranza per il futuro – quell’inguaribile ottimismo che disgustava lo scrittore James Rorty alle prese con la Grande depressione, ma che è fondamentale per non spararsi un colpo in testa o vivere nell’angoscia di morire soli di stenti o freddo in qualche luogo remoto. A essere tragico, in Nomadland, è il sistema, di rado lo sono gli individui. Non vittime né spensierati amanti dell’avventura, scrive Bruder, ma tante sfumature nel mezzo, capaci come sono di resilienza e umanità; che nella perdita di uno status economico e sociale trovano però il senso di essere e formare comunità in cui condivisione e aiuto reciproco sono l’unico modo per non soccombere.
Nomadland non è solo un racconto di un margine; è la fotografia di un mondo in cui i margini si sono progressivamente ispessiti fino a giungere anche ai centri, divenendo città nelle città, popolando, invisibili in bella vista, anche le strade di New York. Certo, quella dei vandwellers, serena o sofferta che sia, è solo una parziale risposta a milioni di interrogativi su a che cosa si possa rinunciare per tirare avanti. Ma è una indagine che pone soprattutto un’altra, fondamentale domanda: fino a che punto si può estendere la disparità economica senza mandare in frantumi il sistema, in una nazione che ormai vanta il livello di disuguaglianza più alto in tutte le nazioni sviluppate, in cui l’1per cento al vertice guadagna ottantuno volte quanto chi sta alla base, e in cui per 117 milioni di persone il reddito è invariato dagli anni settanta? Come si chiedeva Langston Hughes, “Cosa accade a un sogno differito? … Forse cede soltanto. Come un grosso peso. Oppure esplode?”
cinzia.schiavini@unimi.it
C. Schiavini insegna letteratura angloamericana all’Università Statale di Milano