Ardente sensibilità
di Margherita Botto
dal numero di gennaio 2014
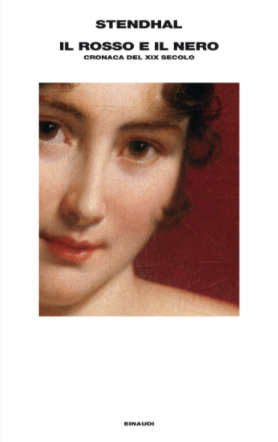 Confesso di essere sempre molto restia a parlare dell’attività del tradurre o commentarne i risultati, a maggior ragione quando sono i miei, se non in contesti didattici che mi offrono l’opportunità di metterli in discussione confrontandomi con giovani aspiranti traduttori; mi è accaduto proprio mentre lavoravo a Il rosso e il nero di Stendhal, nel 2012, con un gruppetto di appassionati allievi della Scuola di specializzazione in traduzione editoriale di Torino. Sottoscriverei piuttosto la bella definizione di Javier Marías: “I testi originali sono un po’ come le partiture musicali; le traduzioni sono un po’ come le esecuzioni e gli adattamenti di ciò che senza di esse tace”. Con una chiosa: che l’esecutore della partitura non dovrebbe sentirsi come un solista sotto le luci della ribalta; semmai come un’orchestra, un insieme di anonimi strumenti che affida la propria interpretazione all’ascolto del pubblico e al giudizio dei critici musicali.
Confesso di essere sempre molto restia a parlare dell’attività del tradurre o commentarne i risultati, a maggior ragione quando sono i miei, se non in contesti didattici che mi offrono l’opportunità di metterli in discussione confrontandomi con giovani aspiranti traduttori; mi è accaduto proprio mentre lavoravo a Il rosso e il nero di Stendhal, nel 2012, con un gruppetto di appassionati allievi della Scuola di specializzazione in traduzione editoriale di Torino. Sottoscriverei piuttosto la bella definizione di Javier Marías: “I testi originali sono un po’ come le partiture musicali; le traduzioni sono un po’ come le esecuzioni e gli adattamenti di ciò che senza di esse tace”. Con una chiosa: che l’esecutore della partitura non dovrebbe sentirsi come un solista sotto le luci della ribalta; semmai come un’orchestra, un insieme di anonimi strumenti che affida la propria interpretazione all’ascolto del pubblico e al giudizio dei critici musicali.
Con Delitto e castigo, tradotto da Emanuela Guercetti, e Il rosso e il nero Einaudi ha inaugurato lo scorso settembre un impegnativo progetto editoriale, “Le grandi traduzioni”, che proporrà ogni anno due romanzi appartenenti al canone letterario le cui precedenti traduzioni einaudiane risalivano ormai a parecchi decenni, nonché alcuni titoli che attualmente non figurano nel suo catalogo.
Per limitarci all’ultimo secolo, Il rosso e il nero è stato più volte ritradotto, e ognuna delle versioni ha quasi sempre goduto di una lunga, talora lunghissima, vita editoriale. Ricorderò brevemente solo quelle che ho avuto modo di consultare, anche se l’ho fatto dopo avere concluso il mio lavoro, saggiando la solidità delle mie scelte attraverso la constatazione delle differenze, delle somiglianze e delle identità. Ma durante il lavoro, misurarmi con una tale pietra miliare nella storia del romanzo europeo bastava e avanzava. Ho quindi voluto affrontare Le rouge et le noir senza averne letto le traduzioni italiane: né quella di Diego Valeri, che la mia doveva sostituire, né quelle di Mario Lavagetto e di Maurizio Cucchi, che oltre a essere le più recenti rappresentavano, per il prestigio dei traduttori, un’ulteriore sfida (la versione di Luigi Maria Sponzilli per Feltrinelli è uscita nell’estate 2013, quando la mia era già in stampa). Esattamente a cento anni fa risale la traduzione di Bontempelli per l’Istituto Editoriale Italiano (1913), ripresa ancora nel 2002 da Newton Compton; nel 1930 uscì per Vallecchi quella di Alfredo Fabietti, riproposta negli “Oscar” Mondadori fino al 2003, quando fu sostituita dalla traduzione di Cucchi originariamente pubblicata nel primo volume dei Romanzi e racconti di Stendhal dei “Meridiani” (1996). La traduzione einaudiana di Diego Valeri (1946) aveva seguito di un solo anno quella di Ugo Dettore (1945), acquisita da Rizzoli nel 1950 e tuttora presente nel catalogo “Bur”, mentre nel 1968 Garzanti aveva presentato la versione di Lavagetto.
Ora, diciassette anni dopo il lavoro di Cucchi, sono uscite a pochi mesi di distanza due nuove versioni: per Einaudi e per Feltrinelli. Dobbiamo dar ragione a Fabrizio Dragosci che sul “Corriere della Sera” (2 ottobre 2013) parla di “insana frenesia (…) della ritraduzione dei classici della letteratura mondiale” da parte di alcune case editrici italiane? Il suo articolo irride con toni piuttosto virulenti la supposta pretesa di “adeguare il testo originario alle mutate esigenze di oggi” e adduce una “spiegazione più prosaica”: non essendo ancora scaduti i diritti di traduzioni precedenti, “chi vuole nobilitare il proprio catalogo con La montagna incantata e Robinson Crusoe deve farli ritradurre”. Ignorando il sarcasmo, riprenderei solo il termine “nobilitare”: non un catalogo (quello Einaudi non ne ha certo bisogno), ma un testo. La maggior parte delle traduzioni novecentesche del romanzo stendhaliano sono nate per una collana tascabile o vi sono velocemente approdate. La nuova edizione Einaudi si distingue in primo luogo per la sua eleganza – del carattere tipografico adottato, della sovraccoperta con il delizioso ritratto di madame Récamier – e per la solida rilegatura dei “Supercoralli”. Certo, costa più o meno il doppio di un tascabile, ma un “grande classico” merita una veste fatta per durare, poiché non è destinato a un consumo passeggero, lo si deve poter conservare e rileggere, o anche leggere per la prima volta molto dopo averlo comperato, quando ci si sente pronti, per età o per esperienza acquisita.
Stendhal non è uno scrittore accattivante, rifugge i facili effetti, e così come non nutre alcuna indulgenza per i suoi personaggi, nemmeno quelli che confessa esplicitamente di trovare simpatici, non cerca mai di conquistarsi il lettore con espedienti emotivi. La migliore definizione della scrittura stendhaliana resta quella di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Spoglio di qualsiasi belletto, alieno da ogni parola ricercata, nemico del ritmo intenzionale, avaro di aggettivi, lo stile di Stendhal è lo stile della prosa settecentesca con la sola differenza che Voltaire, per esempio, intendeva esprimere soltanto dei ragionamenti, mentre Stendhal, con la medesima economia di mezzi, si propone di trasmettere al lettore dei sentimenti. Il suo genio per snellire, per sopprimere le ridondanze, per ‘restare in tema’, rasenta il prodigio. (…) Stendhal è riuscito a riassumere una notte d’amore in un punto e virgola” (Lezioni su Stendhal, Sellerio, 1977). È proprio questa la resistenza che la scrittura stendhaliana oppone alla trasposizione in un’altra lingua, soprattutto quando si tratta dell’italiano, che nemmeno oggi, mi pare, sembra particolarmente incline all’economia di mezzi. La sintassi della frase di Stendhal si riduce, nella gran parte dei casi, alle strutture minimali, con scarsa aggettivazione e poche subordinate. Traducendola, in alcuni casi ho quindi ritenuto di potermi arrischiare a introdurre un punto fermo anche là dove nell’originale non c’era, accentuando l’andamento secco e martellante del paragrafo. Ma in Stendhal la vera sfida è il lessico. Con un testo che risale a quasi duecento anni fa, e così profondamente radicato in una precisa realtà storica e sociale, il problema è trovare e mantenere il delicato equilibrio tra la necessità di far accedere il lettore sia a sentimenti e riflessioni che hanno un indubbio riscontro anche nella nostra esperienza contemporanea sia al contesto socio-storico in cui entrano in gioco le passioni e gli interessi che muovono i personaggi. Il che, ritengo, spazza via le vacue polemiche e le facili ironie mediatiche sul presunto tentativo, nelle ritraduzioni odierne, di attualizzare a oltranza, seguendo le effimere mode linguistiche del momento.
Riprodurre la precisione chirurgica stendhaliana
In Stendhal la maggiore difficoltà è posta dalle pagine dedicate alla descrizione e all’analisi della passione, in tutte le sue accezioni. L’italiano (e non solo quello attuale) non è molto adatto a restituire la precisione chirurgica dell’anatomia stendhaliana dei sentimenti e, in questo senso, il mio più grosso timore era di scivolare nel patetico, nell’enfatico, nello sdolcinato, nel melodramma, a cui la nostra lingua cede tanto spesso, mentre purtroppo non potevo disporre del vocabolario che il Settecento francese ha creato e che è tuttora perfettamente comprensibile a chi legga il testo in lingua originale. In questo ambito lessicale, a mio avviso, non sono possibili molte innovazioni ed è necessario mantenersi strettamente aderenti alla lingua stendhaliana, anche a costo di chiedere al lettore un piccolo sforzo interpretativo. Penso, per esempio, all’uso dell’aggettivo “morale”, che copre un’ampia gamma di valori semantici, compresi quelli che oggi sono invece espressi dalla vulgata della psicologia e della psicoanalisi, oppure alle ellittiche evocazioni della sessualità femminile, che nel lessico stendhaliano è sempre e soltanto “ardente sensibilità”. In compenso, tutte le pagine dedicate alla descrizione e all’analisi delle dinamiche sociali e degli interessi che le scatenano offrono un più ampio spazio di manovra perché, al di là delle differenze di contesto storico, sono perfettamente (e forse ancor più) comprensibili a qualunque lettore odierno. Tradurre i capitoli incentrati sui piccoli intrighi politici di provincia, sugli squallidi maneggi del seminario di Besançon o sulle crudeli malignità del salotto de La Mole è stato un autentico godimento, nonostante la necessità di corredare il testo con qualche nota per esplicitare allusioni a personaggi o eventi appartenenti più alla cronaca che alla Storia.

D’altro canto, la lettura di un romanzo deve essere anche apprendimento, e non solo nel caso di testi da cui ci separano uno o più secoli. Ho quindi cercato di mantenere rigorosamente le formule legate alle convenzioni sociali, anche a costo di ripetere un po’ ossessivamente gli appellativi “signore” o “signora”, essenziali per connotare una società rigidamente codificata come quella che figura del romanzo, e per salvaguardare la precisione storica mi è persino accaduto di ricorrere a una perifrasi esplicativa, rendendo l’espressione “acheter un homme” con “evitare il servizio militare pagando un sostituto” (pratica assai diffusa in Francia, e addirittura regolamentata, tra il 1796 e il 1872), mentre tutti gli altri traduttori hanno preferito la formula “corrompere qualcuno”, più comprensibile a un lettore attuale ma storicamente poco corretta. Non mi è parso, invece, di far torto al testo acclimatandolo all’uso italiano quando ho premesso al nome dei vari personaggi di sacerdoti la qualifica “don”, in luogo dell’ingiustificato calco “abate/abbé”. Né ho esitato, considerando lo status sociale del padre del protagonista, plebeo arricchito ma analfabeta, a osare la formula “ti sei arruffianato il parroco”, invece di ricorrere al verbo “conquistarsi” o “ingraziarsi”.
Non è questa la sede per entrare nei dettagli o procedere ad analisi comparative che di certo sono più appassionanti per i traduttori stessi che per i lettori. Ritengo tuttavia che “tradurre il tradotto”, per riprendere il titolo di un capitolo del bel libro di una traduttrice che ammiro, Susanna Basso (Sul tradurre, Bruno Mondadori, 2010), sia forse la più stimolante delle molteplici esperienze in cui si declina l’attività del tradurre: non per smania di innovare né per una sorta di competizione con le versioni già pubblicate, ma per provare a inscrivere la propria esecuzione nell’effimera sequenza di quelle che l’hanno preceduta e la seguiranno, di fronte all’immutabile perfezione del testo originale.
m.botto@tiscali.it
M Botto è traduttrice


