Silenzio universale, applausi unanimi
recensione di Vittorio Coletti
dal numero di ottobre 2017
Vincenzo Bellini
CARTEGGI
a cura di Graziella Seminara
pp. VI – 622, € 76
Olschki, Firenze 2017
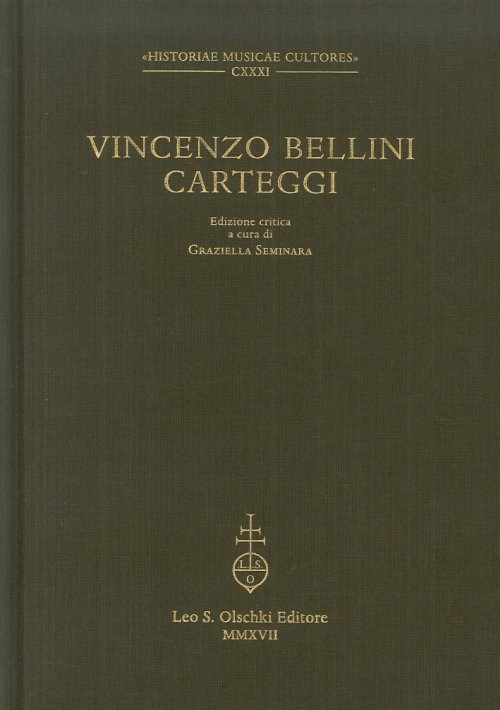 La raccolta di tutte le lettere di Vincenzo Bellini sinora note e altre inedite, tutte scrupolosamente accertate, va ad aggiungere prezioso materiale al già vasto corpus degli epistolari ottocenteschi, sulla base del quale Giuseppe Antonelli (Tipologia linguistica del genere epistolare nel primo Ottocento, Roma, 2004) ha potuto ricostruire la grammatica dell’epistolografia dell’epoca, alla quale si attiene ovviamente anche il musicista catanese. In particolare, però, le lettere di Bellini accrescono quella speciale sezione del corpus epistolare dell’Ottocento costituito dalle lettere dei musicisti, Verdi innanzitutto, l’edizione del cui enorme carteggio è già ben avanzata, ma anche, da poco, Puccini, di cui è uscito il primo volume. L’interesse è dunque assicurato, sia al linguista che al musicologo che al biografo belliniano, anche grazie alla attenta cura filologica ed erudita con cui questo epistolario è stato edito e annotato da Graziella Seminara. Il biografo vi troverà soprattutto copioso materiale per documentare la meticolosa contabilità e l’istinto affaristico con cui Bellini curava i suoi interessi economici (anche con poca generosità, come si evince dalla imbarazzante lettera 127 al fratello Carmelo in cui giustifica la sua renitenza ad aiutare la famiglia), non secondi a quelli che avrà poi Verdi, ma scarso alimento per ulteriore gossip sui suoi vari e complicati amori (qui in particolare quello per Giuditta Turina).
La raccolta di tutte le lettere di Vincenzo Bellini sinora note e altre inedite, tutte scrupolosamente accertate, va ad aggiungere prezioso materiale al già vasto corpus degli epistolari ottocenteschi, sulla base del quale Giuseppe Antonelli (Tipologia linguistica del genere epistolare nel primo Ottocento, Roma, 2004) ha potuto ricostruire la grammatica dell’epistolografia dell’epoca, alla quale si attiene ovviamente anche il musicista catanese. In particolare, però, le lettere di Bellini accrescono quella speciale sezione del corpus epistolare dell’Ottocento costituito dalle lettere dei musicisti, Verdi innanzitutto, l’edizione del cui enorme carteggio è già ben avanzata, ma anche, da poco, Puccini, di cui è uscito il primo volume. L’interesse è dunque assicurato, sia al linguista che al musicologo che al biografo belliniano, anche grazie alla attenta cura filologica ed erudita con cui questo epistolario è stato edito e annotato da Graziella Seminara. Il biografo vi troverà soprattutto copioso materiale per documentare la meticolosa contabilità e l’istinto affaristico con cui Bellini curava i suoi interessi economici (anche con poca generosità, come si evince dalla imbarazzante lettera 127 al fratello Carmelo in cui giustifica la sua renitenza ad aiutare la famiglia), non secondi a quelli che avrà poi Verdi, ma scarso alimento per ulteriore gossip sui suoi vari e complicati amori (qui in particolare quello per Giuditta Turina).
Piano-forte e palco scenico
Il ritratto del musicista che le lettere ci offrono (ma in fondo pubblicare un epistolario privato è un po’ come pubblicare delle intercettazioni telefoniche, dove uno dà spesso il peggio di sé) non è dei più lusinghieri: evidente e ripetuto il compiacimento per l’insuccesso o lo scarso successo dei colleghi, spesso manifestato però con l’ipocrita preghiera di non renderlo pubblico. Grandi vantaggi ne avrà soprattutto il musicologo, come ovvio: tra i tanti, un solo dato, ricorrente: Bellini non nomina quasi mai i vari pezzi chiusi come si faceva di solito e farà Verdi, scrivendo aria del soprano, cabaletta del tenore, duetto tenore e soprano ecc. ma aria della Pasta, cabaletta di Rubini, scena di Tamburrini, duetto tra Tosi e David ecc.: li individua cioè dal nome di chi li ha cantati in quella data occasione. Questo per due ragioni: Bellini è attentissimo alle particolarità della voce del cantante (che a volte, come fa, in una delle lettere al musicista riportate nell’epistolario, il tenore Domenico Donzelli, gliene anticipa per scritto caratteristiche ed estensione) e segue puntigliosamente le varie messinscene delle sue opere, anche le più remote repliche e riprese, legandone l’esito sempre ai diversi attori-cantanti, come li chiama in qualche occasione, rivelandosi non meno preoccupato delle doti sceniche che di quelle vocali (“Basta che questi mezzi-cani di cantanti sapranno eseguire i miei pensieri”, scrive durante le prove dei Capuleti).
Si entra con questo epistolario nel modo di lavorare di Bellini; in particolare si capisce meglio quel suo prepararsi in anticipo dei motivi, delle idee musicali che poi avrebbe impiegato sui testi, una volta disponibili: un tratto ancora da vecchia scuola, se vogliamo, ma che le lettere mostrano meno astratto e meno prefabbricato di quello che si poteva pensare. Meno sostanziose invece, anche se non assenti, le notizie sulla lavorazione dei libretti, che Bellini seguiva con uguale apprensione ma minor partecipazione di Verdi, anche perché a lungo affiancato dal principe dei librettisti, l’insindacabile Felice Romani. Una valanga di elementi di interesse le lettere poi riservano allo studioso del metalinguaggio operistico, come ha ben visto Seminara nella sua introduzione. Bellini parla, specie nelle lettere più antiche, più spesso di “libro” che di “libretto”, e in tutto l’epistolario i due termini continuano ad alternarsi. Interessante l’uso ancora disgiunto di “palco scenico” e, sia pure col trattino, di “piano-forte”. Il costume dell’ascolto teatrale del primo Ottocento è ripetutamente documentato in queste lettere: dalle molte stufe nei palchi, all’eccezionalità, oggi invece regola inderogabile, del silenzio in sala, che, quando c’era, era segno della conquista del pubblico da parte dell’opera (“Il teatro è pieno zeppo ogni sera, il silenzio universale, gli applausi unanimi”, scrive parlando di Norma nel 1831).
La musica dev’essere “concisa come frappante”
Bellini fa il possibile per misurare linguisticamente i suoi successi e sente che l’italiano non ha tutte le parole che servirebbero per descriverli: “furore”, “furorone”, “fanatismo”, “fanatizzare”, “entusiasmo”, “fare un’eruzione” (un catanese ne aveva un’idea viva), “andare alle stelle”, “non plus ultra”, sono le sue espressioni, ben chiosate da Seminara. Per lui un chiodo fisso è l’“effetto”, la capacità di colpire e soprattutto commuovere di una scena, di un’aria. Non è infrequente “agire” per recitare (“Il terzetto … lo agiscono bene e con forza”). Ribadito è l’obiettivo ben noto della limpidità, della chiarezza e quindi la critica tanto degli artifici poetici quanto di quelli musicali: la musica deve essere “concisa come frappante”, scrive, ricorrendo a un francesismo, al Pepoli, stentato librettista dei Puritani (1834).
La curiosità linguistica di Bellini spunta qua e là, come quando si compiace di chiamare, sottolineandolo, “influenza” “tale epidemica malattia” (1833) o si diverte col “puttanismo” dell’amico Santocanale jr, gioca con “l’indorarci la pilola (sic)” e con “tu fa l’indiano con tutti”, scova una rarità come “ella… m’incombenzò di scrivervi”, o recupera un napoletanismo come “garbizzare”, andare a genio (“Vuol dire che non le garbizò molto la mia schietta maniera d’esprimermi”), o infine si inventa un “antegalantuomo” per affibbiarlo a Pacini. Certo, niente di paragonabile alla verve toscanaccia di Puccini, ma pur sempre un indizio della spontaneità e della freschezza espressiva di queste lettere. Il linguista si interesserà anche a usi della lingua allora corrente, come “subito che” per il nostro appena che, “frattanto che” per mentre; “successo” per accaduto, “sposa” per fidanzata, “raziocinio” per giudizio, “disgusti” per rancori. Inutile dire poi che abbondano i tratti che rivelano il sostrato meridionale dell’italiano di Bellini (“affezzionata”, “serviggi”, “colleggio”, “compinazione”) e che ci sono i segni della sua imperfetta padronanza della lingua scritta, sia nella grafia (“sollenne”, “fattiga”, “commodino”, “un’abboccamento”) che nella morfologia (“che la nostra amicizia divenghi preziosa”, “è stato pure piaciuto”, “stiedi” per stetti, il frequente “le” ipercorrettivo per “gli”) e nella sintassi ( “se Cottrau avrebbe solo la proprietà dell’edizione, fosse presto accomodabile”, con inversione di condizionale e congiuntivo). Le varie improprietà (“petitio non petita accusatio manifesta” invece di excusatio ecc, “prodigalizzare” per prodigare) sono attribuibili allo stile informale, diretto dello scrivente (come esemplarmente nella lettera al tenore Rubini, scritta con evidente impeto). Il lavoro editoriale, si è detto, è stato fatto da Graziella Seminara con encomiabile cura e precisione. In una messe di testi come questa capiterà al lettore di non trovare tutto quello che desidererebbe sapere, ma il complesso è di tale ricchezza di informazioni e serietà di controllo filologico sugli originali da meritare i più sinceri elogi.
vittorio.coletti@lettere.unige.it
V Coletti insegna storia della lingua italiana all’Università di Genova
La vertiginosa distanza fra l’uomo e l’opera: anche Gabriele Bucchi commenta i carteggi di Vincenzo Bellini.


