L’ultimo distillato ronconiano
recensione di Federica Mazzocchi
dal numero di aprile 2015
Stefano Massini
LEHMAN TRILOGY
pp. X-334, € 17.50
Einaudi, Torino 2014
È un altro pezzo di bellezza che se ne va. Nell’arco di pochi anni il nostro teatro ha perso Massimo Castri, Mario Missiroli e ora Luca Ronconi, tre fuoriclasse di quella generazione che, oltre i padri Visconti e Strehler, ha reso indimenticabile il teatro di regia italiano. Era un fatto di talento, certo, evidentissimo e svettante nelle reciproche diversità, ma anche di un sistema-teatro che pensava e agiva in grande. E sotto il segno dell’ampiezza di visione e della profondità analitica si congeda Luca Ronconi con questa Lehman Trilogy di Stefano Massini, in scena al Piccolo teatro Grassi di Milano. Suggello di estrema coerenza in una storia teatrale lunghissima e costellata di capolavori, incisi nella memoria degli spettatori come veri e propri punti fermi.
E della poetica di Ronconi questo suo ultimo spettacolo rappresenta, in un certo senso, il distillato, in cui si ritrovano molte delle scoperte fatte e testate, nel corso degli anni, sul piano ritmico, spaziale, attorico e drammaturgico. Al di là del fatto che l’interesse di Ronconi per l’economia sia noto, Lehman Trilogy è soprattutto una sorta di oggetto drammaturgico non identificato (e questo lo rende un testo ronconiano per eccellenza) nel suo integrare molti linguaggi, come ha scritto il regista nella sua lucidissima prefazione al testo: “Centosessant’anni di storia del capitalismo vengono squadernati in un continuo saltare fra terzietà saggistiche, flussi romanzeschi, narrazioni di incubi e vaneggiamenti, il tutto punteggiato da isole realistiche in cui l’improvviso andamento da sceneggiatura filmica è inframmezzato di continuo dal commento in contrappunto di un ignoto narratore onnisciente”.
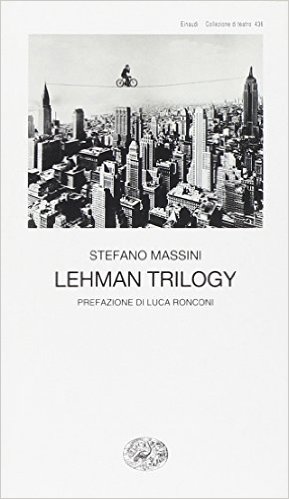 Lo spettacolo si costruisce intorno al racconto, ora monologante ora sciolto in dialogo, dei tre capostipiti della famiglia di banchieri: Henry (Massimo De Francovich), Emanuel (Fabrizio Gifuni), Mayer (Massimo Popolizio); delle seconde generazioni rappresentate dal compulsivo Philip (Paolo Pierobon) e dal polemico cugino Herbert che sceglie la carriera politica (Roberto Zibetti); e della terza generazione dell’inquieto Robert (Fausto Cabra), figlio di Philip. Da un piccolo emporio a Montgomery in Alabama, anzi dal molo di New York dove arriva il primo dei tre fratelli, Henry, per aprire la strada, i Lehman inventano il mestiere immateriale dei mediatori, comprando e rivendendo, per prima cosa, il cotone grezzo delle piantagioni di schiavi, poi il carbone, il caffè, i titoli, le azioni. Henry muore quasi subito, ma gli altri Lehman, padri e figli, conquistano il cuore di Wall Street e dell’economia mondiale, passando attraverso gli sconvolgimenti di tre guerre (quella di Secessione e le due mondiali) e la grande crisi del ’29. La potenza crescente della banca è lo specchio della forza di sviluppo dell’America, paese che la Lehman contribuisce a costruire con i lucrosi investimenti nelle infrastrutture, nell’industria, nei trasporti. E di pari passo si affianca (finendo per disintegrare l’impero) il gioco della finanza pura e la droga sintetica del trading più spregiudicato. Quando la banca di Wall Street crolla nel 2008 (e ormai da tempo non c’è più nessun Lehman a capo dell’istituto che ne porta il nome) per Massini è un crollo mitologico, che mette in luce impietosamente le fallibilità del capitalismo e del sistema. E il tutto si accompagna al mutamento del rapporto con la religione dei padri, l’ebraismo, sostituito, inesorabilmente nello scorrere dei decenni, dalla religione del denaro. I nomi dei riti religiosi, scritti con la luce sulle quinte per dividere in capitoli la vicenda, verso la fine lasciano il posto al nome di altri riti, lo squash, per esempio, il gioco-simbolo dello yuppismo anni ottanta.
Lo spettacolo si costruisce intorno al racconto, ora monologante ora sciolto in dialogo, dei tre capostipiti della famiglia di banchieri: Henry (Massimo De Francovich), Emanuel (Fabrizio Gifuni), Mayer (Massimo Popolizio); delle seconde generazioni rappresentate dal compulsivo Philip (Paolo Pierobon) e dal polemico cugino Herbert che sceglie la carriera politica (Roberto Zibetti); e della terza generazione dell’inquieto Robert (Fausto Cabra), figlio di Philip. Da un piccolo emporio a Montgomery in Alabama, anzi dal molo di New York dove arriva il primo dei tre fratelli, Henry, per aprire la strada, i Lehman inventano il mestiere immateriale dei mediatori, comprando e rivendendo, per prima cosa, il cotone grezzo delle piantagioni di schiavi, poi il carbone, il caffè, i titoli, le azioni. Henry muore quasi subito, ma gli altri Lehman, padri e figli, conquistano il cuore di Wall Street e dell’economia mondiale, passando attraverso gli sconvolgimenti di tre guerre (quella di Secessione e le due mondiali) e la grande crisi del ’29. La potenza crescente della banca è lo specchio della forza di sviluppo dell’America, paese che la Lehman contribuisce a costruire con i lucrosi investimenti nelle infrastrutture, nell’industria, nei trasporti. E di pari passo si affianca (finendo per disintegrare l’impero) il gioco della finanza pura e la droga sintetica del trading più spregiudicato. Quando la banca di Wall Street crolla nel 2008 (e ormai da tempo non c’è più nessun Lehman a capo dell’istituto che ne porta il nome) per Massini è un crollo mitologico, che mette in luce impietosamente le fallibilità del capitalismo e del sistema. E il tutto si accompagna al mutamento del rapporto con la religione dei padri, l’ebraismo, sostituito, inesorabilmente nello scorrere dei decenni, dalla religione del denaro. I nomi dei riti religiosi, scritti con la luce sulle quinte per dividere in capitoli la vicenda, verso la fine lasciano il posto al nome di altri riti, lo squash, per esempio, il gioco-simbolo dello yuppismo anni ottanta.
Non c’è il tono di denuncia (spesso foriero di esiti infelicissimi a teatro), non l’invettiva, né il teatro-documento. L’opera di Massini/Ronconi si muove in uno spazio volutamente con-fusoin cui precipitano, come in un crogiuolo, i dati della realtà storica, i sogni, i presagi di catastrofe, le soggettive, le visioni. Uno spazio tra fatto storico e immaginario, in cui tutto è già dato, tutto è già accaduto. Perché Lehman Trilogy è un rito funebre, in cui il tempo non esiste. Il passato e il presente sono la stessa cosa, come nei sogni. I morti rimangono accanto ai vivi e parlano. Come Henry che rimane a osservare, a raccontare, a commentare, a cantare. Ronconi compie un montaggio straordinariamente sapiente di queste diverse temporalità, di questi piani che mantengono la loro differenza qualitativa pur agendo in contemporanea, mostrandoci un’ulteriore declinazione di quella simultaneità resa celebre dal grande Orlando furioso del 1969.
Colpisce, in questo spettacolo, il silenzio, che funziona da vero e proprio microfono per la parola dell’attore. Qualche effetto sonoro e solo due inserti musicali in oltre cinque ore di spettacolo. Il primo, che riassume gli sconvolgimenti della guerra di secessione, è una marcetta patriottica intonata da Henry, cui si unisce il nero capo di schiavi Testatonda Degoo (Martin Llunga Chishimba), che cantano come la Lehman sia riuscita a navigare nella burrasca del cambiamento (la canzone del “bicchiere che era rimasto in piedi”). Invece, avviandoci alla catastrofe, il twist indiavolato su cui si muove l’ultimo dei Lehman, Robert, sarà registrato, perché è musica imposta dall’esterno, dagli eventi, da ciò che si muove intorno, musica sulla quale è meglio ballare, senza tante storie, perché certe regole, una volta dettate, poi si subiscono.
 Silenzio dunque, e uno spazio svuotato. Niente locomotive, come nel Ronconi degli Ultimi giorni dell’umanità, di Infinities o di altre regie, anche se il testo lo poteva suggerire (il sogno di Emanuel e la sua resistenza a convincersi che la ferrovia è il futuro). In questo suo ultimo spettacolo Ronconi arriva a un’essenzialità definitiva. La scena è scarna, nuda, quasi senza appoggi per gli attori. Pochissimi arredi, qualche sedia che entra dalle botole del sottopalco, il tavolo del consiglio di amministrazione, qualche rialzo per suggerire, per esempio, la banchina di New York dove mette il piede Henry con la sua valigia scalcagnata, il podio del politico Herbert, la tribuna dell’ippodromo dove Bobbie incontra la prima moglie. Tutta la vicenda si srotola in uno spazio neutro e bianco, con il pavimento coperto di vecchie insegne dipinte, scolorite, fuori tempo, che indicano i vari nomi della Lehamn, dal negozio a Montgomery fino alla grande banca. Niente di più lontano dai cartelli brecthiani di queste insegne antiche, che i fratelli fondatori mimano di dipingere pescando un’immaginaria vernice da secchi di latta. Talvolta messe in verticale, quasi sempre distese sul palcoscenico, le insegne paiono lapidi cimiteriali scolorite dalle piogge di oltre un secolo. È dunque uno strano racconto di morti, un requiem, e lo spazio scenico deve suggerirlo e al contempo lasciare campo libero alla parola, strumento della tensione rammemorante dei personaggi/narratori. È, insomma, una vecchia storia eterna, che si snoda in uno spazio quasi asettico, neutro e chiaramente illuminato come una sala d’attesa o un laboratorio anatomico, o come un ipotetico aldilà, in cui i pochissimi oggetti (come l’orologio in alto, che ruota talvolta su stesso, ma segna sempre la stessa ora) assumono una potente, e quasi fragrante, forza di segno. La sbarra nera su cui per decenni, davanti a Wall Street, compie le sue evoluzioni l’acrobata Solomon Paprinskij (Fabrizio Falco) ha la funzione di rendere concreta la metafora di un agire sempre sul filo del rischio, ma anche di far vedere (dividendo la scena come un tratto di penna) lo spazio che si moltiplica. Per esempio, di qua New York dove comincia a operare Emanuel, di là l’Alabama, dove rimane ancora per un po’ il fratello minore Mayer. Quando Solomon cadrà, dopo decenni di onorata carriera di strada, il suo errore è presagio dell’altra caduta.
Silenzio dunque, e uno spazio svuotato. Niente locomotive, come nel Ronconi degli Ultimi giorni dell’umanità, di Infinities o di altre regie, anche se il testo lo poteva suggerire (il sogno di Emanuel e la sua resistenza a convincersi che la ferrovia è il futuro). In questo suo ultimo spettacolo Ronconi arriva a un’essenzialità definitiva. La scena è scarna, nuda, quasi senza appoggi per gli attori. Pochissimi arredi, qualche sedia che entra dalle botole del sottopalco, il tavolo del consiglio di amministrazione, qualche rialzo per suggerire, per esempio, la banchina di New York dove mette il piede Henry con la sua valigia scalcagnata, il podio del politico Herbert, la tribuna dell’ippodromo dove Bobbie incontra la prima moglie. Tutta la vicenda si srotola in uno spazio neutro e bianco, con il pavimento coperto di vecchie insegne dipinte, scolorite, fuori tempo, che indicano i vari nomi della Lehamn, dal negozio a Montgomery fino alla grande banca. Niente di più lontano dai cartelli brecthiani di queste insegne antiche, che i fratelli fondatori mimano di dipingere pescando un’immaginaria vernice da secchi di latta. Talvolta messe in verticale, quasi sempre distese sul palcoscenico, le insegne paiono lapidi cimiteriali scolorite dalle piogge di oltre un secolo. È dunque uno strano racconto di morti, un requiem, e lo spazio scenico deve suggerirlo e al contempo lasciare campo libero alla parola, strumento della tensione rammemorante dei personaggi/narratori. È, insomma, una vecchia storia eterna, che si snoda in uno spazio quasi asettico, neutro e chiaramente illuminato come una sala d’attesa o un laboratorio anatomico, o come un ipotetico aldilà, in cui i pochissimi oggetti (come l’orologio in alto, che ruota talvolta su stesso, ma segna sempre la stessa ora) assumono una potente, e quasi fragrante, forza di segno. La sbarra nera su cui per decenni, davanti a Wall Street, compie le sue evoluzioni l’acrobata Solomon Paprinskij (Fabrizio Falco) ha la funzione di rendere concreta la metafora di un agire sempre sul filo del rischio, ma anche di far vedere (dividendo la scena come un tratto di penna) lo spazio che si moltiplica. Per esempio, di qua New York dove comincia a operare Emanuel, di là l’Alabama, dove rimane ancora per un po’ il fratello minore Mayer. Quando Solomon cadrà, dopo decenni di onorata carriera di strada, il suo errore è presagio dell’altra caduta.
I fratelli e i figli hanno visi naturali e costumi sobri con panciotto e cravatta, alternati a eloquenti tute da padroni-operai (il lavoro prima di tutto). Ma ciascuno si irrigidisce in monumento, si esemplarizza, si muove in una dimensione atemporale da statua-vivente grazie anche al repertorio di gesti e frasi ricorrenti come leitmotiv studiati (già nel testo) per ognuno. Ci sono i movimenti degli arti di Emanuel detto “il braccio” per la sua spinta all’azione, il sorriso che risolve tutto di Mayer detto “la patata”, il mordersi le labbra di Bobbie, il mantra“non sono d’accordo” di Herbert, l’ansia di annotare tutto dell’iper razionale Philip, cifre, programmi, financo le papabili mogli. Le truccature vistose dell’acrobata Salomon lo collegano, invece, agli altri due personaggi/metafora: gli squali dell’ultima fase della Lehman, il greco Peterson (Raffaele Esposito) e l’ungherese Gluksman (Denis Fasolo), quest’ultimo vero pirata della finanza creativa e delle speculazioni.
I due stanno inerti a terra come Golem pronti a prendere vita, figure distantissime dall’iconografia cinematografica dei vari Gekko o “lupi di Wall Street”, eppure profondamente inquietanti nella loro immobilità scomposta di Frankenstein prossimi a entrare in gioco. Ma attenzione a credere che al tempo dei grandi uomini si sostituisca l’era dei mostri. Del tutto immune da improbabili ricostruzioni nostalgiche, il lavoro di Massini/Ronconi mostra che gli uni e gli altri sono frutto della stessa logica, figli della stessa storia, e che di quelle antiche contraddizioni i mostri non sono che le ultime, estreme, naturali conseguenze.
Certo non è una storia di donne Lehman Trilogy, che contano poco o niente qui. È profondamente dentro un tempo/mondo di maschi, in cui le donne sono sempre la stessa figura che torna, ora come madre amorevole ancorché incolore e scelta proprio perché scialba (la moglie di Philip e madre di Bobbie), ora come moglie persecutoria (le tre mogli di Bobbie), tutte affidate a un’unica attrice (Francesca Ciocchetti), una scelta certo non inusuale per Ronconi, basti ricordare la “gemellarità” di Franca Nuti e Marisa Fabbri in John Gabriel Borkman. Ed è appunto in una stanza con sei uomini, tutti i Lehman dal capostipite Henry in poi, che si attende la notizia della morte della banca, data per telefono a Henry, che chiude così il cerchio.
federica.mazzocchi@unito.it
F Mazzocchi insegna storia del teatro all’Università di Torino
Sul fronte oscuro dell’economia e Tra epopea contemporanea e tragedia antica: anche Peter Kammarer e Doriana Legge hanno recensito Lehman Trilogy per il numero di aprile 2015.


