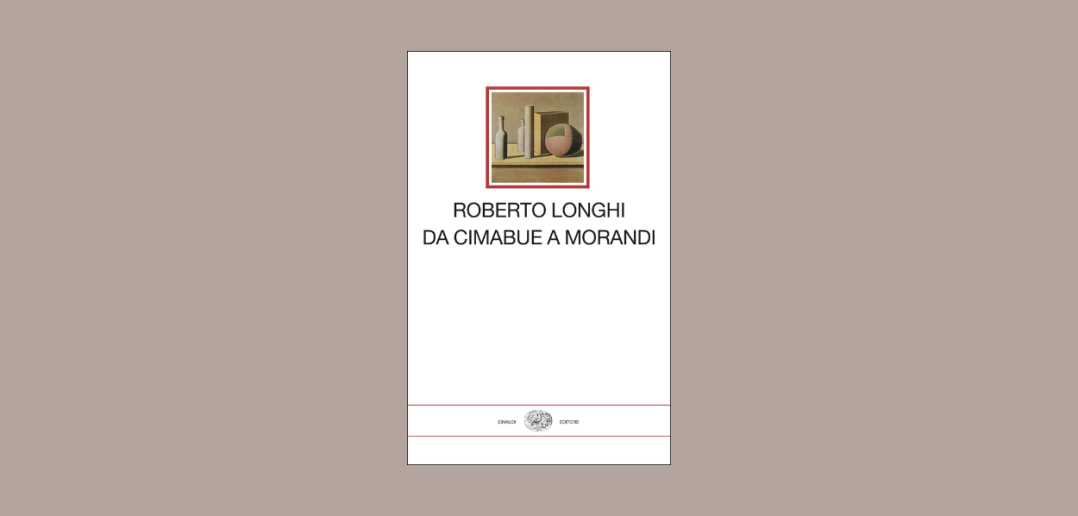Figure poche, introduzioni troppe
di Massimo Ferretti
Roberto Longhi
Da Cimabue a Morandi
a cura di Cristina Acidini e Maria Cristina Bandera, saggio introduttivo di Lina Bolzoni,
pp. XXXVIII-1160, € 100,
Einaudi, Torino 2024
Fu Dante Isella, agli albori della collana, a caldeggiare un “Meridiano” per Longhi, da affidarsi necessariamente a Gianfranco Contini. Quando uscì, nel 1973, Sansoni aveva pubblicato sì e no metà delle Opere complete del massimo storico dell’arte, morto da tre anni. Non era un problema, questo: Contini ne conosceva bene la parte restante. Quello vero era farne entrare una parte rappresentativa nelle dimensioni di un “Meridiano”, soprattutto per l’assenza di riproduzioni. D’altronde, l’intento era far conoscere più largamente uno dei massimi scrittori italiani del Novecento, tanto che il volume si aprì con una qualificatissima Antologia su Longhi scrittore. Introducendolo, Contini non nascose le difficoltà dell’operazione, che non sbriciolò sotto l’insegna “Le più belle pagine…”. Si dovettero però sacrificare le note (leggereste L’Adalgisa senza quelle?); le “fortune critiche” che insegnavano a mantenere l’intreccio fra storia e storiografia; talvolta sezioni importanti di uno scritto. Saggi di storia della pittura italiana, dichiarava il sottotitolo, stranamente omesso in questo “Millennio” conforme in toto alle scelte di Contini. Che avrà rinunciato a malincuore, scegliendo tale criterio, ai momenti di riflessione teorica del formalista fattosi storicista empirico (Proposte per una critica d’arte); alle pagine centrate sulla fragile natura materiale delle opere d’arte; alle congiunture sovrannazionali della pittura sei-settecentesca; al raggio europeo dei maggiori fatti artistici dell’Otto-Novecento. E soprattutto, a quella trascendente griglia storica venne subordinato il reale svolgimento del critico-scrittore. A fare un passo indietro, scrisse Pier Paolo Pasolini, fu proprio “la storia dello stile di Longhi”.
L’ideale disegno storico-artistico era tuttavia una bussola utile ai lettori con qualche ricordo liceale della materia. Fatto sta che il volume ebbe successo: dodici ristampe al 2011. Non che sia servito molto agli storici dell’arte, neppure in erba (ai quali si spera bene che venga indicato Longhi cum figuris). Ma se oggi trova posto nei manuali liceali di letteratura e se sono così frequenti gli studi letterari e linguistici su di lui, molto merito dovrà andare al “Meridiano” curato da Contini. Oggi la situazione è cambiata. Non solo perché in mezzo secolo sono riemersi inediti ed epistolari, e con essi l’iter di Longhi. Quel “Meridiano” non è più un’abbordabile alternativa ai 18 tomi rilegati in verde da cercare in biblioteca o da comprare dopo aver messo assieme una sfilza di paghette settimanali. L’editore Abscondita propone in formato ridotto sei dei suoi maggiori libri o saggi e due ne annuncia per quest’anno (certo, le riproduzioni sono quello che sono). Ci saranno ragioni di mercato, se il “Meridiano” non era più in libreria.
In forma editoriale non meno canonizzante, è stato qui riproposto con due novità. La prima è “un corredo di illustrazioni in riferimento ai testi”. Cosa sono mai 51 riproduzioni rispetto alla fitta trama di opere d’arte che intesse la scrittura di Longhi? Una goccia d’acqua in mare. Si corre poi il rischio di far percepire in modo improprio il metro di “qualità” con l’iniqua assegnazione di una figura (talvolta due) per ciascun scritto: Officina ferrarese come Ricordo di Trombadori. E almeno di primo acchito, si potrebbe credere che Francesco Trombadori e Alberto Magnelli pesino nel Novecento di Longhi quanto Carlo Carrà e Giorgio Morandi. Tanto valeva farne a meno, delle illustrazioni. Anche perché a esse non si fa rinvio nei testi; e le didascalie, quando servirebbero a dire che l’opinione di Longhi è diversa da quella oggi corrente, sono un po’ sibilline e comunque fra loro difformi. Forse sarebbe stata più efficace una scelta dei disegni che Longhi faceva d’après o un montaggio di riproduzioni che proponesse una complessiva interpretazione visiva. Senza contare che è oggi possibile – almeno in parte – sopperire alla diminuzione dovuta all’assenza di figure. Sarebbe bello se la Fondazione Longhi, benemerita nell’aver portato a termine le Opere complete, ne mettesse online il corpus delle illustrazioni.
L’altra novità del “Millennio” è “soprattutto una premessa per ciascun saggio scritta da esperti di ogni argomento”. Era necessario averne uno per il Giudizio sul Duecento e un altro per i due “commenti alle tavole” scelti fra quanti chiudono lo stesso saggio? O affidare a due distinte persone il Dialogo fra Caravaggio e Tiepolo, come se si trattasse di metterlo in scena? L’evidente assenza di un criterio sufficientemente unitario ha fatto sì che le premesse abbiano a volte proporzione inversa rispetto ai testi. Introduzioni a libri interi sono relativamente brevi e orientative (spesso le migliori), mentre quelle a testi corti o frammentari propongono approfondimenti bibliografici che interessano chi si preoccupa innanzitutto di quel particolare problema. C’è una Prefazione che in corpo piccolo occupa spazio maggiore del testo di Longhi; altre si avvicinano a tale sbilanciamento. In più, ognuno sembra aver scritto la propria premessa secondo l’estro personale. Nel complesso, si è spostato l’impianto di Contini da una destinazione letteraria a quella storico-artistica.
Per entrambe le destinazioni servirebbe oggi una silloge che proponesse i testi, eventualmente anche quelli assenti nelle Opere complete, in base all’itinerario intellettuale di Longhi. A chi pratica storia della letteratura o della lingua non nasconderebbe troppo la profonda scansione diacronica; agli storici dell’arte potrebbe insegnare a meglio riferire i giudizi di Longhi al quadro di cultura, oltre che di condizioni materiali e conoscitive, in cui furono espressi.
massimo.ferretti@sns.it
M. Ferretti ha insegnato storia dell’arte alla Scuola Normale di Pisa
Un controllatissimo delirio
di Jacopo Parodi
Come definire “scrittore” chi non ha lasciato romanzi, poesie, prose liriche? Chi non ha parlato di amori, di avventure picaresche, di miserie umane? Roberto Longhi, storico dell’arte di riferimento del Novecento italiano, si è occupato con rigore di tecniche artistiche, del loro prepotente materializzarsi. Dunque si interessa di cose, e non di uomini, tantomeno delle loro passioni. Non è facile riassumere la valenza letteraria di questa riproposizione einaudiana, per i “Millenni”, dell’antologia Da Cimabue a Morandi, cioè della scelta degli scritti longhiani, curata da Gianfranco Contini, principe indiscusso della filologia letteraria, per i “Meridiani” Mondadori. Dove finisce lo “scienziato”, il tecnico dalla penna sapiente, e dove invece incomincia lo scrittore?
Si potrebbe tentare la via dell’“abbandono empatico”. Uno dei massimi allievi di Longhi, Giuliano Briganti, si augurava, utilizzando tale espressione, di poter raggiungere nella scrittura quel fuoco e quell’intensità emotiva, tipicamente longhiani, che mettono in diretta relazione, quasi in un controllassimo delirio, il critico e l’oggetto d’arte. In quella brama miracolosa di un istante di verità cui abbandonarsi, dovrebbero compiersi tutti i misteri, chiarirsi i sommi enigmi, perché il quadro, ma anche la stampa, la statua, il capitello incarnano, per scelta dello studioso-veggente, lo strumento di qualsiasi risposta esistenziale. Il veicolo di un’evocazione di storie indecifrabili, di vicende lontanissime. Si tratta di un intrico di volti che si affacciano nella prosa ecfrastica di Longhi: artisti dal nome obliato ma spuntati fuori da un dettaglio notato per la prima volta, ombre cui si è dato l’onore, o la pietà, di un’attribuzione. E poi committenti, falegnami, trasportatori, apprendisti di bottega che circondano, per esempio, un resuscitato Michelangelo Merisi da Caravaggio dal buio caotico e tormentato del Seicento.
Lina Bolzoni, studiosa del rapporto tra parole e immagini, nel suo testo introduttivo in sostituzione di quello di Contini, sceglie di non consegnare interamente Longhi alla letteratura, a differenza di quanto cercava di fare spregiudicatamente il grande filologo. Svanisce quindi la provocazione di Contini? L’originale proposta di lettura di Bolzoni risiede nel riprendere, espandendone e aggiornandone decisamente la prospettiva, l’interpretazione continiana di un Longhi attore, che, di fronte al mondo annichilito in un vuoto di significato, presta la propria voce, multiforme e camaleontica, a tutte le cose della realtà. A metà fra lo stregone e l’interprete drammatico, Longhi ridà vita alla sarabanda dell’esistenza, a patto che essa trovi la strada dell’arte sublimata dalla sua parola. In un incrocio di riflessi e di finzioni (poesia verbale e poesia visiva), si compie il miracolo, che è un sovvertimento generale. Ciò che è vero diventa falso: la falsificazione offerta dalle arti, assottigliandosi il confine delle distinzioni tecniche, è l’unico modo di raggiungere la gioia festosa di una verità. É l’approdo di un dialogo tra differenti forme dell’espressione: la parola dipinta, scolpita, artigianalmente, pesantemente costruita e quella detta, scritta, labile e ovunque trasportabile. Senza farne prevalere nessuna, potremmo dire che concorrono entrambe a sfidare il nulla strabordante e noioso della vita. Possiamo allora immergerci nella favola longhiana e credere, nella superficie di Giovanni Bellini o di Caravaggio, che il mondo esista davvero.
jacopo.parodi@sns.it
J. Parodi è ricercatore in storia della critica alle Università di Pisa e di Siena