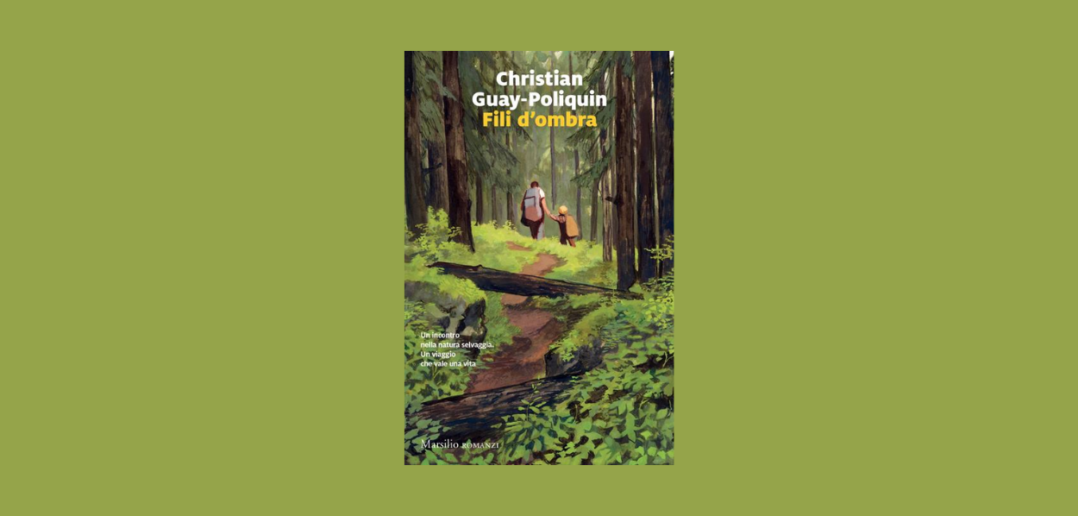Il blackout distopico mette in luce qualcosa
Intervista a Christian Guay-Poliquin di Teresa Lussone
La foresta. Vorrei cominciare da lì. La frase in esergo, “Ecco la porta, ecco l’aria aperta. Itur in antiquam silvam”, una citazione di Stevenson che a sua volta riprende Virgilio (“Vanno in una selva annosa”), lascia intendere immediatamente che la foresta in cui è ambientato il romanzo abbia un valore simbolico e si richiami ad un archetipo.
La foresta è uno spazio mitico e paradossale, protettivo e al contempo ostile. Da un lato essa offre rifugio, dall’altro può rivelarsi minacciosa. La foresta è, dunque, il luogo per eccellenza del rovesciamento. È il luogo in cui qualcosa può apparire all’improvviso, come il luogo in cui qualcosa può scomparire. Questa duplicità le conferisce il suo fascino. Non c’è nulla che non possa accadere nella foresta: un essere incantato può giungere all’improvviso, un abisso può aprirsi. È il luogo del paradosso, di quello che ci sfugge. La foresta lascia sempre un segno, un segno che non è necessariamente negativo e che allo stesso tempo potrebbe non essere completamente positivo. L’immagine della foresta e la sua simbologia sono capaci di risvegliare ciò che è sopito in noi e, come scrivo nel romanzo, nessuna creatura esce indenne dall’abbraccio della foresta.
Benché sia un luogo mitico, mi sembra, però, che non sia priva di relazioni con la nostra società e che possa persino essere considerata uno specchio deformante della realtà.
Sì, lo è certamente. E lo è in funzione dello stato d’animo individuale. La foresta, multiforme e proteiforme, è il riflesso delle nostre speranze e delle nostre paure. Essa muta, quindi, sotto lo sguardo di ciascuno. Può essere vista come luogo dalla natura lussureggiante o persino come un deserto: Tocqueville e Chateaubriand, per esempio, si servono proprio della parola “deserto” per descrivere la foresta.
Un altro tema fondamentale di Fili d’ombra è quello della famiglia. Cosa hanno in comune, in questo romanzo, la foresta e la famiglia?
In qualche modo l’una è metafora dell’altra, in quanto anche nel caso della famiglia notiamo come quello che ci protegge può allo stesso tempo essere quello che ci soffoca. All’inizio, il personaggio va in cerca della famiglia perché essa garantisce la sicurezza fisica e morale. La famiglia è il luogo della conoscenza, del savoir-faire e del savoir-vivre nella foresta: è grazie alla famiglia che si impara come sopravvivere nella foresta e come trarre profitto da questa. Il sapere rassicura perché, in quanto radicato nel passato e destinato a reiterarsi nel futuro, offre la risposta all’emergenza del blackout. Anche quando la nuova condizione sembra far pensare alla necessità di cambiare le carte in tavola, la famiglia risponde: “Abbiamo sempre fatto così e continueremo a fare così”. A un certo punto, però, l’irruzione di un personaggio estraneo alla famiglia, Olio, prospetta la possibilità di rompere con la linearità della tradizione e suggerisce nuovi modi di venire a patti con il presente, anche a costo di allontanarsi dalle proprie origini.
A dire il vero, sembra un clan più che una famiglia.
Sì, è così. Questa famiglia è un luogo esclusivo, claustrofobico, chiuso in sé stesso, da cui i membri esterni sono espulsi perché troppo diversi. In gioco non c’è solo il contendersi le risorse, bensì una più generale diffidenza verso l’altro, percepito come una minaccia in quanto capace di mettere in luce le nostre debolezze, rimaste nascoste fino a quel momento. Ed è questa presa di consapevolezza che spingerà il protagonista a decidere di lasciare la sua famiglia.
Sì, si allontana dalla famiglia imposta dalla tradizione, ma mi sembra importante che il nuovo legame non sia completamente scevro da un senso della famiglia. Si replicano alcune dinamiche familiari, per esempio si ritrova un senso della paternità.
C’è un interrogativo che sottende la scrittura: che cos’è una famiglia? Cosa crea una famiglia? È una questione su cui mi sono interrogato a lungo. Credo che il legame di sangue conti davvero poco, che sia solo un aspetto della questione. Penso, invece, che il tempo trascorso insieme sia fondamentale, così pure il senso di dipendenza reciproca e l’assunzione di responsabilità nei confronti di qualcuno. Nel caso del protagonista è interessante osservare come egli si assuma molto rapidamente una responsabilità verso Olio, che è la sua famiglia d’elezione, ma solo molto più lentamente ammetta con sé stesso di aver compiuto questa scelta.
Un’altra cosa che il protagonista fa, molto lentamente, è quella di adattarsi alle menzogne di Olio, fino a farle proprie. Olio è un bugiardo, un bugiardo patentato ma meraviglioso. E nel finale del romanzo si scopre che talvolta le sue bugie anticipano la realtà: come è possibile?
Nel romanzo c’è un lato cripto-onirico che si richiama ai grandi classici della finzione postapocalittica. Amo destreggiarmi tra i diversi livelli di realtà e in questa peculiarità della menzogna c’è anche un riferimento alla forza della parola. È come quando nei libri per bambini basta dire Abracadabra affinché un evento, magicamente, si realizzi. È qualcosa che mi affascina, ma anche che mi diverte molto mentre scrivo! Nell’episodio a cui allude, che potrebbe del resto essere interpretato in modi diversi, c’è poi un riferimento a Saint-Exupéry e al Piccolo Principe, così come nel momento in cui Olio compare per la prima volta.
La menzogna si potrebbe legare a un altro aspetto, quello dei segreti, dei misteri. Non tutti vengono svelati. Non ha paura che il lettore si senta poco “coccolato”?
Così come nella vita, mi piace che ci siano aspetti o eventi su cui non ci si sofferma troppo, che non vengono nominati o spiegati. A volte questo sarebbe una deviazione rispetto al racconto. Preferisco limitarmi a orientare la curiosità del lettore attraverso alcuni indizi, piuttosto che soddisfarla completamente.
Oggetti obsoleti di un’altra era
di Teresa Lussone
Christian Guay-Poliquin
Fili d’ombra
ed. orig. 2021, trad. dal francese di Francesco Bruno,
pp. 288, € 18,
Marsilio, Venezia 2024La benzina, l’orologio, la bussola, il calendario. E la foresta, naturalmente. Una foresta ammaliante o spaventosa, dove si fanno incontri “rari e decisivi”. Queste le immagini intorno a cui si snoda Fili d’ombra, ultimo romanzo del quebecchese Christian Guay-Poliquin. La narrazione si apre con un uomo che, in una foresta silenziosa, schiude le palpebre e si accorge che un lupo lo osserva con i suoi occhi gialli. Vorrebbe alzarsi e scappare, ma è ferito, dolorante, vulnerabile come lo sono tutti gli uomini dopo il blackout generalizzato che ha sconvolto l’esistenza. Le città sono ormai state abbandonate, la sopravvivenza è possibile solo nella foresta. A fatica, l’uomo si mette in marcia per raggiungere il capanno di caccia dove è rifugiata la sua famiglia. Cerca di ritrovare la strada, necessità reale e al tempo stesso etica. “Il blackout elettrico” scherza l’autore, “consente di mettere in luce quello che abitualmente passa inosservato”: la catastrofe permette di vedere dentro sé stessi oppure di vedere il nostro vicino.
In questo caso, il vicino è Olio, un dodicenne impertinente che prende la bussola del protagonista e lancia in acqua il suo orologio, ma con cui l’uomo, per un tacito accordo che sfugge alla comprensione, prosegue il suo percorso. Quello che più lo irrita, è il fatto che il ragazzino sia un bugiardo. Solo più avanti si capirà che la menzogna è il simbolo della necessità, compresa da Olio prima che dagli adulti, di ricreare il futuro e di liberarsi del passato. Fortemente ancorata al passato è, invece, la famiglia del protagonista. Lo dimostra l’ossessione per la benzina, di cui una tanica “troneggia sul tavolo della scrivania”. Eppure, quella benzina stantia sarà presto inservibile. Come l’orologio, la bussola, il calendario degli anni precedenti che la famiglia si ostina a utilizzare, la benzina è un retaggio di un tempo in cui l’uomo si illudeva di imporre la sua razionalità sullo spazio e sul tempo. Sarà, però, nel rapporto agli altri che verrà a crearsi una frattura insanabile tra la famiglia e la “coppia”. Mentre la famiglia rifiuta di mostrarsi solidale con altri clan, Olio e il protagonista sono convinti che la sopravvivenza passi anche dalla condivisione delle poche risorse. Ci si rende conto allora che l’apparente allontanamento dalla realtà proposto dal romanzo non è un’evasione ludica, bensì uno strumento per osservare con distacco alcune questioni della nostra contemporaneità, prima di tutto la crisi ambientale. La generazione attuale deve ribellarsi alla precedente che nega la necessità di riconfigurare i rapporti con il mondo e resta ancorata a un modo di vita inattuale ma rassicurante. Ed è nello smascheramento delle illusioni del passato e nella propensione al futuro che Guay-Poliquin riesce a conquistare uno spazio originale in un genere, quello del racconto distopico, talvolta cupo e privo di speranza.