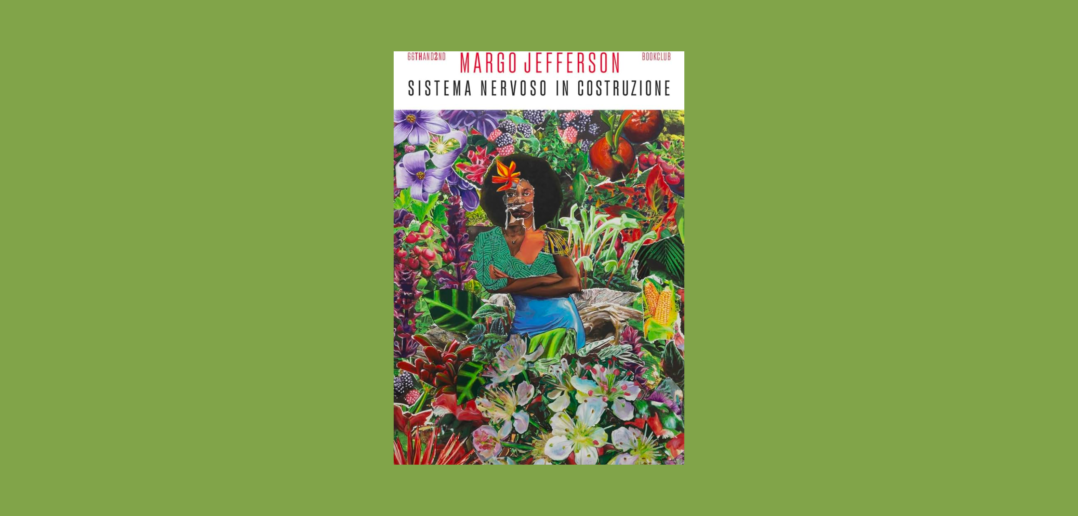Istruzioni al racconto di sé
di Nicolò Bellon
Margo Jefferson
Sistema nervoso in costruzione
ed. orig. 202, trad. dall’inglese di Sara Antonelli,
pp. 169, € 17,00,
66thand2nd, Roma 2023
Ci sono due cose che può fare un memoir, e sono forse le due cose che, per generalizzazione massima, compie la letteratura tutta: fare ordine al mondo, o restituirlo per quello che è.
Nel primo caso va ricostruita una cronologia degli eventi, vanno riordinate le memorie, varate le fotografie del passato e ogni scritto, che ciò porti alla costruzione o alla demolizione di un mito, alla genesi di un sé riuscito o in crisi, poco importa: in questo memoir si riconoscerà una narrazione lineare, piana, un punto d’inizio (la nascita, il battesimo) e un punto d’arrivo (l’io per quel che è nel momento del narrare), i nodi vengono sciolti, le nevrosi risolte, i conti tornano. Due buoni esempi: L’educazione di Tara Westover, cresciuta in una famiglia di mormoni estremisti da cui poi si è emancipata, o l’epopea sportiva e familiare di Andre Agassi raccontata da J. R. Moehringer in Open.
Accanto a questo tipo di racconto del sé si muove, in direzione ostinata e contraria, un modo diverso di narrare. Disordinato, libero. Facile pensare a Sebald, al suo Austerlitz e a Gli anelli di Saturno, e a ogni altro suo scritto. Ma pure a I vagabondi di Olga Tokarczuk, e ancora a Maggie Nelson, quando ne Gli argonauti parla di suo marito che prima era una donna, o quando s’incapriccia su tutto ciò che un colore può significare in Bluets. Guardando al panorama nazionale, due nomi, tra gli altri: Emanuele Trevi che ruba le vite di chi lo circonda per dire di sè (in Qualcosa di scritto è il caso di Pasolini e Laura Betti, in Sogni e favole spetta ad Amelia Rosselli, Arturo Patten e Metastasi, nell’ultimo La casa del mago prende la vita del padre Mario, noto psicanalista); e Claudia Durastanti, per quell’autobiografia frattale che è La straniera.
Questi preferiscono a un evolversi della narrazione lineare una struttura costellazione che funziona per associazione d’idee, dove una canzone rimanda a un amore e un amore a una città e la città a un fratello e il fratello a un libro letto, e così via. È un procedere erratico, scomposto ma non per questo impreciso. Ricco di citazioni al cinema, alla musica, all’arte varia, e rimandi ad aneddoti piccoli e grandi, personali o collettivi.
Così si muove Margo Jefferson, scrittrice e giornalista, nel suo ultimo libro, Sistema nervoso in costruzione, memoir o (come da lei chiamata) “autobiografia caratteriale”.
Dire di che parla un libro che cerca di intrappolare la vita nel suo inciampare, e quindi nel suo farsi e disfarsi, in ogni sua contraddizione, parrebbe impossibile. Ci si può provare, e lo si può fare, dicendo che forse Jefferson prova a rispondere a una domanda, che è: di che siamo fatti? E nel rispondere, spolvera vecchi ricordi di famiglia, propone stralci di canzoni jazz, e cita Gertrude Stein, Katherine Mansfield, Fitzgerald e Hawthorne, Wordsworth, Willa Cather, e lo fa con una lingua che ruba dal cinema, dalla musica, dall’arte varia. Così ripercorre l’infanzia, l’adolescenza, la maturità. Così ricorda le battaglie femministe degli anni Settanta, e il sogno della sorella di farsi ballerina. Scompone e ricompone una possibile genealogia, sostituendo ai parenti di sangue scrittori, artisti, atletica celebrità. Dicendo al mondo, e quindi a se stessa, che tutto ciò che l’essere umano è composto di tante piccole cose banali: frasi sentite, appuntate, dimenticate, foto sparse, memorie aggrovigliate, controversie, bugie, sregolatezze e inibite possibilità d’essere. Jefferson abbatte le mura del memoir, facendosi altro, all’altro guardando. Muta in Ike Turner, dialoga con Du Bois e George Eliot.
Ci vuole buon fiato e molta fiducia per non impazzire davanti alle sue acrobazie linguistiche e connessioni neuronali. Rapsodica, scomposta, psichica, irregolare. Jefferson che è donna di ieri e di oggi, del domani, e si muove nel campo del possibile: inciampa, cancella, cestina, recupera. Soprattutto, nelle parti più belle di Sistema nervoso in costruzione (che è pure saggio, album di figurine, diario e bloc-notes): s’interroga. Sul verbo più giusto da usare – che sia esporre, diseppellire o giudicare. Sulle parole adatte con cui chiudere un paragrafo. Sulle ragioni e sui torti. Ed espone il dubbio, chiede sicura di non ricevere risposta. Continua a chiedere senza dar risposta, com’è forse giusto faccia la letteratura.
Questo suo Sistema nervoso in costruzione è fatto di parti che saltano, scoppiano, si spezzano, si aggregano, sfrecciano, fluttuano. E Jefferson fa quel che già faceva nel precedente Negroland (tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da 66thand2nd), cioè: indicarci la luna per dirci di guardare il dito; cioè: parlarci d’altro per parlarci di sé, perché sa che è più interessante parlar d’altro che di sé, pure in questi tempi fatti d’autofiction e di gossip. Certo, la luna è il punto, ma non è quello l’importante, e può dircelo lei che ha passato una vita – da critica e insegnante – a esercitare il proprio sguardo sull’altro. Jefferson è regista, direttrice della fotografia, montatrice, accorpa, allontana, mette in pausa e riprende a piacere.
Stralci sparsi di quando parla di Cather e del suo Il canto dell’allodola (riportiamo corsivi, grassetti, maiuscoli dal testo così come Jefferson li ha usati): “LETTORE, QUESTO È UN PROCEDIMENTO ARGOMENTATIVO. Per cui inizierò ricreandomi in forma di insegnante. Eccomi qua, intenta a prendere appunti sul testo. A espandere, a integrare […], a compensare quel che non dissi”, segue elenco numerato di tesi e antitesi, e poi: “RICORDA: QUESTO È UN PROCEIMENTO ARGOMENTATIVO”, ancora, dopo poco: “STOP! Torni tra noi, professoressa Jefferson. Ha sprecato tutto questo tempo”, subito dopo essersela presa con Cather perché donna e lesbica in un’America ultraconservatrice eppure innamorata della sua protagonista bianca e bionda(“Willa Cather, so chi è tua madre”): “UN ENTR’ACTE – Queste confessioni e ammissioni mi hanno sfinita. Ho bisogno di una pausa immaginativa. Ho bisogno di riprendermi” e allora lascia il posto alla conversazione immaginata tra Du Bois ed Elliot (“ELIOT: Cominciai ad avere coscienza di uno stadio della mia abnorme sensibilità… DU BOIS: Ricordo bene quando l’ombra mi piombò addosso”) che concluderà con una scritta centrale, in maiuscolo, rassettata: FINE – simile chiusa ha il libro stesso, che va finire con una domanda aperta sul diritto di essere stanchi e la scritta BLACKOUT.
A uno sguardo superficiale parrebbero prove generali d’uno spettacolo nel suo farsi, ma gli attenti sapranno riconoscere il talento di chi possiede grande abilità tecnica e ingegno creativo, a tal punto d’affidarsi e seguirla in questa sua storia confusa, senza la pretesa di far ordine.
Quindi la si ascolta raccontare di quando derideva con la sorella Denise la Mami di Hattie McDaniel in Via col vento perché era nera come loro ma assai scema, e quando dice che tutti hanno bisogno di un minstrel man nella vita e che il suo è Bing Crosby, e mentre riscrive la morte dello zio Tom e quando s’interroga sull’estasi di Willa Cather davanti alla pelle bianca della sua eroina ne Il canto dell’allodola. E ancora mentre fa dialogare James Baldwin con Sammy Davis Jr. e quando riscrive il finale di una sua storia d’amore con un bucaniere, e lo fa con i versi di Woolf, poi con quelli di T. S. Eliot, e poi con una scena di The Wire. La si ascolta richiamare in scena tutte le sue mille sé rubate a Mansfield mentre ci ricorda che se Isadora Duncan diceva di essere una ballerina solista, lei invece da sola non ha ballato mai.
C’è un racconto (che poi è un saggio) di Jefferson che compare nell’antologia Un lavoro da donne (curata da Sinéad Gleeson e Kim Gordon, Sur, 2023), si chiama Diaforesi ed è dedicato a Ella Fitzgerald. Di più, al sudore di Ella Fitzgerald. Il racconto-saggio torna in parte riscritto e approfondito nel secondo capitolo di questo libro, forse perché ogni essere umano si fonda su alcune ossessioni primarie e ricorrenti. Nel caso di Jefferson sono la razza, l’arte (nella forma del canto, della letteratura e della danza) e un certo modello di donna (colta, libera, arrabbiata). Di questo parla negli ultimi due capitoli di Sistema nervoso in costruzione, e ne parla attraverso le storie della sua nonna nera, della sorella che voleva diventare come Martha Graham e ora non c’è più, e di Josephine Baker. Ballerina, attrice, attivista prima omaggiata da Charles De Gaulle per il suo impegno nella IIGM poi profilata dall’FBI, ragazza in fuga sempre. Più che diva, dea. Baker che incarna tutto: la disperazione di un popolo lacerato, frustato, silenziato, la forza, la follia, il desiderio, la controversia. Donna fatta d’altre donne, di leggende passate e possibili scenari.
Margo Jefferson riproduce su carta (nella forma scomposta, aliena, antipatica ma affascinante di questo libro) ciò che Baker ha rappresentato per la vita con il suo corpo: l’idea di una donna che è un impasto di mondi, lingue, idee, amori, disprezzi, folgorazioni e fratture. Una donna che non ha paura di prendersi tutto, di invocare l’incendio, di percorrere strade sconosciute. E davanti al vuoto non esista a ballare.