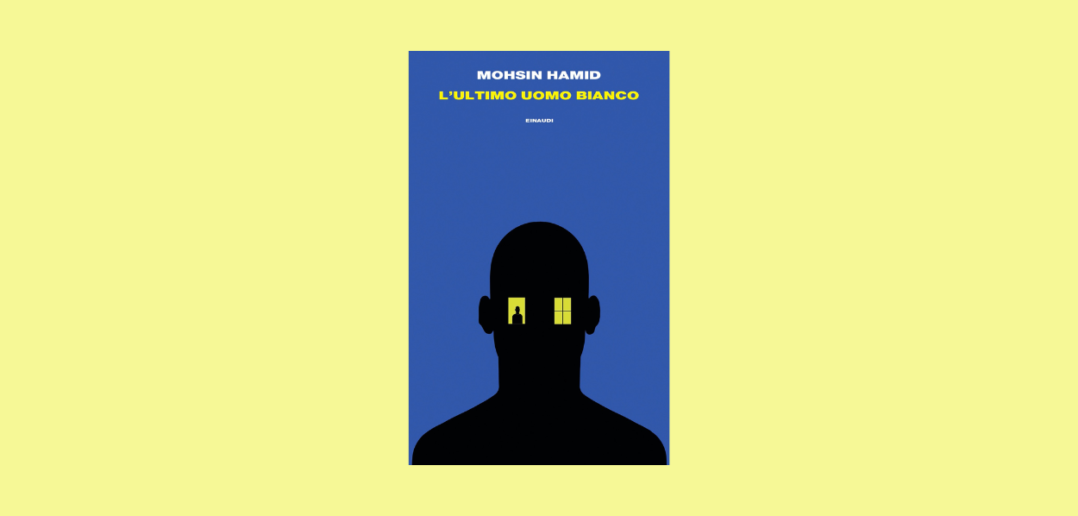di Giacomo Raccis
Mohsin Hamid
L’ultimo uomo bianco
traduzione dall’inglese di Norman Gobetti,
pp. 136, € 16,00
Einaudi, Torino 2023
Diceva Julio Cortázar che il racconto fantastico si distingue da quello realistico soltanto perché porta alle estreme conseguenze una situazione che alla base è reale: per Cortázar era il finale il luogo in cui il fantastico si mostrava, lasciando esplodere le contraddizioni abitualmente tacitate nella realtà di tutti i giorni. Le cose non vanno molto diversamente se, ribaltando lo schema, si pone quell’elemento all’inizio del racconto: un’anomalia che innesca una serie di reazioni, piccole e grandi, che procedendo a cascata finiscono per trasformare radicalmente le coordinate della realtà per come siamo abituati a riconoscerla. L’ultimo uomo bianco di Mohsin Hamid è costruito proprio in questo modo. Una mattina Anders, uomo bianco intorno ai quarant’anni, cittadino di un anonimo centro urbano di un imprecisato occidente contemporaneo, si risveglia con la pelle nera.
Il dispositivo narrativo è tradizionale, ma gli esiti possono essere anche molto originali, soprattutto se quella piccola trasformazione non rappresenta il destino eccentrico di un uomo isolato, destinato a distinguersi da tutti i suoi simili (dei cui disagi, tuttavia, finisce per essere esempio), bensì è una sorte condivisa. Perché, dopo Anders, anche altre persone subiscono quell’improvvisa trasformazione e così, a poco a poco, gli equilibri di una città prevalentemente bianca si modificano, le persone nere sono sempre di più e, alla fine, quando anche “l’ultimo uomo bianco” sarà morto, ne diventeranno gli unici abitanti.
Dopo il grande successo di Exit West, Hamid torna in questo romanzo a sollecitare un’immaginazione narrativa che riesce a concentrare in pochi, discreti tratti inverosimili i reagenti necessari a mostrare le derive possibili a cui la nostra civiltà è esposta. L’ultimo uomo bianco assomiglia a un apologo che, trasposto nella misura romanzesca, dà vita a una sorta di esperimento sociale, verificando il valore simbolico che può assumere il colore della pelle e, soprattutto, l’elemento identitario che più o meno consapevolmente vi assegniamo. Un romanzo “sulla perdita del privilegio”, recita la presentazione nella bandella, e in effetti L’ultimo uomo bianco registra le reazioni sconsiderate all’imprevista trasformazione somatica, come la rabbia di Anders nello scoprirsi nero, o il senso di vergogna (ritroviamo qui tratti che rimandano alla Macchia umana di Philip Roth) che lo spinge a uscire di casa con occhiali da sole e cappuccio per non farsi riconoscere. Riconoscersi: è questo che si rivela fin da subito come il centro nevralgico del romanzo. Il cambio di colore mette in crisi il riconoscimento, proprio e da parte degli altri, innescando ripulse viscerali, ma anche sintonie inaspettate, o indesiderate.
La prosa di Hamid scorre piana, delicata ma anche diretta, registrando gli sconvolgimenti sociali, gli scontri armati, le paranoie collettive che le trasformazioni somatiche producono (alimentate anche dai social network, amplificatori di inverificate leggende), ma esplorando anche la dimensione intima dei rapporti personali, osservati nella piccola bolla familiare composta da Anders e Oona, dal padre di lui e dalla madre di lei. È in questa cellula minima che si possono misurare le oscillazioni del pregiudizio, laddove l’affetto e il legame di sangue producono crepe nel muro di convinzioni e costruzioni identitarie su cui si edifica oggi il conflitto sociale. E proprio la famiglia, per Hamid, è il nucleo da cui è possibile guardare al futuro, in un mondo devastato da impulsi antisociali e depredato delle sue risorse naturali. Solo proiettandovi i nostri figli riusciamo a vedere il tempo che verrà e ci possiamo convincere, forse, dell’importanza di apparecchiarlo per il meglio.