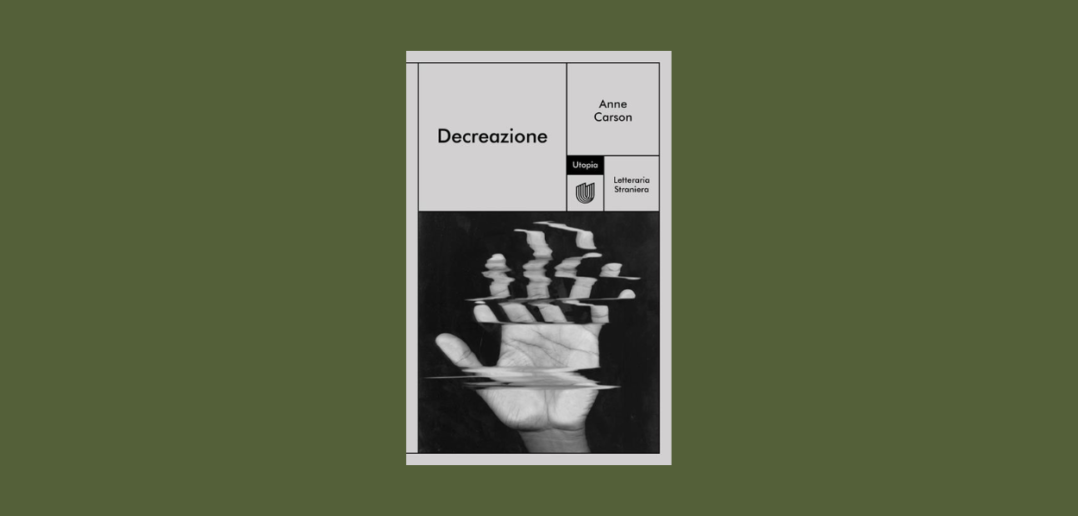Raccontare per non annullarsi, saccheggiando altri spiriti
di Micol Jalla
“Una citazione (…) è un taglio, una sezione, uno spicchio dell’arancia di qualcun altro. Si succhia lo spicchio, si getta la scorza e via, sui pattini”. Così Anne Carson, in riferimento al trattato Sul Sublime di Longino, saggista greco del secolo, implicitamente definisce anche la propria poietica: come banditi, saccheggiare e poi “scappare con un punto di vista”, che penetra nell’io di chi scrive al punto che diventa difficile, vedi ininfluente, distinguere ciò che è proprio da ciò che non lo è.
Carson procede tra scrittori, filosofi, poetesse, attrici, registi “a salti, saltelli e sgambettii” – parole di Michel de Montaigne in epigrafe a Decreazione, uscito per Utopia nel marzo 2023 nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli –, nel tentativo, irrisolto, di decrearsi, di annullare il proprio io per creare in sé il vuoto indispensabile per poter accogliere la grazia. In una forma che non ha paura né bisogno di essere definita, Decreazione (che nell’originale ha per sottotitolo Poetry, essays and opera) prende avvio da brevi liriche sulla madre “mai non tenera”, resoconto poetico e amoroso dei suoi ultimi tempi, della sua “ultima lezione”, prima che lei non si faccia altro che “vento vitreo”, perché “qualunque cosa dicano sul tempo, la vita si muove solo in una direzione”. E allora la figlia, orfana, vorrebbe solo dormire. Forse per questo segue un saggio in cui Carson ripercorre, dono a chi legge, il suo sapere letterario sul sonno, “lastra di tempo fuorilegge”.
Non stupisce che Carson, da ragazza, volesse disegnare, non scrivere: le immagini che crea si stagliano prepotenti e aggraziate, svettano dalle parole prendendo forma e corpo. A un certo punto, intorno ai vent’anni, ha iniziato a dare titoli a ciò che disegnava, finché i titoli sono diventati sempre più lunghi e i disegni sono scomparsi. Semplice. Molte delle sue opere, per altro, riflettono anche graficamente questo processo di ideazione che ha origine nella visualizzazione: la disposizione del testo sulle pagine ha spesso una valenza semiotica rilevante, ricreando silenzi, immagini, sensazioni. Dopo quello sul sonno, in Decreazione troviamo un saggio sul sublime in Longino e in Antonioni – e in particolare sulla schiuma, su ciò che resta, sul fuori-copione del sublime stesso – e una rapsodia sull’arrivo del regista in manicomio, luogo in cui “gli estranei (Antonioni) entrano alla velocità sbagliata”. Colpisce, nei saggi, il tono quasi amicale: nessuno sfoggio di erudizione, ma un sapere sperimentato nutrito dall’eros della condivisione. “Credo che alla gente piaccia sentirsi dire qualcosa che può capire. Altrimenti sarebbe come dare a una persona un regalo che non può scartare. Una crudeltà. E quindi credo che la scrittura sia una sorta di dono che può essere scartato in modi diversi da persone diverse.”
Poi alcuni poemi sul sublime, tra cui un’ode a Monica Vitti e una Sinfonia di sospiri, alcuni Gnosticismi, una sfilza di Se a partire da un’opera di Betty Goodwin; un Oratorio per cinque voci – Un mucchio di pistole –, composto in origine come tributo a Gertrude Stein e rappresentato con Carson stessa tra gli interpreti nel 2003.
Segue Quad, intervista-analisi su due opere televisive di Beckett; una sceneggiatura su Eloisa e Abelardo rappresentati come una coppia da sitcom americana, tra inferno e stanze di motel; un saggio sulle eclissi (quella totale sta a quella parziale come il matrimonio al bacio, secondo un’analogia di Annie Dillard); e finalmente Decreazione. Opera di musica in tre parti introdotta da un saggio sull’opera di tre mistiche: Saffo, Margherita Porete (bruciata viva per nel 1310 per aver scritto un libro sull’amore di Dio che fu considerato eretico) e Simone Weil.
Decreazione è testimonianza di un percorso spirituale, manuale senza indicazioni, miscellanea a tema che saccheggia spiriti amici, che entrano nei pensieri dell’autrice alla giusta velocità. Dio, per Margherita Porete, è “geloso” perché la separa da sé. La decrea, direbbe Simone Weil, ed è un paradosso: per amare Dio è necessario amare sé stessi, ma questo amore rende schiavi e non permette un vero contatto con il divino. Così come paradossale è il fatto stesso di parlare di decreazione: raccontare è funzione dell’io, non permette di annullarsi. L’unico modo per farlo è, con Carson, saccheggiando altri spiriti. L’opera si conclude con Brama, la sceneggiatura di un documentario in cui sembra di vederla, la decreazione. Ma non bisogna illudersi – o preoccuparsi, secondo altri punti di vista: “altre paure faranno presto ritorno”, avverte la scrittrice.
Amore, desiderio, disperazione: nel maggio 2022, è uscito per La Tartaruga La bellezza del marito, già pubblicato in Nuovi Argomenti (Mondadori) nel 2019, il cui sottotitolo – Un saggio romanzato in 29 tanghi – è avvertimento immediato di un’operazione inusuale e non incasellabile in un genere preciso, come sempre avviene per le opere della scrittrice. Ventinove frammenti, tra prosa, poesia e teatro (tanghi, semplicemente; inutile sprecar parole e pensieri per la forma: “scrivi ciò che vuoi scrivere nel modo in cui deve essere scritto”), prendono tutti avvio da parole di Keats. E queste danze fatte di sensualità e relazione seguono, cinepresa dalla lente poetica, il rapporto tra una moglie e un marito. Più che amore, un’ossessione non voluta, una relazione iniziata, finita, ritentata, andata in frantumi, ma inevitabile, perché “la bellezza persuade”, non è un gran segreto, e lega indissolubilmente. Un marito congelato a divinità, idealizzato, che diventa elemento di definizione di sé e dunque necessario alla vita della moglie, che non esiste se non in relazione a lui. Una moglie che si decrea, si nasconde dietro l’io fino a scomparire, lasciando tutta la scena al marito, per poi riaffiorare e di nuovo inabissarsi, novella Aretusa che fugge ma al contempo insegue, incatenata, il suo Alfeo. Un Dongiovanni, lui, fedifrago fin nelle ossa, “fedele a niente”, un uomo “che conosceva più cose sulla battaglia di Borodino di quante ne conoscesse sul corpo di sua moglie, molte di più!”, che la lascia sola all’altare (“Ma non piangere, per favore”); lei consapevole, sempre sofferente, sempre innamorata. “Meglio essere la causa della sua rovina che non esserlo pensa lei”, e resta.
I due ballerini, lui e lei, compaiono e scompaiono, si siedono ad aspettare, in punizione, lasciando solo il compagno, cambiano partner (lui con le amanti, lei, al più, con l’amico di lui, amante delle rime, Ray, ma più sovente sola). E così il marito prende forma in modo sempre più definito: all’inizio confinato nelle immagini di lei – un’affermazione di potere della moglie, almeno nella scrittura? –, visibile solo attraverso il suo spesso filtro, poi conosciuto attraverso le sue menzognere infide lettere, udito nel venticinquesimo tango mentre dialoga con l’amico Ray, finché, nel ventisettesimo, sono suoi i pensieri che seguiamo. Lei si è decreata al punto da potersi fare lui.
La bellezza del marito si chiude con l’elenco dei “saccheggiati”, in alcuni casi citati nei tanghi in modo esplicito, in altri un’ispirazione, ma non è rilevante: spicchio succhiato, scorza gettata, e poi “via, sui pattini”. Via su un sentiero antico e contemporaneo, senz’altro nuovo. Forward only, come dice Teseo a Eracle in H of H Playbook, riscrittura dell’Eracle euripideo. Via da ciò che si è stati per andare avanti, via a resuscitare il canone attraverso gli sviluppi inattesi della propria intimità: forward only.