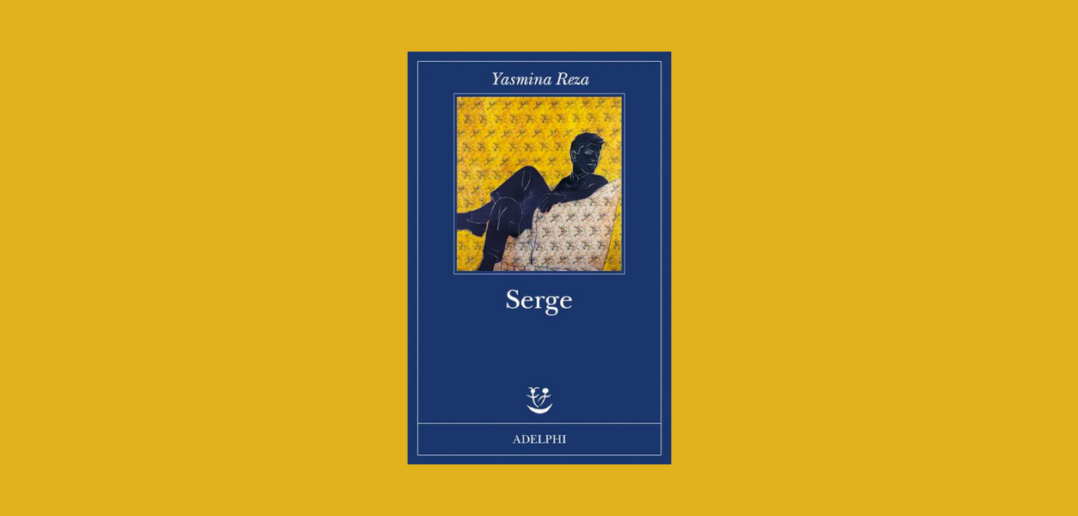Yasmina Reza intervistata dagli studenti di Roma Tor Vergata
a cura di Alessio Rischia
Quanto sono significativi i dettagli nei suoi romanzi? Pensiamo ad esempio alla scena in cui Serge, protagonista del suo ultimo libro, afferra con le dita un bignè della torta che sta mangiando al ristorante.
Credo che i dettagli siano ciò che più caratterizza il nostro rapporto con il mondo. È un rapporto che si svolge attraverso piccolissime cose, nel legame con gli oggetti, o nei legami sottili con gli altri. Per cui la nostra vita può essere raccontata quasi solo attraverso i particolari. Provo una sorta di gioia, come lettrice, nell’assistere all’osservazione dei dettagli da parte di un autore. Ed è la medesima gioia che cerco di provare nello scrivere.
A proposito dell’ingresso della grande storia (con la visita ad Auschwitz raccontata in Serge) nella sua narrativa. Si tratta di una svolta, di un’evoluzione?
È molto difficile, per me, analizzare quello che faccio. Provo una forte reticenza, come una paura. Temo che se mi mettessi a esaminare il mio lavoro, se provassi a guardarlo con occhi da studiosa, rischierei di perdere l’istinto che mi guida normalmente. Sono perciò la persona meno adatta per rispondere a questo tipo di domande. Farò comunque un tentativo. Se c’è un’evoluzione nella mia scrittura, su questo non posso dire nulla. Ma credo di aver sempre affermato, nello scrivere, la superiorità del piccolo sul grande. Non solo, cioè, la superiorità del dettaglio rispetto ai massimi sistemi, ma la chiusura individuale dentro di sé in rapporto alle grandi idee o alle grandi speranze che nutriamo circa le nostre qualità, quel che potremmo fare, o la persona ideale che dovremmo cercare di essere. Gli uomini amano raffigurarsi grandiosamente. Io ho sempre creduto invece in una superiorità, di fatto, delle piccole preoccupazioni. Ciò che è grandioso risulta sempre inferiore, dal punto di vista delle nostre emozioni, se confrontato alle piccole preoccupazioni. E questo aspetto, ritengo, non è cambiato da quando ho cominciato a scrivere.
Tra le sue prime opere rientrano alcune scritture autobiografiche (Hammerklavier, Nulle part). Ne vedremo altre in futuro, magari dedicate a memorie familiari?
Anzitutto non so mai cosa scriverò dopo. Ogni volta mi dico che forse non ci sarà più niente, forse non avrò più energia, né la necessità interiore di scrivere. Ed è una possibilità che mi spaventa eppure esiste. Perché avrei molta paura di scrivere solo per scrivere, o di scrivere qualcosa di troppo. Non mi piacerebbe trovarmi in quella situazione. Riguardo ai testi autobiografici che ho scritto, che rivelano – credo – una dimensione universale, o almeno così sembra, li ho scritti senza pensare che sarebbero stati pubblicati. Erano testi destinati a rimanere nel cassetto. E credo che una certa loro freschezza derivi dal fatto che li ho scritti un po’ come si scatta una fotografia ai propri figli. Descrivo il corpo di mio padre nei suoi ultimi giorni, oppure una serata con un’amica. Piccoli fatti della mia vita che non credevo potessero un giorno interessare un pubblico. Penso che se oggi mi mettessi a scrivere delle cose simili, ma con la consapevolezza d’una eventuale pubblicazione, farei qualcosa di tutt’altra natura, e di decisamente meno buono. Dunque non credo di volermi avventurare ancora in quella direzione.
I personaggi dei romanzi hanno un loro modello nella realtà oppure sono creature di fantasia? Qual è la sua esperienza?
Per quanto concerne la mia esperienza dirò onestamente, sì, ci sono sempre all’inizio uno o due modelli reali. O comunque il personaggio viene plasmato attorno a una persona. Ma ciò avviene nelle prime righe. Dopo accade questa magia della letteratura per cui non appena si comincia a creare il personaggio lui spicca il volo da solo, e nel giro di poche pagine diviene del tutto resistente a imposizioni esterne o colpi di mano. Ha una sua propria logica. E quella logica costringe il demiurgo, il suo creatore, ad aggiustarlo in qualche modo e riformularlo. Gli si manda allora qualcun altro per contrastarlo, e così via. C’è una sorta di lotta tra autore e personaggio. E alla fine ci si rende conto di aver creato qualcuno che è del tutto sconosciuto, che in fondo non risulta né simpatico né antipatico. Ed è questa la cosa meravigliosa, aver creato un essere fatto di carta che ci sfugge completamente.
Nel teatro come nei romanzi compaiono vari oggetti legati al quotidiano, oppure ad altre funzioni, come nel caso di un quadro o di una fotografia. Questa disseminazione di oggetti è un processo volontario?
Credo che un aspetto specifico della mia scrittura sia il fatto di procedere molto liberamente, senza alcuna preclusione. Per cui non imbastisco un’architettura che funziona per capitoli, ma procedo con un unico getto, interrotto da piccoli vuoti. E prendo tutto quello che viene. Se è una fotografia di Robert Frank, ad esempio, e trovo che è pertinente per quel luogo, la inserisco. Non ho alcun tabù letterario, ma nemmeno regole che mi impongo. Non ho una modalità specifica di costruzione, è tutto molto istintivo. E ho l’impressione che se funziona, funziona.
alessiorischia@gmail.com
A. Rischia è dottorando all’Università Tor Vergata di Roma
recensione di Luca Bevilacqua
Yasmina Reza
Serge
ed. orig. 2021, trad. dal francese di Daniela Salomoni,
pp. 186, € 19,
Adelphi, Milano 2022Come ci si prepara alla morte? La nostra, oppure quella di un genitore, o di un amico malato. E come ci si avvicina alla morte collettiva dei milioni di individui spazzati via dall’Europa nel giro di una manciata di anni? Morte atroce sotto ogni aspetto: per il modo, per l’età delle vittime (si stima un milione e mezzo di bambini e ragazzi uccisi o usati per esperimenti durante la Shoah). Morte che supera ogni possibilità di rappresentazione, e che proprio per questo – ci viene detto – ognuno dovrebbe andare a vedere nel luogo emblematico in cui si è consumata, Auschwitz. E qui di nuovo l’idea di preparativo. Bisogna predisporsi, anche mentalmente, per vedere Auschwitz. Ma una volta che si è giunti sul posto, non è realmente la morte l’oggetto della visione. Tutt’al più gli edifici, i vialetti, le camere a gas dove sfila il corteo di tutti quelli che sono lì come noi, “in tenuta semibalneare, canottiere, sneakers colorate, pantaloncini, tutine, abitini a fiori”. E ancor più vivo di quello spettacolo, sono vivi i nostri pensieri, le nostre emozioni, e le piccole cose della nostra esistenza privata. Che non soltanto non è interrotta, ma subisce come una accelerazione che può condurci a dilemmi del tutto inadeguati alle circostanze: mi sarò commosso abbastanza? Mi faccio un selfie?
L’ultimo romanzo di Yasmina Reza, Serge, come i precedenti, così come la recente pièce Anne-Marie la beltà (Adelphi, 2021), si aggira intorno alla domanda posta all’inizio: come ci si prepara alla morte? In verità la questione non è formulata direttamente. Eppure ogni azione, ogni parola dei personaggi, comprese quelle più frivole e allegre, sembrano stagliarsi sullo sfondo cupo di un impossibile preparativo. Questo perché Reza, con la sua opera, non fa che riformulare incessantemente la sola questione della letteratura: come vivono gli esseri umani nel tempo che è loro concesso prima di morire?
Una soluzione contemplata da millenni, descritta da filosofie antiche e attuali, consiste nel vivere l’attesa senza curarsi di alcun preparativo. Fintantoché la morte non c’è, finché l’età o la malattia non l’annunciano come imminente, bisogna pensarci il meno possibile e godersi invece la vita. Ed è la visione, o forse piuttosto il carattere, del protagonista del romanzo, Serge, il quale ama la vita, e ovviamente l’amore, specie se di tipo fisico, e ovviamente il cibo, e l’alcol. E le sigarette. Ma è difficile godersi la vita se si ha paura di morire, e Serge è tremendamente ipocondriaco. Una possibile soluzione è allora affidarsi a oggetti e rituali che scongiurino il male. Serge, superstizioso fino al midollo, “è convinto che il suo destino sia governato dai numeri”.
Queste cose su di lui – comprese le infedeltà e qualche splendido slancio di altruismo egoista – le sappiamo grazie al narratore, Jean, che è suo fratello di qualche anno più piccolo. C’è poi, seguendo l’ordine decrescente di età, una dolce e amabile sorella, Nana. Forse più empatica dei fratelli, forse solo più stupida. Sicuramente animata da ottimi intenti di ordine etico e sociale che si rivelano anch’essi, d’altra parte, un’ottima soluzione alla domanda su come intrattenere la vita in attesa della morte. È sposata con tale Ramos Ochoa, il tipico “personaggio secondario” che però suscita l’impagabile buonumore di chi, come Jean, si diverte a parlar male di lui rimarcandone la mediocrità.
Morte e buonumore. Angoscia del tempo che passa, e desiderio (insopprimibile) di ridere e godersi la vita. Ecco le due forze primigenie ed eterne che si scontrano nelle opere di Yasmina Reza. Non è importante più di tanto, allora, la circostanza che conduce Serge, Jean e Nana ad Auschwitz. O forse invece sì. Perché nessuno di loro tre ha avuto l’idea di quel viaggio insieme. La loro vita, dopo essere stata una cosa sola quando erano bambini, si è come frantumata. Racconta Jean: “sul comodino [di mamma]c’era una foto di noi tre che ridevamo aggrovigliati l’uno con l’altro in una carriola. È come se fossimo stati spinti a una velocità vertiginosa e rovesciati nel tempo”.
Il viaggio nasce da un’idea di Joséphine, la figlia di Serge. Un altro personaggio secondario, poco più di una comparsa (le tante comparse che irrompono nel libro, genitori, ex-mogli, ex-fidanzate, badanti: e chiamarle comparse pare quasi un’offesa). Jo è una ragazza, è il futuro. E al tempo stesso è l’insignificanza – di mestiere fa la truccatrice – perché anagraficamente ancora lontana dal tempo dei preparativi alla morte. In tal senso, più di Serge, la figura davvero memorabile del libro è Maurice, un lontano e ormai vecchissimo zio. Nelle pagine dedicate a lui l’abilità descrittiva e il timbro di voce di Reza rasentano la perfezione. E credo che questo vada sottolineato: nessuno oggi in Francia possiede il timbro di Reza. La traduzione di Daniela Salomoni, intelligente e attentissima, ci restituisce integro, in lingua italiana, questo prezioso patrimonio di stile.