Nessuno è mai troppo perso
di Chiara D’Ippolito
Anna Maria Bruzzone
Ci chiamavano matti
Voci dal manicomio
(1968-1977)
a cura di Marica Setaro e Silvia Calamai,
pp. 416, € 29,
il Saggiatore, Milano 2021
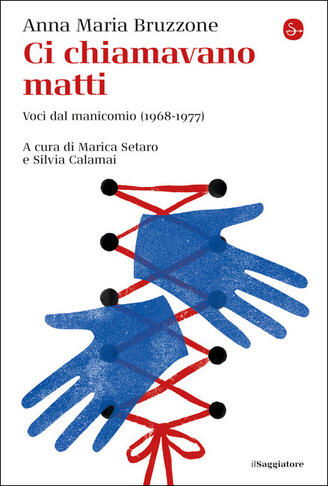 Un taccuino e un piccolo mangianastri usati come dei fonendoscopi attraverso i quali accostarsi al corpo dell’istituzione manicomiale, ascoltarne le profondità e cogliere un rumore di fondo sospeso fra certezza, paura e speranza. Quello composto dalle voci dei pazienti che – nei manicomi in cui, grazie a Franco Basaglia, si stanno abbattendo i muri e rovesciando le logiche dominate da pratiche violente e rapporti verticali disumanizzanti – dicono: “Non saremo mai più chiusi. Guai. Speriamo che non capiti”; “La ruota dell’umanità cammina per avanti; non si può tornare indietro. Capiterebbe una rivolta. Fuggiremmo: la frontiera è qui vicina”; e ancora: “Se Basaglia andasse via, tutti protesterebbero e vorrebbero tenere aperto l’ospedale. Batteremmo i medici. Non sono i più forti, non hanno autorità, hanno paura. L’ospedale non si può più chiudere”. Parte da qui – dall’idea rivoluzionaria di una storica non accademica, pioniera della storia orale, di accostarsi alla voce di uomini e donne piegati dalla storia della follia – la ricerca “avventurosa” e “ricca di colpi di scena” che ha portato alla ripubblicazione, per il Saggiatore, di Ci chiamavano matti di Anna Maria Bruzzone. Un libro che, pubblicato da Einaudi nel 1979, aveva raccolto le trascrizioni delle interviste realizzate, due anni prima, ai pazienti dell’Ospedale Neuropsichiatrico di Arezzo, in via di dismissione dopo l’arrivo dello psichiatra “basagliano” Agostino Pirella. E che ora ritorna arricchito dal materiale prezioso e inedito ritrovato dalle due curatrici Marica Setaro e Silvia Calamai nell’“officina operosa” di “una pensatrice e ricercatrice che può insegnarci ancora tanto”, come ci ricorda la voce della storica Anna Bravo, da poco scomparsa, che chiude la premessa.
Un taccuino e un piccolo mangianastri usati come dei fonendoscopi attraverso i quali accostarsi al corpo dell’istituzione manicomiale, ascoltarne le profondità e cogliere un rumore di fondo sospeso fra certezza, paura e speranza. Quello composto dalle voci dei pazienti che – nei manicomi in cui, grazie a Franco Basaglia, si stanno abbattendo i muri e rovesciando le logiche dominate da pratiche violente e rapporti verticali disumanizzanti – dicono: “Non saremo mai più chiusi. Guai. Speriamo che non capiti”; “La ruota dell’umanità cammina per avanti; non si può tornare indietro. Capiterebbe una rivolta. Fuggiremmo: la frontiera è qui vicina”; e ancora: “Se Basaglia andasse via, tutti protesterebbero e vorrebbero tenere aperto l’ospedale. Batteremmo i medici. Non sono i più forti, non hanno autorità, hanno paura. L’ospedale non si può più chiudere”. Parte da qui – dall’idea rivoluzionaria di una storica non accademica, pioniera della storia orale, di accostarsi alla voce di uomini e donne piegati dalla storia della follia – la ricerca “avventurosa” e “ricca di colpi di scena” che ha portato alla ripubblicazione, per il Saggiatore, di Ci chiamavano matti di Anna Maria Bruzzone. Un libro che, pubblicato da Einaudi nel 1979, aveva raccolto le trascrizioni delle interviste realizzate, due anni prima, ai pazienti dell’Ospedale Neuropsichiatrico di Arezzo, in via di dismissione dopo l’arrivo dello psichiatra “basagliano” Agostino Pirella. E che ora ritorna arricchito dal materiale prezioso e inedito ritrovato dalle due curatrici Marica Setaro e Silvia Calamai nell’“officina operosa” di “una pensatrice e ricercatrice che può insegnarci ancora tanto”, come ci ricorda la voce della storica Anna Bravo, da poco scomparsa, che chiude la premessa.
Tutto nasce da una domanda: se Anna Maria Bruzzone aveva raccolto le voci dei degenti di Arezzo con un registratore, dove saranno finite le cassette? Grazie alla mediazione proprio di Anna Bravo, che con Bruzzone aveva condiviso libri e progetti, Setaro e Calamai entrano in contatto con la nipote Paola Chiama. E così, alle pagine di Ci chiamavano matti, si affianca in maniera imprevista tutto il materiale proveniente da una vita di studio centrata sulla consapevolezza che “lo spazio di liberazione e di emancipazione di soggetti deboli, marginali, subalterni (…) si costruisse anche attraverso l’emersione della loro voce”: i diari, i taccuini, i libri, le tesi di ricerca; le registrazioni di Arezzo, che ora fanno parte dell’archivio sonoro dell’Università di Siena; i nastri con le voci delle donne partigiane della Resistenza e delle sopravvissute ai lager nazisti intervistate negli anni e rese protagoniste dei libri La resistenza taciuta (con Rachele Farina, La Pietra 1976 e Bollati Boringhieri 2016) e Le donne di Ravensbrück (con Lidia Beccaria Rolfi, Einaudi 1978 e 2020). Infine, un’ulteriore sorpresa: dall’archivio storico universitario dell’Università di Torino giungono trenta interviste inedite fatte nel 1968 ai pazienti dell’ospedale di Gorizia – dove, da Torino, Anna Maria Bruzzone arrivò come volontaria per completare la propria tesi di specializzazione in psicologia – e che oggi, aprendo e completando questa riedizione, consentono di restituire nella sua interezza il viaggio di una studiosa “eccentrica” nella realtà del manicomio, in quei luoghi di “impossibilità dell’umano” dove “violenza, esclusione, alterità hanno rappresentato la grammatica consunta e bestiale dell’internamento manicomiale”.
Un viaggio in cui, per la prima volta, sono “i matti” a prendere la parola, con i loro trascorsi e le loro riflessioni, i dolori, le speranze e le paure, con il loro sguardo ravvicinato sulla vita e l’evoluzione dell’istituto. Lì dove, dal 1961, Franco Basaglia e la sua équipe stanno mettendo in atto le condizioni per una nuova possibilità di salute mentale in Italia, Bruzzone fa infatti una scelta “immediata e drastica”: per due mesi, vive la quotidianità dell’ospedale, annota tutto ciò che accade nei reparti, intervista i degenti – solo loro, non i medici, non gli infermieri, non gli altri volontari – e diviene testimone della necessità di restituire autonomia e soggettività a quanti hanno subito la violenza dell’istituzione manicomiale. Con i pazienti il colloquio è libero, non ci sono domande e risposte come nello schema classico di un’intervista: Bruzzone si limita a diventare “orecchio della memoria”, “strumento di trasmissione” delle “memorie del sottosuolo” che appunta sui suoi taccuini. Nulla interrompe la storia che il paziente vuole raccontare di sé, esistono solo uno spazio e un’esperienza di scambio dove è possibile riconnettersi a un passato dimenticato e a un futuro da costruire che la pratica della deistituzionalizzazione sta facendo intravedere.
Nelle diverse sezioni del libro, si susseguono così i racconti di chi è arrivato in manicomio da bambino solo perché orfano, oppure povero, o solo troppo irrequieto o troppo silenzioso, e non è mai più uscito; di chi sa di aver avuto la vita contagiata dal “batterio patogeno dell’istituzione”, come Milva C.: “Da piccola ero venuta qui con una infermiera e avevo visto tutte le malate in grigio e chiuse. È meglio ora. L’uomo in un caos diventa un caos. I medici potrebbero chiudere come prima, ma sarebbe un male; l’uomo, fatto vivere come una bestia, diventa bestia. Ho le idee di Basaglia; bisogna portar fuori i malati in gita, da farli rivivere”; di chi, ancora, ha avuto il corpo legato, scioccato, sottoposto a tecniche di contenzione vicine alla tortura, come quella della “maschera”: attorno alla testa dei pazienti si applicava una tela che, progressivamente bagnata, diventava impermeabile all’aria fino a provocare un transitorio soffocamento; di chi, infine, è “troppo perso” e vive in “isola congelata senza storia”, come i degenti del reparto C.
Dopo Gorizia, c’è Arezzo, e il coro delle voci si allarga. Ma perché tornare in manicomio dopo dieci anni? Nell’edizione del 1979, troviamo una riflessione di Bruzzone che ci fornisce la risposta: “Ogni volta che leggevo il testo venivo presa da una delusione che era quasi disperazione. Il racconto sulla pagina mi pareva freddo: non c’era più traccia del calore prodotto dal ritmo, dal timbro, dalle inflessioni della voce, dall’accento toscano spesso bellissimo, e dalle pause, nella loro diversa durata.” La decisione di entrare, all’inizio dell’estate del 1977, in quell’edificio che tutti chiamano “Tetti Rossi” – i muri sono così alti che è possibile vedere solo le tegole – è quindi dettata dalla consapevolezza che l’esercizio della memoria affidato alla carta e alla penna non è più sufficiente. Nelle trascrizioni delle interviste non c’è calore, non ci sono i sorrisi, le pause, i pianti: per “auscultare”, il registratore deve sostituire il taccuino. Questo cambiamento, del resto, va di pari passo con il radicamento dell’esperienza basagliana e con la necessità, sempre più forte, di far trovare alle storie dei pazienti una diffusione più larga, di farle diventare dei “documenti umani” in grado di rappresentare la messa in pratica del rovesciamento istituzionale e restituire una ricchezza che è “il frutto di una maggiore libertà di espressione, di una vita quotidiana che ha mutato passo e non costringe all’abbrutimento”. Le storie di Arezzo, così, diventano “un’esplosione di ricordi e di vita” in cui – accanto al dolore, alla fragilità e alla paura – compare il desiderio di descrivere e ridefinire se stessi. Perché, come ci dice Elvira C., “Ci chiamavano matti, ma non eravamo matti, noi eravamo seri, come tutte l’altre persone”.


