Dal sottosuolo dei giorni
di Roberto Valle
“Le mie lettere sono uno chef-d’oeuvre di alta letteratura”: così scriveva Dostoevskij al fratello Michail in una lettera del 30 settembre 1844. Sebbene abbia più volte affermato di mancare di senso della misura e di non sapere come si scrivono le lettere, considerandole, come Gogol’, una stupidaggine adatta per i farmacisti, Dostoevskij ha posto la scrittura epistolare al di là della conversazione scritta e della dimensione di un presente non sempre memorabile (Fëdor Dostoevskij, Lettere, a cura di Alice Farina, trad. dal russo di Giulia De Florio, Alice Farina e Elena Freda Piredda, pp. 1357, € 75, il Saggiatore, Milano 2020). L’epistolario di Dostoevskij si caratterizza, in primo luogo, come una esemplare e frammentaria opera polemica orientata a disvelare il sottosuolo di un’epoca transitoria e fatale, riuscendo a cogliere le insolubili contraddizioni del suo “venire a essere”. Come afferma Dostoevskij in una lettera del 13 febbraio 1866 indirizzata alla moglie di suo fratello Andrej: “Come è possibile nelle lettere parlare della vita interiore, spirituale?”. Tale interrogativo è centrale per comprendere l’intricata vicenda epistolare di Dostoevskij, che dal punto di vista letterario riesce a far coesistere i molteplici ed eterogenei generi del discorso: la cronaca familiare, il racconto della propria vicenda umana spesso contrassegnata da disgrazie, l’indagine esistenziale e sociale, la riflessione filosofico-politica, la descrizione dell’attività artistica e pubblicistica.
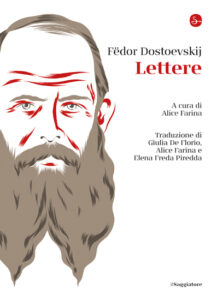 Nel definire la peculiarità del romanzo polifonico di Dostoevskij (Michail Bachtin e il suo circolo. Opere 1919-1930, a cura di Augusto Ponzio, Bompiani 2014), Bachtin afferma che nell’epistolario dello scrittore dominano la parola pluridirezionale a due voci, la polemica nascosta e la confessione. Con il suo primo romanzo, Povera gente (1844), Dostoevskij ha iniziato dalla “parola rifrangente” della forma epistolare che è rivolta a un interlocutore assente e contiene anticipazioni della parola altrui. Non diversamente dal Diario di uno scrittore (1873), l’epistolario di Dostoevskij è un’opera sperimentale che non segue la via del pensiero lineare, ma è un paradossale rovesciamento degli stereotipi esistenziali e istoriosofici della sua epoca e dei diversi generi di discorso codificati. L’epistolario esordisce con la cronaca familiare dalla morte della madre nel 1837 all’arrivo a Pietroburgo, per studiare insieme al fratello Michail alla Scuola di ingegneria, fino alla tragica morte del padre, ucciso dai propri contadini nel 1839. La cronaca familiare subì una cesura con la deportazione nella “casa dei morti” in Siberia a causa della partecipazione dello scrittore all’attività cospirativa del circolo fourierista di Petraševskij: nella sperduta Asia Dostoevskij aveva scoperto, nel corso di quattro anni, la tortura del “comunitarismo forzato” per cui la compagnia delle persone diventava “veleno e contagio”. Nel 1854, nell’esilio a Semipalatinsk, in uno dei più lontani governatorati della steppa Dostoevskij strinse un rapporto amicale con Aleksandr Vrangel’, un giovane barone di origini baltiche procuratore di stato per gli affari civili e penali, con il quale poté riannodare nel Giardino di Cosacchi, una dacia nella steppa, il legame spezzato dei tempi (Jan Brokken, Il Giardino dei Cosacchi, Iperborea 2016). A Semipalatinsk, Dostoevskij aveva conosciuto Marija Dimitrevna Isaeva, moglie di un modesto impiegato doganale, che, diventata vedova, nel 1857 sposò lo scrittore. Il primo e tormentato viaggio sentimentale di Dostoevskij è descritto nelle lettere indirizzate a Vrangel’ e alla stessa Marija Dimitrevna che, con la sua originale vocazione cavalleresca, sembrava votata a una precoce rovina.
Nel definire la peculiarità del romanzo polifonico di Dostoevskij (Michail Bachtin e il suo circolo. Opere 1919-1930, a cura di Augusto Ponzio, Bompiani 2014), Bachtin afferma che nell’epistolario dello scrittore dominano la parola pluridirezionale a due voci, la polemica nascosta e la confessione. Con il suo primo romanzo, Povera gente (1844), Dostoevskij ha iniziato dalla “parola rifrangente” della forma epistolare che è rivolta a un interlocutore assente e contiene anticipazioni della parola altrui. Non diversamente dal Diario di uno scrittore (1873), l’epistolario di Dostoevskij è un’opera sperimentale che non segue la via del pensiero lineare, ma è un paradossale rovesciamento degli stereotipi esistenziali e istoriosofici della sua epoca e dei diversi generi di discorso codificati. L’epistolario esordisce con la cronaca familiare dalla morte della madre nel 1837 all’arrivo a Pietroburgo, per studiare insieme al fratello Michail alla Scuola di ingegneria, fino alla tragica morte del padre, ucciso dai propri contadini nel 1839. La cronaca familiare subì una cesura con la deportazione nella “casa dei morti” in Siberia a causa della partecipazione dello scrittore all’attività cospirativa del circolo fourierista di Petraševskij: nella sperduta Asia Dostoevskij aveva scoperto, nel corso di quattro anni, la tortura del “comunitarismo forzato” per cui la compagnia delle persone diventava “veleno e contagio”. Nel 1854, nell’esilio a Semipalatinsk, in uno dei più lontani governatorati della steppa Dostoevskij strinse un rapporto amicale con Aleksandr Vrangel’, un giovane barone di origini baltiche procuratore di stato per gli affari civili e penali, con il quale poté riannodare nel Giardino di Cosacchi, una dacia nella steppa, il legame spezzato dei tempi (Jan Brokken, Il Giardino dei Cosacchi, Iperborea 2016). A Semipalatinsk, Dostoevskij aveva conosciuto Marija Dimitrevna Isaeva, moglie di un modesto impiegato doganale, che, diventata vedova, nel 1857 sposò lo scrittore. Il primo e tormentato viaggio sentimentale di Dostoevskij è descritto nelle lettere indirizzate a Vrangel’ e alla stessa Marija Dimitrevna che, con la sua originale vocazione cavalleresca, sembrava votata a una precoce rovina.
Dopo il matrimonio e il ritorno a Pietroburgo nel 1859, la cronaca familiare si intrecciò con le questioni economiche, nel tentativo di conciliare il lavoro artistico con il guadagno, e con la passione per la giovane Apollinarija Suslova. In una lettera alla sorella di Apollinarija, Dostoevskij definiva la sua amante un’“egoista malata” che pretendeva dall’altro tutte le virtù e non perdonava la minima imperfezione e che l’aveva accolto a Parigi con la frase “Sei arrivato un po’ tardi”, perché si era innamorata di un altro. In Europa, Dostoevskij conobbe le “città da gioco”: come scrive in una lettera del settembre 1863, egli si era recato nei casinò al fine di salvare la famiglia dalla rovina economica. Dopo avere sposato la ventenne Anna Grigor’evna Snitkina, la stenografa che lo aveva coadiuvato nella stesura di Rulettenburg (pubblicato dall’editore Stellovskij con il titolo Il giocatore), Dostoevskij soggiornò in una sorta di esilio volontario per quattro anni in Europa, soprattutto per sfuggire ai creditori dopo la morte del fratello Michail con il quale aveva creato due riviste.
Dostoevskij paragonava la propria situazione a quella di Mister Micawber personaggio perennemente indigente e indebitato di David Copperfield di Dickens. Scrivendo da Dresda nel maggio del 1867 ad Apollinarija Suslova, Dostoevskij afferma che dopo la morte del fratello trovava ripugnante vivere, anche perché sfiancato dalla “lotta contro l’indifferenza del pubblico”. A Pietroburgo sembrava impossibile lavorare sia per l’impazienza dei creditori, sia per gli attacchi di epilessia, sia perché si sentiva una sorta di “reietto della famiglia”: Dostoevskij sperava in un risanamento della propria salute e delle proprie economie rimanendo all’estero. Tuttavia, come si evince dalle lettere alla moglie Anna Grigor’evna, il richiamo di Roulettenburg si rivelava fatale, provocando ingenti perdite di denaro e costringendo lo scrittore a vendere e a impegnare i propri miseri averi. Nonostante i reiterati atti di contrizione nel confessare i propri misfatti alla moglie, Dostoevskij affermava di non giocare d’azzardo per divertirsi, ma perché lo riteneva necessario. Nel “catechismo delle qualità e delle virtù di ogni europeo civilizzato” era storicamente iscritta la qualità di mettere insieme un capitale: l’intemperanza e l’audacia dell’epoca capitalista era sfociata nel mercato d’azzardo.
Le lettere sulle città da gioco e Il giocatore possono essere considerati una sorta di trattato sulla genesi e sullo spirito del capitalismo collocati al di là di ogni etica religiosa e razionalista. L’ordine civile europeo, fondato sullo “spirito del realismo speculativo” assurto a religione. Nel suo esilio volontario, Dostoevskij approfondì la riflessione istoriosofica sull’ambivalente rapporto tra l’idea russa e la civiltà europea, confrontandosi sia con il saggio panslavista di Danilevskij Russia ed Europa (1869), sia con l’eccelso pessimismo poetico di Herzen, rivoluzionario ed emigrato di professione, che aveva lucidamente pronosticato il tramonto dell’Europa. Nell’ultimo decennio della vita di Dostoevskij, la cronaca familiare coincise con la stesura del Diario di uno scrittore, alla cui redazione contribuì anche Anna Grigor’evna. La cronaca familiare che si evince dall’epistolario è, perciò, strettamente connessa con le riflessioni filosofico-politiche sui destini della Russia e dell’Europa e con la descrizione del mondo letterario e pubblicistico. Negli anni sessanta del XIX secolo, con le riforme di Alessandro II e con il riconoscimento della glasnost’ (libertà di espressione), la libera circolazione delle idee favoriva l’attività pubblicistica. Dostoevskij si inserì nel dibattito politico-ideologico e, tra il 1861 e il 1865, diresse con il fratello Michail le riviste “Vremja” ed “Epocha” che sostenevano il programma del počvenničestvo (ritorno al suolo natale) e che si ponevano al di là della contrapposizione scolastica tra occidentalisti e slavofili, quale superamento di quella linea invalicabile che separava l’intelligencija dal popolo.
Descrivendo nelle lettere il processo creativo di Delitto e castigo Dostoevskij affermava che il soggetto del suo romanzo non era eccentrico ed era giustificato dalla contemporaneità e dalla “incredibile inconsistenza di idee” dalla quale scaturivano “azioni terribili”. La gratuità del delitto rivelava l’assenza di paura di fronte al castigo e la trasformazione della gioventù russa in un branco di lupi selvatici e nichilisti, svegli e depravati, che nel corso della loro vita erano nel contempo atei e credenti, fanatici e settari. Anche il famoso omicidio dello studente Ivanov da parte di Nečaev, a capo dell’organizzazione sovversiva Narodnaja Rasprava e autore del Catechismo del rivoluzionario, non solo confermava le riflessioni sulle derive criminali del nichilismo, ma ispirò a Dostoevskij I demoni, una sorta di romanzo-poema nel quale si dimostrava come gli inferi del demonismo russo si fossero riversati su coloro che avevano perso la fede nella Russia e nell’ortodossia. Nel descrivere in una lettera a Katkov, pubblicista reazionario, l’idea centrale di I demoni, Dostoevskij presentava per la prima volta la tragica figura del principe Stavrogin come l’idealtipo di un peculiare carattere russo sorto nell’ambito dell’aristocrazia rivoluzionaria e nichilista e che aveva come archetipo Bakunin. Il movimento rivoluzionario russo era sfociato nel terrorismo, quello europeo nella Comune di Parigi: entrambi, non potendo instaurare il paradiso in terra in nome di un’idea di felicità non giustificata dall’esperienza e tratta da Rousseau, aspiravano a distruggere il mondo.
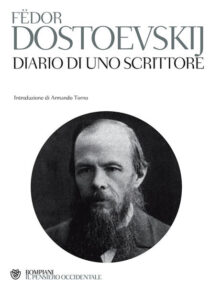 Sebbene fosse accusato dalla riviste del radicalismo populista e rivoluzionario di essere oscurantista e reazionario, Dostoevskij era lo “scrittore di riferimento” della gioventù nichilista, come attesta anche una lettera del 18 aprile 1878 indirizzata agli studenti dell’Università di Mosca, rispondendo alle loro domande sulla “vita interiore” della Russia. Invece di considerare esemplare la “marcescente società russa europea”, i giovani dovevano cercare una parola di verità nel popolo e nella počva (suolo natale): il democraticismo russo, infatti, si era unito agli aristocratici contro il popolo e andava verso il popolo per disprezzarlo. D’altro canto, l’attentato di Vera Zasulič contro il generale Trepov, governatore di Pietroburgo, dimostrava che il popolo non solo non condivideva il terrorismo, ma considerava i nichilisti dei banditi di strada. Dalla seconda metà degli anni settanta, con la pubblicazione del Diario di uno scrittore e con il discorso su Puškin pronunciato l’8 giugno 1880 nella seduta solenne della Società degli amici della letteratura russa, Dostoevskij intrecciò un dialogo epistolare con i suoi lettori: dalle centinaia di lettere ricevute emergeva il “punto di vista autentico e giusto dell’uomo russo”, quale fede di un cambiamento imminente nella mentalità dell’intelligencija che si era separata dal popolo. Dostoevskij era considerato un moltiplicatore di paradossi che indagava sul destino della Russia e dell’umanità al di là del proprio tempo, come attestano anche le lettere nelle quali lo scrittore affronta le questioni inerenti la stesura dei Fratelli Karamazov. Dostoevskij aveva prefigurato l’idea del Grande inquisitore in una lettera del maggio 1869 inviata da Firenze ad Apollon Majkov: collocando le questioni ultime in una prospettiva metastorica, egli avrebbe voluto scrivere un poema che avrebbe dovuto essere una “pietra preziosa originaria” tratta dalla “possente sostanza della vita”.
Sebbene fosse accusato dalla riviste del radicalismo populista e rivoluzionario di essere oscurantista e reazionario, Dostoevskij era lo “scrittore di riferimento” della gioventù nichilista, come attesta anche una lettera del 18 aprile 1878 indirizzata agli studenti dell’Università di Mosca, rispondendo alle loro domande sulla “vita interiore” della Russia. Invece di considerare esemplare la “marcescente società russa europea”, i giovani dovevano cercare una parola di verità nel popolo e nella počva (suolo natale): il democraticismo russo, infatti, si era unito agli aristocratici contro il popolo e andava verso il popolo per disprezzarlo. D’altro canto, l’attentato di Vera Zasulič contro il generale Trepov, governatore di Pietroburgo, dimostrava che il popolo non solo non condivideva il terrorismo, ma considerava i nichilisti dei banditi di strada. Dalla seconda metà degli anni settanta, con la pubblicazione del Diario di uno scrittore e con il discorso su Puškin pronunciato l’8 giugno 1880 nella seduta solenne della Società degli amici della letteratura russa, Dostoevskij intrecciò un dialogo epistolare con i suoi lettori: dalle centinaia di lettere ricevute emergeva il “punto di vista autentico e giusto dell’uomo russo”, quale fede di un cambiamento imminente nella mentalità dell’intelligencija che si era separata dal popolo. Dostoevskij era considerato un moltiplicatore di paradossi che indagava sul destino della Russia e dell’umanità al di là del proprio tempo, come attestano anche le lettere nelle quali lo scrittore affronta le questioni inerenti la stesura dei Fratelli Karamazov. Dostoevskij aveva prefigurato l’idea del Grande inquisitore in una lettera del maggio 1869 inviata da Firenze ad Apollon Majkov: collocando le questioni ultime in una prospettiva metastorica, egli avrebbe voluto scrivere un poema che avrebbe dovuto essere una “pietra preziosa originaria” tratta dalla “possente sostanza della vita”.
Delineando un “quadro ardente” del XVI secolo in Europa, il “rovente pensiero” dello scrittore si proiettava nella visione dei “quadri fantastici del futuro”. Dostoevskij vedeva i due secoli successivi al XIX come compimento del tramonto dell’Occidente: l’Europa del XXI secolo, oscurantista, deturpata e abbrutita, destinata a perire dal momento in cui il papa avrebbe snaturato del tutto Cristo e l’ateismo e il nichilismo avrebbero fatto sprofondare la civiltà europea nelle sue tenebre, inverando l’apoftegma “se Dio non esiste, tutto è permesso”. La Leggenda del Grande Inquisitore è al centro di una vicenda ermeneutica che ha avuto inizio nell’ambito del pensiero filosofico-politico russo del XX secolo (Il Grande Inquisitore. Interpretazioni nel pensiero russo, a cura di Daniela Steila, pp. 274, € 24, Accademia University Press, Torino 2020) e che giunge fino all’apocrifa interpretazione della desolante attualità della globalizzazione che vedrebbe ricomparire lo spettro della “dittatura eudemonistica dell’Inquisitore” nella “serra del comfort” del capitalismo globale (Il Grande Inquisitore. Attualità e ricezione di una metafora assoluta a cura di Renata Badii ed Enrica Fabbri, Mimemis, 2013) Al di là delle semplificazioni parafilosofiche per servire la globalizzazione, il Grande Inquisitore non è una metafora assoluta della tarda modernità, ma una versione satirica sia delle sacre rappresentazioni medievali, sia dell’utopia moderna.
roberto.valle@uniroma1.it
R. Valle insegna storia dell’Europa orientale all’Università La Sapienza di Roma


