Il desiderio che imita la violenza dei terremoti
di Luca Bevilacqua
Pierre Michon
La grande Beune
ed. orig.1996, trad. dal francese di Giuseppe Girimonti Greco,
pp. 76, € 11,
Adelphi, Milano 2020
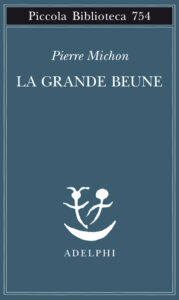 Scrittore è, spesso, qualcuno che ha perso la testa per la lingua. Ci sono beninteso le storie da raccontare, vere o inventate. E ci sono le ossessioni: immagini o fantasmi da cui occorre liberarsi, senza alternativa possibile, neanche fosse in gioco la vita stessa. Ma poi c’è – sopra ogni altra cosa – la lingua. Dentro cui ci si avventura e ci si perde, negandola, polverizzandola, fino a ricrearla straniera: per farla durare intatta un domani. Il lessico, la sintassi, la punteggiatura. Pierre Michon, va detto subito, appartiene a questa tipologia di scrittori. Ai quali corrisponde una categoria ben precisa di lettori: quelli che non temono e anzi cercano il viaggio arduo e a tratti scomodo della prosa. Lettori che per nulla al mondo rinuncerebbero a Rabelais o a Joyce, o a Gadda. Michon esordisce negli anni ottanta, epoca in cui appaiono in Francia le prime prove di coloro che formeranno, se non un gruppo, quantomeno una risposta al nouveau roman. Scrittori che abdicano agli esperimenti formali a favore d’un recupero del reale e della storia (o delle storie): Jean Echenoz, Olivier Rolin, Jean-Philippe Toussaint, François Bon, Emmanuel Carrère (per nominare forse i più noti). Il primo libro di Michon s’intitola Vite minuscole (1984: Adelphi, 2016) e inaugura una scrittura in cui la biografia, sia essa di persone sconosciute oppure notissime (come avviene per Rimbaud il figlio, 1991: Mavida, 2005), è riformulata in termini tanto più autentici quanto più l’invenzione dilaga in una fantasiosa e pervicace verosimiglianza di situazioni o tratti caratteriali.
Scrittore è, spesso, qualcuno che ha perso la testa per la lingua. Ci sono beninteso le storie da raccontare, vere o inventate. E ci sono le ossessioni: immagini o fantasmi da cui occorre liberarsi, senza alternativa possibile, neanche fosse in gioco la vita stessa. Ma poi c’è – sopra ogni altra cosa – la lingua. Dentro cui ci si avventura e ci si perde, negandola, polverizzandola, fino a ricrearla straniera: per farla durare intatta un domani. Il lessico, la sintassi, la punteggiatura. Pierre Michon, va detto subito, appartiene a questa tipologia di scrittori. Ai quali corrisponde una categoria ben precisa di lettori: quelli che non temono e anzi cercano il viaggio arduo e a tratti scomodo della prosa. Lettori che per nulla al mondo rinuncerebbero a Rabelais o a Joyce, o a Gadda. Michon esordisce negli anni ottanta, epoca in cui appaiono in Francia le prime prove di coloro che formeranno, se non un gruppo, quantomeno una risposta al nouveau roman. Scrittori che abdicano agli esperimenti formali a favore d’un recupero del reale e della storia (o delle storie): Jean Echenoz, Olivier Rolin, Jean-Philippe Toussaint, François Bon, Emmanuel Carrère (per nominare forse i più noti). Il primo libro di Michon s’intitola Vite minuscole (1984: Adelphi, 2016) e inaugura una scrittura in cui la biografia, sia essa di persone sconosciute oppure notissime (come avviene per Rimbaud il figlio, 1991: Mavida, 2005), è riformulata in termini tanto più autentici quanto più l’invenzione dilaga in una fantasiosa e pervicace verosimiglianza di situazioni o tratti caratteriali.
La grande Beune, che Adelphi pubblica nella mirabile traduzione di Giuseppe Girimonti Greco, è un breve romanzo uscito in Francia nel 1996. Il protagonista racconta il suo primo incarico, quand’era appena ventenne, come maestro di una scuola elementare nella più oscura provincia francese. È il settembre 1961. Ma fin dalle prime righe l’interesse del lettore, più che dalla modesta esperienza esistenziale, è trasportato dallo sguardo acutissimo di chi la racconta. E dal modo, appunto, in cui è maneggiata la lingua: “A Castelnau non c’è la stazione; è in mezzo al nulla; qualche corriera che parte al mattino da Brive o da Périgueux ti ci scarica la sera tardi, alla fine del suo giro. Ci arrivai di notte, decisamente inebetito, in mezzo a un galoppo di piogge settembrine imbizzarrite contro i fari, nel battito di due grandi tergicristalli; del villaggio non vidi nulla, la pioggia era nera”.
Michon, si direbbe, ha la capacità di vedere le cose come in fondo tutti le vediamo: in maniera immediata e diretta. Con la differenza che normalmente dopo un attimo siamo già distratti, pensiamo ad altro, e trascuriamo di annotare l’unicità di un colore, di una sagoma che si profila nell’ombra, di una certa atmosfera. Spazi aperti e ambienti chiusi. L’opacità della bruma autunnale, la vicinanza di una falesia e, poco sotto, del misterioso fiume che dà il titolo al libro. Gli arredi scolastici primo Novecento e gli scolaretti scalpitanti di ogni epoca. Le grotte dove appaiono dipinti meravigliosi e arcaici. Persone strane e sconosciute che in pochi giorni, come nei romanzi, diventano familiari: tutto, agli occhi del protagonista, sembra annunciare inconcepite libertà e precoci riscatti; oppure, al contrario, remote quanto fatali minacce. E se possiamo definirlo, più che racconto, un romanzo, è per il modo in cui il respiro della pagina sembra riferirsi di continuo a un orizzonte temporale più vasto dei pochi eventi narrati. Non a caso questo piccolo libro (nelle dimensioni) è il frammento superstite di un progetto romanzesco grande e ambizioso, il cui titolo avrebbe dovuto essere, come il celebre quadro, L’origine del mondo. E sempre non a caso, un capitolo si apre con una frase che pare uscita da un romanzo dell’Ottocento, dove protagonista incontrastato è lo scorrere delle stagioni: “Alla fine di novembre cambiò il tempo, le acque si rappresero. I campi inondati gelarono, ciuffi di giunco rinsecchiti spuntavano dritti nel terreno”.
C’è infine il richiamo implicito a una situazione che, a un lettore navigato, torna subito in mente: la visione inattesa – come una vera “apparizione” – d’una donna da adorare e desiderare. Una donna che incanta e paralizza. “Fantasticavo, mi spingevo oltre ogni limite”. Ma non è qui la scialba e idealizzata Mme Arnoux dell’Educazione sentimentale di Flaubert, bensì una sensuale tabaccaia, che sconvolge la carne assai più che lo spirito. Un terzo elemento completa lo schema: la donna reale, quella con cui l’amore fisico c’è, ma che non riesce a scatenare la passione: nel romanzo flaubertiano è Rosanette, qui l’ignara e “provocante” Mado.
Forze primordiali, diremmo telluriche, hanno generato lo scenario su cui si muovono i personaggi di La grande Beune. “Origine del mondo” è infatti quell’urto doloroso dell’incontro, quando il desiderio imita la violenza dei terremoti. O delle acque che scavano caverne, portando vita nelle viscere di pietra.
lucabevi@yahoo.it
L. Bevilacqua insegna letteratura francese all’Università Tor Vergata di Roma


