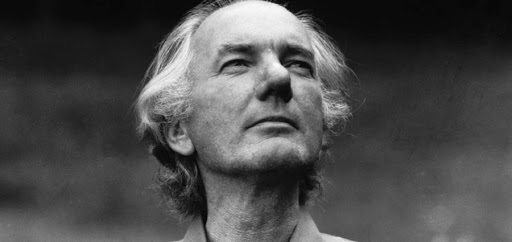recensione di Mauro Maraschi
Thomas Bernhard
MIDLAND A STILFS
traduzione italiana di Giovanna Agabio,
pp. 121, € 12,
Adelphi, 2020
Quando uscì Midland a Stilfs, nel 1971, Thomas Bernhard aveva quarant’anni e aveva già pubblicato Amras (1964), Perturbamento (1967) e La fornace (1970): anche se si fosse fermato lì, magari per dedicarsi al violino, oggi sarebbe comunque uno degli autori più significativi del Novecento. Ma Bernhard non ha mai smesso di dare alle stampe capolavori, da Correzione (1975) e Cemento (1982) fino agli ultimi A colpi d’ascia (1984), Antichi maestri (1985) ed Estinzione (1986). Uno dei suoi meriti è stato quello di aver sempre perseguito una specifica idea di letteratura, assonante con Beckett ma originale, autonoma e mutevole, una letteratura modulare, concepita come una partitura, che di volta in volta combina temi ed espedienti ricorrenti e sempre più rodati. La raccolta Midland a Stilfs, pubblicata da Adelphi per la prima volta in Italia, è esemplare del suo vasto repertorio.
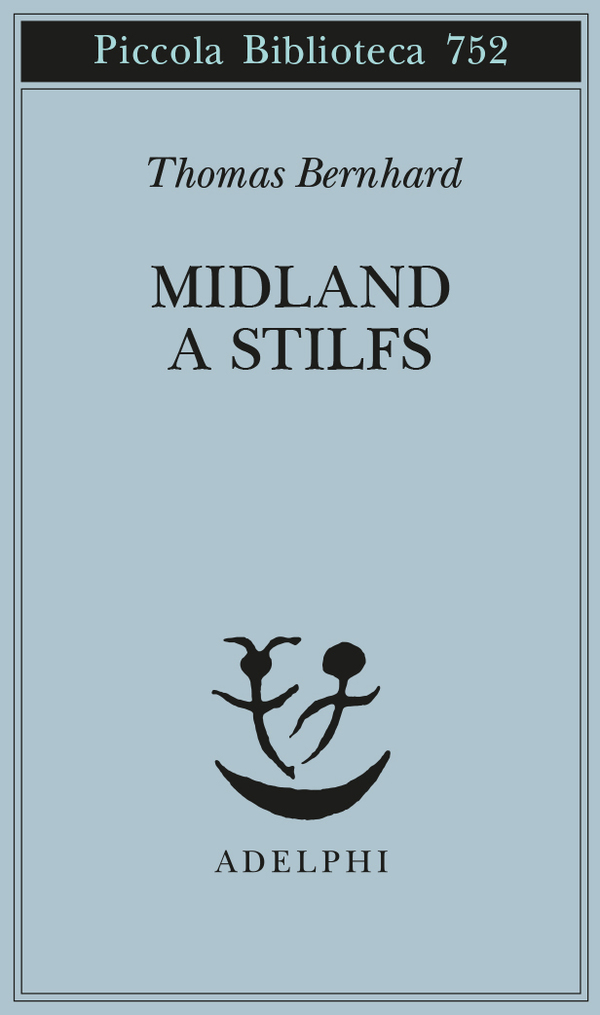 Fin dal suo esordio narrativo con Gelo (1963), a trentadue anni, Bernhard ha affrontato il problema tecnico dell’identità del narratore, e della sua sovrapponibilità allo scrivente e all’autore, risolvendolo in due modi principali: il primo, più classico, legittima la narrazione travestendola da lettera rivolta a una seconda persona che è un puro pretesto (come avviene ne Il mantello di Loden e Sull’Ortles); nella seconda modalità, che potremmo definire “narrazione de relato”, per dar voce al personaggio che lo interessa di più Bernhard ne costruisce un altro preposto a riferirne il pensiero (vedi Gelo o Correzione). Entrambe le modalità comunicano al lettore che la voce narrante non sta raccontando per velleità bensì per dovere, e quindi in una condizione di tensione. Non è un caso se il narratore di Gelo premette subito: «Il compito che mi è stato affidato di osservare il pittore Strauch mi costringe a occuparmi di questo tipo di realtà e di possibilità»; il suo incarico lo autorizza a trasportare il lettore nella logorrea di Strauch, e lo rende un narratore più affidabile di quanto lo sarebbe stato Strauch in prima persona. In Gelo i monologhi sono raccordati da gesti e interazioni, così come nelle opere successive fino a Correzione, il cui narratore non si limita a riferire ma si muove, cammina ed è persino protagonista del siparietto “fisico” che chiude la prima parte del romanzo (l’equivalente di uno scherzo in musica); nello stesso anno di Correzione, il 1975, ha inizio la pubblicazione della cosiddetta autobiografia (L’origine, La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino), che sposterà l’attenzione dal resoconto al memoriale. Nei romanzi autobiografici, tra i quali va annoverato Il nipote di Wittgenstein, Bernhard ricorre inoltre all’autofiction: trasforma se stesso in un personaggio ma non raggiunge mai la coincidenza biografica, con il risultato che, da un punto di vista letterario, il personaggio Bernhard non è più vicino all’uomo Bernhard di quanto lo siano Rudolf, Roithamer e tutti gli altri; Bernhard ha sempre giocato con questa ambiguità, dissociandosi dalle dichiarazioni dei suoi personaggi ma esprimendosi come loro durante le interviste. Al di là del tentativo di delimitare delle fasi nel suo percorso creativo, è possibile rilevare una costante, quel processo di demolizione della forma romanzo che ha raggiunto l’apice con Estinzione (1986), dove nel presente narrativo non accade nulla, se non il ritrovamento delle fotografie che innescano il monologo. D’altronde, lo stesso Bernhard ha chiarito: «[…] non sono un narratore di storie, io odio profondamente le storie. Sono un distruttore di storie, io sono il tipico distruttore di storie. Nel mio lavoro, quando qua e là si formano i primi segni di una storia, o quando in lontananza vedo spuntare da dietro una collina di prosa l’accenno a una storia, io gli sparo addosso»[1].
Fin dal suo esordio narrativo con Gelo (1963), a trentadue anni, Bernhard ha affrontato il problema tecnico dell’identità del narratore, e della sua sovrapponibilità allo scrivente e all’autore, risolvendolo in due modi principali: il primo, più classico, legittima la narrazione travestendola da lettera rivolta a una seconda persona che è un puro pretesto (come avviene ne Il mantello di Loden e Sull’Ortles); nella seconda modalità, che potremmo definire “narrazione de relato”, per dar voce al personaggio che lo interessa di più Bernhard ne costruisce un altro preposto a riferirne il pensiero (vedi Gelo o Correzione). Entrambe le modalità comunicano al lettore che la voce narrante non sta raccontando per velleità bensì per dovere, e quindi in una condizione di tensione. Non è un caso se il narratore di Gelo premette subito: «Il compito che mi è stato affidato di osservare il pittore Strauch mi costringe a occuparmi di questo tipo di realtà e di possibilità»; il suo incarico lo autorizza a trasportare il lettore nella logorrea di Strauch, e lo rende un narratore più affidabile di quanto lo sarebbe stato Strauch in prima persona. In Gelo i monologhi sono raccordati da gesti e interazioni, così come nelle opere successive fino a Correzione, il cui narratore non si limita a riferire ma si muove, cammina ed è persino protagonista del siparietto “fisico” che chiude la prima parte del romanzo (l’equivalente di uno scherzo in musica); nello stesso anno di Correzione, il 1975, ha inizio la pubblicazione della cosiddetta autobiografia (L’origine, La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino), che sposterà l’attenzione dal resoconto al memoriale. Nei romanzi autobiografici, tra i quali va annoverato Il nipote di Wittgenstein, Bernhard ricorre inoltre all’autofiction: trasforma se stesso in un personaggio ma non raggiunge mai la coincidenza biografica, con il risultato che, da un punto di vista letterario, il personaggio Bernhard non è più vicino all’uomo Bernhard di quanto lo siano Rudolf, Roithamer e tutti gli altri; Bernhard ha sempre giocato con questa ambiguità, dissociandosi dalle dichiarazioni dei suoi personaggi ma esprimendosi come loro durante le interviste. Al di là del tentativo di delimitare delle fasi nel suo percorso creativo, è possibile rilevare una costante, quel processo di demolizione della forma romanzo che ha raggiunto l’apice con Estinzione (1986), dove nel presente narrativo non accade nulla, se non il ritrovamento delle fotografie che innescano il monologo. D’altronde, lo stesso Bernhard ha chiarito: «[…] non sono un narratore di storie, io odio profondamente le storie. Sono un distruttore di storie, io sono il tipico distruttore di storie. Nel mio lavoro, quando qua e là si formano i primi segni di una storia, o quando in lontananza vedo spuntare da dietro una collina di prosa l’accenno a una storia, io gli sparo addosso»[1].
In Midland a Stilfs (1971) troviamo un Bernhard già maturo, ma anche alcune varianti interessanti dei suoi impianti e delle sue voci. Il primo racconto, quello eponimo, è affidato a una voce narrante in prima persona plurale che include il narratore, suo fratello Franz e, più passivamente, la sorella Olga; una voce narrante in prima persona plurale appare anche in Amras e in Sull’Ortles, ma in quei casi abbiamo un individuo che parla a nome di un altro personaggio delineato e giustapposto, mentre in Midland a Stilfs il fratello del narratore ne è quasi un doppio, e la voce narrante plurale incarna, più che due individui specifici, l’intera categoria di coloro che in montagna, e in generale nella natura, cercano un rifugio dal mondo e trovano invece il proprio annientamento: «Laggiù pensavamo a un miglioramento. Quassù è cominciato il peggioramento radicale». Il racconto si apre con il timore del narratore per la visita di chiunque giunga a Stilfs «per svagarsi o per calunniare o per distruggere»; il narratore fa eccezione soltanto per l’Inglese, il Midland del titolo, del quale parla con benevolenza nonostante ne disapprovi comportamenti e attitudini; il risultato di quest’ambivalenza è che la voce narrante, già doppia, si quadruplica nell’alternanza di sentimenti opposti, una schizofrenia che spinge i fratelli a fingere entusiasmo per cose in realtà detestate: «Quanto a noi, non leggiamo più giornali da anni, perché la lettura dei giornali, che per decenni ci ha entusiasmato, da un momento all’altro ci ha fatto orrore […] Quando invece è l’Inglese a portarci i giornali, ci avventiamo sopra come se di lettura dei giornali fossimo affamati». Questa doppiezza è sottolineata meta-letterariamente: «Non sarebbe inglese, un Midland, se tutto per lui non avesse due facce, e non si sa mai quale delle due sia la più vile, la più grossolana e meschina» dice la voce narrante, come se non fosse essa stessa la dimostrazione di questa faccia nascosta.
Atipico è anche l’Inglese, determinato a scrivere un’opera monumentale e destinato a fallire come molti protagonisti bernhardiani, ma, diversamente dagli stessi protagonisti bernhardiani, non cupo né autodistruttivo: Midland sembra la prova indiretta che la disperazione è una questione austriaca, che Rudolf, Roithamer e gli altri non avrebbero trasformato il pensiero in una condanna se fossero stati inglesi o comunque non austriaci, forse anche perché «il genio e l’Austria non sono compatibili» (Antichi Maestri). Midland non riesce a manifestare il proprio genio per via della propensione all’enciclopedismo: «Da qui ha origine la sua incapacità di realizzare anche solo una delle migliaia di idee che confluiscono in continuazione nella sua mente addestrata, com’è ovvio, in vista dell’universale». Il suo fallimento intellettuale, però, è la sua salvezza: Konrad (La fornace), Rudolf (Cemento) e Roithamer (Correzione), che al contrario scelgono di specializzarsi rispettivamente sull’udito, su Mendelssohn Bartholdy e su Altensam, diventano rispettivamente un assassino, un reietto e un suicida, mentre Midland, che gode della conoscenza in modo non “concentrato”, è ancora sano di mente e capace di entusiasmo. In Bernhard la specializzazione è sinonimo di genio, perché è se vero che «bisogna saper pensare sempre tutto in un unico istante» (Correzione), bisogna anche scegliere una strada, seguirla fino alla follia e «interrompere il pensiero esattamente prima dell’attimo letale» (Camminare): questo processo, per Bernhard, è l’unica testimonianza del vero genio, che è sempre un genio autodistruttivo.
Il tema di un’opera monumentale concepita in ogni dettaglio ma mai iniziata, al quale Micaela Latini ha dedicato il prezioso La pagina bianca (Mimesis, 2010), questo tema in Midland a Stilfs compare due volte, la prima in riferimento all’Inglese e la seconda in riferimento ai due fratelli, che l’Inglese immagina alle prese con un’opera «epocale» di scienze naturali: «Sì, ci sospetta di tacere intenzionalmente sul fatto che qui a Stilfs […] abbiamo fatto, insieme o ciascuno per conto suo, lavori scientifici che, conformemente alla lucidità delle nostre menti, saranno di altissimo valore». Il fulcro del racconto è però altrove, e per coglierlo è forte la tentazione, suggerita dall’assonanza dei titoli, di fare un parallelo con Kleist a Thun di Robert Walser: in questo racconto del 1907 l’autore svizzero ricostruisce il soggiorno di Heinrich von Kleist (1777-1811) su un’isola del lago di Thun, dove il drammaturgo tedesco si era trasferito per riavvicinarsi alla natura e scrivere più intensamente, e dove rimase talmente scosso di fronte al sublime da dover essere salvato dalla sorella. Kleist a Thun, secondo alcuni, sarebbe ispirato a Lenz (1835) di Büchner, anch’esso basato sul vissuto di uno scrittore, Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792); il Lenz di Büchner viaggia tra le foreste dell’Alsazia, è conteso tra euforia naturalistica e follia, e ritrova una sorta di equilibrio soltanto quando viene riportato nella civiltà. Midland a Stilf chiude idealmente questa genealogia immaginaria di racconti che parlano di una natura idealizzata e in realtà annichilente, con una differenza sostanziale: qui, con piglio satirico, il sublime romantico è diventato uno stereotipo per turisti (magari inglesi) più che una fonte d’ispirazione per scrittori (magari tedeschi).
Un ultimo appunto sul primo racconto. Se in tutta l’opera di Bernhard c’è poco spazio per le donne, alle sorelle è riservato un inquietante ruolo sacrificale, spesso alla base dell’agire maschile: nella Fornace il protagonista ha sposato la sorella, l’ha torturata psicologicamente per anni e infine uccisa; il narratore di Cemento (così come Konrad ne La fornace) addebita alla sorella la responsabilità del proprio fallimento; e in Correzione Roithamer regala un edificio «insensato» alla sorella, che però muore per lo shock non appena lo vede. Allo stesso modo, in Midland a Stilfs abbiamo due sorelle puramente funzionali, una delle quali è morta da tempo e ha spinto l’Inglese ad andare a Stilfs, mentre l’altra è paralizzata e costringe i fratelli a rimanere a Stilfs.
Nel Mantello di Loden (già Il loden, Theoria, 1988) troviamo invece un personaggio femminile dal carattere forte ma anche abominevole. Anche in questo caso abbiamo un narratore plurale, che però appare soltanto nell’incipit, premette che sta riferendo «testualmente» ciò che ha appreso per via epistolare, e cede subito la parola all’avvocato Enderer, che diventa a conti fatti il narratore; questa struttura a scatole cinesi viene sporadicamente ribadita attraverso i tipici incisi bernhardiani: «dice Humer, scrive Enderer». Il racconto vive di sospensione: Enderer si interessa a Humer, un produttore di articoli funebri, perché è convinto che Humer indossi il mantello dello zio morto suicida otto anni prima (il tema dell’utilizzo di indumenti appartenuti ai morti appare anche in Midland in Stilfs: «Adesso Roth indossa unicamente gli abiti dell’amico morto, quando era arrivato l’Inglese, Roth aveva subito indossato l’abito della domenica del suicida»). Soltanto a metà racconto Humer rivela il motivo della sua visita, ovvero l’usurpazione della sua attività e della sua abitazione a opera del figlio e della nuora «sempre spettinata»; al che Enderer mette per un attimo da parte il disprezzo per l’uomo, ma poi conclude il suo resoconto concentrandosi sull’oggetto della propria ossessione, il mantello dello zio morto suicida, e insabbiando così il dramma di Humer (perché «tutto è ridicolo, quando si pensa alla morte»[2]).
Il terzo racconto, Sull’Ortles, è stato considerato da Bernhard, almeno fino al 1976, uno dei suoi lavori più riusciti, al pari del «prediletto» Amras, per via di uno «stato fluttuante tra ingenuità, pubertà e un altissimo livello di riflessione intellettuale»[3]. Sull’Ortles è un racconto gemello di Un incontro, pubblicato nel 1982 su «Zeitgeist» e raggruppato insieme ad altri tre coevi nella raccolta Goethe muore (Goethe schtirbt, Suhrkamp, 2010, Adelphi, 2013): al di là dell’impianto simile, in entrambi i testi troviamo le ascensioni forzate («sempre ci costringevano ad andare in montagna con loro, benché noi la montagna la odiassimo»), i genitori vessatori e i due protagonisti giustapposti; torna persino la formula in corsivo quiete interiore (innere Ruhe); e ancora, in Sull’Ortles abbiamo due fratelli vestiti in modo identico («gli stessi pantaloni neri, la stessa giacca nera, lo stesso cappello nero in testa»), mentre in Un incontro abbiamo due amici i cui genitori, ugualmente “crudeli”, si vestono in modo opposto (calzettoni e berretti rosso vivo per spiccare nella natura oppure verde vivo per non spiccare nella natura). Il narratore di Sull’Ortles racconta all’agente del fratello, per via epistolare, l’ascensione fino a Gomagoi, dove si troverebbe una malga ereditata trentacinque anni prima; il narratore è uno scienziato che sta portando all’estremo un lavoro intellettuale, mentre il fratello acrobata ha già raggiunto il picco della sua arte e si trova nella fase discendente. Torna così il tema dell’opera monumentale, ma con una variante, quella della disciplina fisica, nella quale il declino è più evidente: «L’acrobazia vive, chi la esegue è morto». In entrambi i casi, il percorso verso l’eccellenza ha avuto inizio soltanto dopo la morte dei genitori, vissuta come una liberazione: «solo dopo […] la loro morte abbiamo avuto il coraggio di vivere la nostra vita in base alla nostra forza di volontà, senza genitori eravamo liberi»; allo stesso modo, in Un incontro, il narratore, riferendosi all’amico, ricorda che «la casa dei suoi genitori era un carcere identico al mio». In Bernhard edifici e case sono sempre «un luogo di fuga che può diventare [un]carcere»[4].
 I tre racconti di Midland a Stilfs, oltre all’ambientazione tirolese, hanno in comune proprio il tema dello spazio chiuso ambito quanto opprimente, un topos approfondito da Gargani, Massari[5] e De Blasio[6]: è possibile distinguere gli edifici simbolici (la torre in Amras, il cono di Roithamer) dai “luoghi del pensiero” (la soffitta di Höller per Roithamer o la sala Bordone per Reger), ma a volte le due entità possono coincidere (la fornace di Konrad, la cripta di Rudolf). Le caratteristiche degli edifici ricalcano sempre la condizione esistenziale del protagonista: la fornace di Konrad dà «l’impressione […] di un penitenziario», e infatti trasforma il suo inquilino in un assassino; la torre di Amras, arredata da uno zio «secondo la sua predilezione per le tenebre, e resa da lui sempre più cupa nel corso degli anni», rende la vita dei protagonisti «un’unica notte senza sonno, scandita solo [da] violenti dolori fisici e morali»; il cono di Roithamer, «questo edificio folle, demente, eccentrico, blasfemo, insensato», rappresenta il processo di stesura di un’altra creazione di Roithamer, un saggio di ottocento pagine ridotto prima a trecento e infine a sole ottanta pagine, ma completo soltanto in quanto somma delle tre stesure, da quella più ampia, che è la base del cono, fino a quella essenziale, che del cono è la punta (per De Blasio il cono è «espressione dell’apoteosi della logica razionalistica della matematica»); e ancora, in Estinzione, come rileva Massari, Murau non eredita soltanto la casa dell’infanzia, ma anche il luogo in cui «si trovano le radici della sofferenza», a tal punto che «l’avversione per i parenti e quella per la casa coincidono». Allo stesso modo, in Midland a Stilfs troviamo degli appartamenti la cui incuria «inimmaginabile» rispecchia il nichilismo dei protagonisti («perché sappiamo che siamo alla fine e che la vita per noi non ha più alcun senso»); nel Mantello di Loden i piani di un edificio corrispondono ai livelli di degradazione di Humer; in Sull’Ortles due fratelli che hanno ereditato una proprietà sgradita (come Murau in Estinzione), affrontano un’ascensione sfiancante per ricongiungersi con questo simbolo della loro infanzia tormentata, ma poi scoprono che della malga non è rimasto che «un mucchio di pietre sparpagliate», così come del legame con i genitori.
I tre racconti di Midland a Stilfs, oltre all’ambientazione tirolese, hanno in comune proprio il tema dello spazio chiuso ambito quanto opprimente, un topos approfondito da Gargani, Massari[5] e De Blasio[6]: è possibile distinguere gli edifici simbolici (la torre in Amras, il cono di Roithamer) dai “luoghi del pensiero” (la soffitta di Höller per Roithamer o la sala Bordone per Reger), ma a volte le due entità possono coincidere (la fornace di Konrad, la cripta di Rudolf). Le caratteristiche degli edifici ricalcano sempre la condizione esistenziale del protagonista: la fornace di Konrad dà «l’impressione […] di un penitenziario», e infatti trasforma il suo inquilino in un assassino; la torre di Amras, arredata da uno zio «secondo la sua predilezione per le tenebre, e resa da lui sempre più cupa nel corso degli anni», rende la vita dei protagonisti «un’unica notte senza sonno, scandita solo [da] violenti dolori fisici e morali»; il cono di Roithamer, «questo edificio folle, demente, eccentrico, blasfemo, insensato», rappresenta il processo di stesura di un’altra creazione di Roithamer, un saggio di ottocento pagine ridotto prima a trecento e infine a sole ottanta pagine, ma completo soltanto in quanto somma delle tre stesure, da quella più ampia, che è la base del cono, fino a quella essenziale, che del cono è la punta (per De Blasio il cono è «espressione dell’apoteosi della logica razionalistica della matematica»); e ancora, in Estinzione, come rileva Massari, Murau non eredita soltanto la casa dell’infanzia, ma anche il luogo in cui «si trovano le radici della sofferenza», a tal punto che «l’avversione per i parenti e quella per la casa coincidono». Allo stesso modo, in Midland a Stilfs troviamo degli appartamenti la cui incuria «inimmaginabile» rispecchia il nichilismo dei protagonisti («perché sappiamo che siamo alla fine e che la vita per noi non ha più alcun senso»); nel Mantello di Loden i piani di un edificio corrispondono ai livelli di degradazione di Humer; in Sull’Ortles due fratelli che hanno ereditato una proprietà sgradita (come Murau in Estinzione), affrontano un’ascensione sfiancante per ricongiungersi con questo simbolo della loro infanzia tormentata, ma poi scoprono che della malga non è rimasto che «un mucchio di pietre sparpagliate», così come del legame con i genitori.
Per questi e altri motivi, Midland a Stilfs è un’ottima chiave d’accesso all’universo di Thomas Bernhard, un mondo senza salvezza nel quale, ogni volta che un uomo si isola per sottrarsi al caos e all’imbecillità altrui, ovunque egli si ritiri, che sia la montagna, la sala di un museo o una soffitta, ogni volta che un uomo di genio si isola in compagnia del suo pensiero ecco che il suo pensiero cresce a dismisura e lo soverchia, lo preme contro il pavimento, e l’uomo deve compiere un vero e proprio atto eroico per ricacciarlo dentro, per non impazzire e per tornare alla quotidianità. È questa la grande vitalità dell’opera di Bernhard, questa forma di adrenalina, l’azzardo di spingere il pensiero alla sua massima potenza annientatrice e di fermarsi un attimo prima di cadere nell’abisso, per poi sollevare lo sguardo, ammirare il panorama e sorridere sardonici, almeno per qualche ora.
[1] Thomas Bernhard, «Secondo giorno», in Tre giorni (Drei Tage, 1971), trad. di Federica Romanini, in Aut Aut, 325, Il Saggiatore, 2005.
[2] Thomas Bernhard, “Discorso in occasione del conferimento del premio di Stato austriaco per la letteratura” (1968), in Eventi, a cura di L. Reitani, SE, Milano 2001, pp. 88-89.
[3] Thomas Bernhard, Peter Hamm, Una conversazione notturna, Portatori d’acqua, atteso per l’ottobre del 2020).
[4] Aldo Giorgio Gargani, La frase infinita. Thomas Bernhard e la cultura austriaca, Laterza, 1990, attualmente in Aldo Giorgio Gargani, L’arte di esistere contro i fatti. Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann e la cultura austriaca. Introduzione di Marco G. Ciaurro, Lamantica, 2017.
[5] Paolo Massari, Nelle stanze di Bernhard. Le case come luogo di infelicità e ossessione, di prossima pubblicazione.
[6] Serena De Blasio, Utopie architettoniche e geometrie dell’essere in Correzione di Thomas Bernhard, in Modelli abitativi e paradigmi identitari nella contemporaneità, a cura di Nunzia Palmieri, Elephant & Castle, aprile 2015.