Sepúlveda: “Noi sappiamo perdere”
intervista di Laura Luche
dal numero di maggio 1998
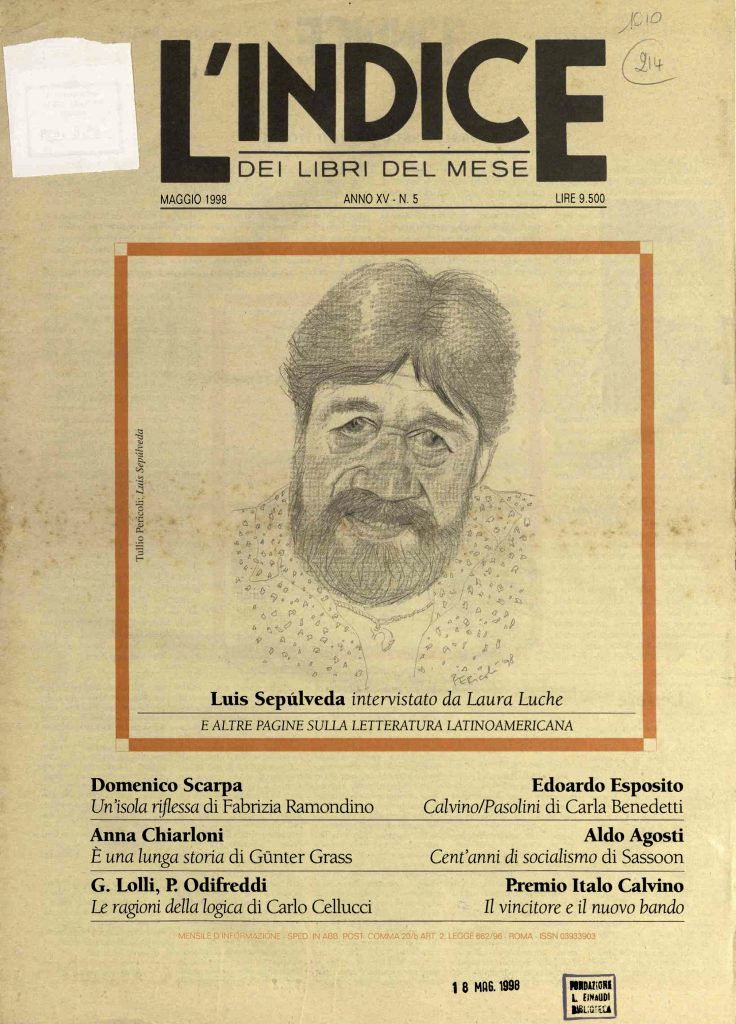
Luis Sepúlveda è l’essere che più somiglia a Maqroll il gabbiere. Lo giura Álvaro Mutis. Lo spirito ribelle, la vocazione per le avventure estreme, la passione per il peregrinare negli angoli remoti del mondo e, soprattutto, il culto dell’amicizia, accomunano il misterioso protagonista dei romanzi di Álvaro Mutis e l’autore cileno dalla vita romanzesca. Dopo esser stato perseguitato politico nel Cile di Pinochet, guerrigliero in Nicaragua, ecologista d’assalto sulle navi di Greenpeace, Luis Sepúlveda è ora autore di culto in molti paesi europei. Il suo ultimo romanzo, Diario di un killer sentimentale, appena uscito ha scalato le classifiche dei libri più venduti. Si tratta, dopo Un nome da torero (Guanda, 1994; cfr. “L’Indice”, 1995, n. 4), di una nuova incursione nella novela negra, il filone della narrativa ispanoamericana che fonde il romanzo poliziesco, da cui prende le mosse, con registri eterogenei: avventura, cronaca, storia, feuilleton. Inaugurato da Paco Ignacio Taibo II, il nuovo romanzo nero è il genere prediletto dai componenti della Banda, il gruppo di scrittori capeggiati proprio da Sepulvéda e da Taibo, che abbraccia una lunga lista di autori di età e nazionalità differenti, una vasta cerchia di amici uniti dalla ribellione alla schiavitù dei generi letterari e dalla volontà di fare una letteratura in sintonia col proprio tempo e con i suoi problemi, una letteratura militante.
Qual è la differenza fra scrivere un romanzo, per quanto breve, e scrivere un racconto?
C’è una notevole differenza, perché le stesse intenzioni di scrittura sono diverse. Nel romanzo lo scrittore entra all’interno dell’opera e si lascia portare per mano dai personaggi. Un racconto, invece, si scrive sempre dall’esterno; nel racconto c’è una distanza che è la distanza dell’io narrante. Nel romanzo quell’io narrante scompare. Il momento che mi affascina di più durante la scrittura di un romanzo è quello in cui il mio io scrittore si dissolve nei personaggi e io mi trasformo in uno dei tanti protagonisti. Tuttavia, il racconto è il genere più difficile perché il romanzo offre numerose possibilità di correzione: se un capitolo è debole lo si può rafforzare col capitolo successivo. Il racconto, al contrario, viene bene o non viene affatto.
È stato detto che la sua scrittura è così semplice, così alla portata di tutti, che pare che chiunque sia capace di scrivere come lei. In realtà, quanto lavoro implica quest’apparente semplicità?
Come una volta disse Hemingway, si possono scrivere grandi romanzi con parole da venticinque dollari ciascuna ma veramente encomiabile è scrivere lo stesso romanzo con parole da venti centesimi. Si tratta, cioè, di dare alla letteratura un carattere molto democratico in modo che sia realmente accessibile a tutti, proprio a tutti. Questa volontà democratica è molto latinoamericana. È, per esempio, una delle caratteristiche della Banda. Scriviamo tutti in un modo per noi non facile, anzi, estremamente difficile. È molto più facile scrivere in un linguaggio mezzo sofisticato, la ricercatezza può contribuire persino a creare il mistero. Ma è importante, come ho detto, tradurre tutto nel linguaggio quotidiano, nel linguaggio della gente.
In alcuni suoi romanzi come Un nome da torero, appunto, o La frontiera scomparsa (Guanda, 1996) lei regola i conti con se stesso, con la sua storia, tuttavia senz’alcun intimismo né alcuna drammaticità anche quando descrive situazioni traumatiche come le torture. Come è arrivato a questa sorta di impassibilità personale?
La letteratura che mi piace leggere è quella in cui gli autori hanno l’onestà di dirsi che, per quanto interessante può sembrare loro ciò che hanno vissuto, potrebbe non esserlo per altri e di conseguenza scelgono di non denudarsi davanti al lettore. Esiste un rispetto per il lettore e ci sono cose ovvie. Quando si esorcizzano demoni di situazioni terribili come la prigionia e le torture, si è consapevoli che l’umanità sa già di cosa si tratta, sicché descriverle minuziosamente sarebbe un atto d’insolenza e un’oscenità. Anche il dolore, infatti, possiede un’enorme oscenità. E qui interviene una considerazione importante, che per me rappresenta una legge fondamentale: mi rifaccio a Cortázar, il quale sosteneva che è indispensabile comprendere il senso della nostra condizione di uomini e il senso della nostra condizione di artisti. Perché comprendere il senso della nostra condizione di uomini, di cittadini, ci obbliga ad assumere una posizione etica rispetto alla vita e quella posizione etica si può chiamare, per esempio, militanza , mentre comprendere il senso della condizione di artisti ci porta ad assumere un atteggiamento rigorosamente coerente rispetto all’estetica con cui lavoriamo. Poiché non può esistere separazione fra la letteratura e la vita, si deve cercare sempre di trasferire l’etica all’estetica, e di trasmettere l’estetica all’etica.
Terza grande passione: il cinema. In più occasioni ha affermato che la sua identità culturale si chiama Metro Goldwin Mayer e Twentieth Century Fox. Che rapporto vede fra cinema e letteratura, crede si possano considerare due linguaggi affini?
Sono discipline diverse ma si intersecano sempre, perché non esiste cinema senza una storia e quella storia la scrive sempre uno scrittore. Il problema è che la gente tende a ignorarne la presenza. Per ciò che mi riguarda, se affermo che la mia identità culturale si chiama Metro Goldwin Mayer e Twentieth Century Fox è perché sono convinto che l’immaginario di chi è nato dopo l’invenzione dei fratelli Lumière sia completamente determinato dal cinema. Prima del cinema si pensava in primo piano, adesso pensiamo in piani sequenza, e questo vale anche nei casi più banali. Prima del cinema, se uno si alzava dal letto per andare a lavarsi i denti, aveva in mente solo l’immagine in primo piano dell’azione di lavarsi i denti. Oggi ci vediamo mentre ci avviamo verso il bagno, mentre spremiamo il tubo del dentifricio e prendiamo lo spazzolino, ci vediamo di fronte allo specchio prima di esserci realmente. E tutto ciò si deve all’invenzione del cinema. Quanto alla letteratura, io, come tanti, sono incapace di scrivere una sola riga se prima non vedo le cose, se non ho uno schermo ben installato in testa in cui non solo vedo cosa fanno i personaggi ma anche lo sfondo. Non mi basta visualizzare il personaggio che cammina per strada, devo vedere anche il colore del muro della strada, se ci sono porte, devo sapere di che colore sono e cosa c’è dietro. Solo allora posso dar vita al personaggio, e questo è cinema puro.
Un nome da torero è dedicato a Paco Ignacio Taibo II, ringraziandolo per averla iniziato al romanzo nero. A cosa si de ve la sua preferenza per questa forma narrativa?
Il romanzo nero nasce dall’esigenza di creare una sintesi di generi da sempre considerati marginali e disprezzati dalla grande letteratura: il romanzo poliziesco puro, il romanzo di avventura, la letteratura di viaggio, il saggio e molto altro ancora. Questo romanzo ha aperto uno spazio incredibile per raccontare le cose e, soprattutto, per trattare temi molto attua li, il che ne fa l’espressione più militante della letteratura. Non esiste romanzo nero, per esempio, che non sia critico nei con fronti del potere e non obblighi a confrontarsi con i propri demoni. Per esempio, un giovane autore cileno, Mauricio Electorat, ha scritto uno straordinario romanzo nero intitolato El paraíso tres veces al día che è un viaggio negli inferi del mondo della droga, fatto attraverso personaggi affascinanti, molto ben costruiti. E un vero e proprio regolamento di conti.
Ha definito il romanzo nero “una finestra sul lato oscuro della vita che bisogna conoscere”. Col suo ultimo lavoro, Diario di un killer sentimentale, che lato oscuro ha voluto illuminare?
L’idea era quella di creare un personaggio terribile, un assassino, un essere abietto che, però, si confrontasse costante mente con la sua parte umana, l’altro io che lo guarda dallo specchio. Non credo nella coscienza degli uomini, ma credo che esista una sorta di sdoppiamento nella persona che in certe occasioni la porta a domandarsi cosa stia facendo, come possa fare certe cose. Volevo, inoltre, che quell’essere selvaggio che agisce su commissione di gente ‘fine’ ma in realtà più selvaggia di lui si muovesse nella mecca del mondo civile, nelle grandi città, negli alberghi di lusso e così via. Insomma, volevo mettere una bestia nel mondo più sofisticato e vederlo agire in quel contesto.
Che problemi ha dovuto affrontare per costruire in prima persona un personaggio così lontano da lei e così diverso dai personaggi dei suoi precedenti romanzi?
È stato piuttosto difficile perché il protagonista a tratti di ventava buono, tenero. Io continuavo a ripetermi che doveva essere malvagio, perverso all’estremo, ma ogni tanto mi sfuggi va di mano e si trasformava in un essere nobile. Comunque, ci sono già stati due o tre critici che l’hanno letto in modo intelligente e l’hanno visto come una metafora del modello economico neoliberale, che non si ferma assolutamente davanti a nulla, che mette al di sopra di ogni cosa il pragmatismo. Il protagonista sacrifica l’amore, sacrifica tutto perché così deve fare un professionista. Il riferimento immediato, quindi, è quello, è il modello economico che impera in molti paesi e che sacrifica tutto.
C’è una nota barocca nel Diario di un killer sentimentale, il mondo al rovescio: la vittima salva il killer, quest’ultimo si rivela essere il vero angelo sterminatore, la Dea invece di con trollare il traffico di droga, lo alimenta…
Il fatto è che il mondo è realmente al rovescio. Gli Stati Uniti, i maggiori finanziatori della lotta contro la droga, sono il paese che consuma più droga. I componenti della massima organizzazione per il controllo del traffico di droga, la Dea, sono i principali trafficanti, perché di tutti gli stupefacenti sequestrati solo un dieci per cento arriva nelle aule dei tribunali, il resto si perde per pagare i collaboratori, o rientra in commercio. Il mondo al rovescio, appunto. La vittima del romanzo, Victor Mujica, è un Robin Hood folle che scopre che l’unico modo di distruggere gli umiliatori, di mettere in ginocchio il sistema, è quello di fornirgli ciò che più desiderano: tutta la droga del mondo.
Questo killer condivide con personaggi precedenti un destino di fallimento…
Tutti noi autori latinoamericani, in un certo senso, siamo laureati in fallimento. Un altro giovane scrittore, Santiago Gamboa, un colombiano, è autore di un ottimo romanzo intitolato Perder es cuestión de metodo. Il titolo è un piccolo omaggio a me perché è una citazione presa da Un nome da torero. Noi latinoamericani ci abituiamo tanto al fallimento che perdere diventa davvero una questione di metodo, bisogna saper perdere bene. I miei personaggi, come me, sono grandi perdenti, non perché ci piaccia perdere, ma perché sappiamo perdere.
Sapete come cadere in piedi.
Esattamente: cadere in piedi, come i gatti.


