Pratiche e reincarnazioni storiche
di Francesco Cassata
 Nel mondo globalizzato del web, le visioni cospirazioniste sono all’ordine del giorno. Va di moda ormai relegarle nella categoria onnicomprensiva di fake news. Oppure ricondurle a uno “stile paranoico”, un oggetto sempre uguale a se stesso dalla Bibbia al maccartismo, un bias cognitivo, una presunta nevrosi collettiva ricorrente perché radicata nell’animo umano. Contro queste interpretazioni astoriche e generalizzanti, due saggi fra loro differenti nel tema e nell’approccio – La congiura immaginata di Ignazio Veca e Uno spettro si aggira per l’Europa di Paul Hanebrink – si ritrovano uniti in un comune sforzo metodologico: quello di ritornare ai contesti specifici, riconducendo le trame complottistiche a luoghi e tempi determinati, analizzandone – come in un esperimento di laboratorio – il concreto funzionamento: il comportamento dei singoli attori sociali, la materialità dei testi, la circolazione delle notizie, la trasmissione delle immagini, l’uso politico degli stereotipi. Il titolo del saggio di Veca è da questo punto di vista illuminante. Non l’immaginazione cospirazionista, ma la congiura immaginata, descritta nella sua meccanica: come un evento non – non ancora? – accaduto, costruito su notizie finte anche se non propriamente false, può passare a un certo punto per vero e determinare reali conseguenze? Al centro dell’analisi di Veca è un episodio spesso relegato ai margini degli studi sul Risorgimento italiano: nel luglio 1847 prese corpo la denuncia di una congiura che avrebbe avuto come bersagli papa Pio IX e il popolo romano, mettendo fine a una stagione di riforme che tante speranze aveva suscitato negli ambienti liberali.
Nel mondo globalizzato del web, le visioni cospirazioniste sono all’ordine del giorno. Va di moda ormai relegarle nella categoria onnicomprensiva di fake news. Oppure ricondurle a uno “stile paranoico”, un oggetto sempre uguale a se stesso dalla Bibbia al maccartismo, un bias cognitivo, una presunta nevrosi collettiva ricorrente perché radicata nell’animo umano. Contro queste interpretazioni astoriche e generalizzanti, due saggi fra loro differenti nel tema e nell’approccio – La congiura immaginata di Ignazio Veca e Uno spettro si aggira per l’Europa di Paul Hanebrink – si ritrovano uniti in un comune sforzo metodologico: quello di ritornare ai contesti specifici, riconducendo le trame complottistiche a luoghi e tempi determinati, analizzandone – come in un esperimento di laboratorio – il concreto funzionamento: il comportamento dei singoli attori sociali, la materialità dei testi, la circolazione delle notizie, la trasmissione delle immagini, l’uso politico degli stereotipi. Il titolo del saggio di Veca è da questo punto di vista illuminante. Non l’immaginazione cospirazionista, ma la congiura immaginata, descritta nella sua meccanica: come un evento non – non ancora? – accaduto, costruito su notizie finte anche se non propriamente false, può passare a un certo punto per vero e determinare reali conseguenze? Al centro dell’analisi di Veca è un episodio spesso relegato ai margini degli studi sul Risorgimento italiano: nel luglio 1847 prese corpo la denuncia di una congiura che avrebbe avuto come bersagli papa Pio IX e il popolo romano, mettendo fine a una stagione di riforme che tante speranze aveva suscitato negli ambienti liberali.
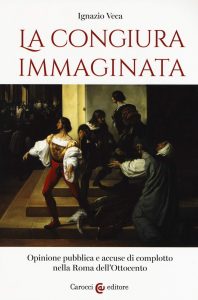 In uno sforzo microstorico di notevole raffinatezza metodologica, l’autore disaggrega, in progressive tappe concentriche, le particelle elementari della “grande congiura” (come la definirono i contemporanei) – avvisi anonimi con liste dei congiurati, lettere, pamphlet, articoli di giornale, dispacci diplomatici, testi teatrali, carte processuali – fino a ricavarne un modello di ampia portata interpretativa, sia per la storia dell’Ottocento sia, più in generale, per la definizione concettuale del complottismo. Per quanto riguarda il primo aspetto, la “grande congiura” del 1847 mostra come Risorgimento e antirisorgimento non si scontrarono soltanto sul piano politico-ideologico, fra l’accettazione e il rifiuto degli ideali liberali o nazional-patriottici, ma si confrontarono accanitamente in un continuo gioco di accuse e controaccuse di complotto. E non è un caso che tutto questo avvenga nel corso dell’Ottocento, in una fase cioè di profonda trasformazione dei regimi comunicativi e dell’interazione sociale. Più che di una patologia sociale, infatti, il complotto – afferma Veca – deve essere visto come il frutto di una fisiologia sociale, ovvero della tendenza da parte di specifici attori sociali a utilizzare precisi strumenti tecnici e culturali come atti performativi volti a orientare o trasformare una situazione. La congiura del 1847 assume in quest’ottica i contorni di una profezia cospirazionista, uno pseudoevento finto nell’enunciazione, ma capace di suscitare comportamenti reali. “Chi crede nelle accuse di complotto – sostiene acutamente Veca – si comporta come se ciò che raccontano fosse avvenuto, finché le condizioni politiche e sociali appaiono giustificare quelle enunciazioni”: gli artefici della “grande congiura” del luglio 1847 fabbricarono gli indizi e le prove necessari a credere; e questi atti performativi produssero effetti reali, materializzando gli effetti delle proprie cause.
In uno sforzo microstorico di notevole raffinatezza metodologica, l’autore disaggrega, in progressive tappe concentriche, le particelle elementari della “grande congiura” (come la definirono i contemporanei) – avvisi anonimi con liste dei congiurati, lettere, pamphlet, articoli di giornale, dispacci diplomatici, testi teatrali, carte processuali – fino a ricavarne un modello di ampia portata interpretativa, sia per la storia dell’Ottocento sia, più in generale, per la definizione concettuale del complottismo. Per quanto riguarda il primo aspetto, la “grande congiura” del 1847 mostra come Risorgimento e antirisorgimento non si scontrarono soltanto sul piano politico-ideologico, fra l’accettazione e il rifiuto degli ideali liberali o nazional-patriottici, ma si confrontarono accanitamente in un continuo gioco di accuse e controaccuse di complotto. E non è un caso che tutto questo avvenga nel corso dell’Ottocento, in una fase cioè di profonda trasformazione dei regimi comunicativi e dell’interazione sociale. Più che di una patologia sociale, infatti, il complotto – afferma Veca – deve essere visto come il frutto di una fisiologia sociale, ovvero della tendenza da parte di specifici attori sociali a utilizzare precisi strumenti tecnici e culturali come atti performativi volti a orientare o trasformare una situazione. La congiura del 1847 assume in quest’ottica i contorni di una profezia cospirazionista, uno pseudoevento finto nell’enunciazione, ma capace di suscitare comportamenti reali. “Chi crede nelle accuse di complotto – sostiene acutamente Veca – si comporta come se ciò che raccontano fosse avvenuto, finché le condizioni politiche e sociali appaiono giustificare quelle enunciazioni”: gli artefici della “grande congiura” del luglio 1847 fabbricarono gli indizi e le prove necessari a credere; e questi atti performativi produssero effetti reali, materializzando gli effetti delle proprie cause.
Un analogo sforzo di ricontestualizzazione e di analisi delle concrete pratiche discorsive e sociali del complottismo è quello condotto da Paul Hanebrink nel suo studio sul mito del bolscevismo giudaico. Il saggio non si limita infatti a dimostrare la fallacia di questa tesi cospirazionista, né la riduce a mero capitolo nella plurisecolare storia dei pregiudizi nei confronti degli ebrei. Al contrario, lungo le trecento pagine del libro Hanebrink penetra in profondità negli ingranaggi della meccanica mitologica, al fine di delinearne il concreto funzionamento: che cosa ha significato la tesi del bolscevismo giudaico nei diversi contesti sociopolitici in cui ha attecchito? In che modo ha attraversato i confini, trasformandosi in un fenomeno transnazionale? Come si è modificata nel corso del Novecento?
Per rispondere a queste domande, Hanebrink punta lo sguardo su un luogo molto preciso – l’Europa centro-orientale – e propone una periodizzazione originale, che ha inizio ben prima dell’ascesa di Hitler nel 1933 e che non termina affatto con la fine della seconda guerra mondiale, ma si prolunga di fatto sino a oggi. Il mito del bolscevismo giudaico emerge come elemento della politica anticomunista in quel crogiuolo di guerre, guerre civili, rivoluzioni e crolli imperiali che caratterizzò la “lunga prima guerra mondiale” nell’Europa dell’est, tra 1914 e 1923. In questo clima di odio, di violenza e di ridefinizione delle sovranità nazionali, i sospetti di guerra sugli ebrei come spie e sabotatori si trasformarono rapidamente nella paura degli ebrei in quanto rivoluzionari. Nei diversi contesti nazionali, plasmati dalla vittoria e dalla sconfitta – in Polonia, Ungheria, Romania – la teoria del bolscevismo giudaico giunse a riflettere le ansie che circondavano la fragile sovranità nazionale, incarnando i timori nei confronti di potenziali nemici interni ed esterni.
In questo contesto va inserita la centralità dell’immagine dell’ebreo bolscevico nella visione di Adolf Hitler e del nazismo, sin dagli esordi dell’organizzazione. I ricordi della lotta – contro i rivoluzionari di Monaco, contro i comunisti per le strade di Berlino – animavano i membri del partito, giustificando le richieste dei leader nazisti di attuare misure estreme per garantire l’ordine e la sicurezza interni, interpretati in termini politico-razziali. Dopo il 1933, la minaccia bolscevico-giudaica si tramutò nel simbolo della difesa da un pericolo non più interno ma esterno, contribuendo a cristallizzare l’idea – dinamica e flessibile – di un’Europa delle nazioni a guida nazista in lotta contro il nemico comunista. Nel 1941, con l’invasione nazista dell’Unione Sovietica, la profezia si sarebbe autoavverata, saldando indissolubilmente la guerra mondiale al genocidio degli ebrei europei.
La guerra fredda scisse in due anche il mito del bolscevismo giudaico. Mentre a occidente, soprattutto in Germania ovest, il paradigma antitotalitario consentiva di salvaguardare l’anticomunismo facendo del riferimento alla civiltà occidentale, giudaico-cristiana, un tratto fondamentale della retorica liberale, a est – in Polonia, Ungheria e Romania – gli stereotipi profondamente radicati che identificavano comunismo ed ebraismo plasmarono decisamente la percezione popolare delle forze di occupazione sovietiche e dei partiti comunisti che salirono al potere con il sostegno russo. Consapevoli della pervasività nell’immaginario popolare del legame tra ebrei e comunismo, negli anni successivi al 1945 i capi dei partiti comunisti locali tentarono di arginare lo stereotipo – manipolando i dibattiti sulla violenza antisemita del dopoguerra, facendo fronte comune con i razzisti nazionalisti, reclutando quadri dalla maggioranza etnica – o lo strumentalizzarono a proprio vantaggio, identificando alcuni nemici interni al partito come ebrei responsabili di aver “tradito il popolo”.
Nell’analisi di Hanebrink, il 1989 giunge da ultimo a segnare una nuova configurazione del mito, questa volta strettamente intrecciata con gli sviluppi della memoria transnazionale della Shoah. Mentre a ovest Ernst Nolte, a partire dal 1986, rispolverava il “nesso causale” tra comunismo e nazismo per relativizzare la Shoah e rifondare una memoria della guerra basata sull’esperienza nazionale tedesca, a est i nazionalismi postcomunisti rifiutavano gli appelli a riconoscere la Shoah come evento distintivo delle rispettive storie nazionali, tornando a identificare strumentalmente gli ebrei (e la memoria “ebraica”) con il comunismo del passato e con il neoliberismo del presente.
E infine il triste presente. Nel novembre 2017 gli attivisti di estrema destra di tutta Europa si sono riuniti a Varsavia in occasione del giorno dell’indipendenza della Polonia, per inneggiare a un’“Europa bianca di nazioni sorelle”. Qualche mese prima, ad agosto, a Charlottesville in Virginia, suprematisti bianchi e neonazisti avevano protestato contro la rimozione della statua del generale confederato Robert E. Lee, urlando slogan razzisti anti-immigrati. Da una parte all’altra dell’Atlantico, i proclami contro l’imminente rischio di una “sostituzione etnica”, in America e in Europa, rivelavano la presenza del nemico di sempre, nella sua ennesima incarnazione: il “comunista ebreo”.
francesco.cassata@unige.it
F. Cassata insegna storia contemporanea all’Università di Genova


