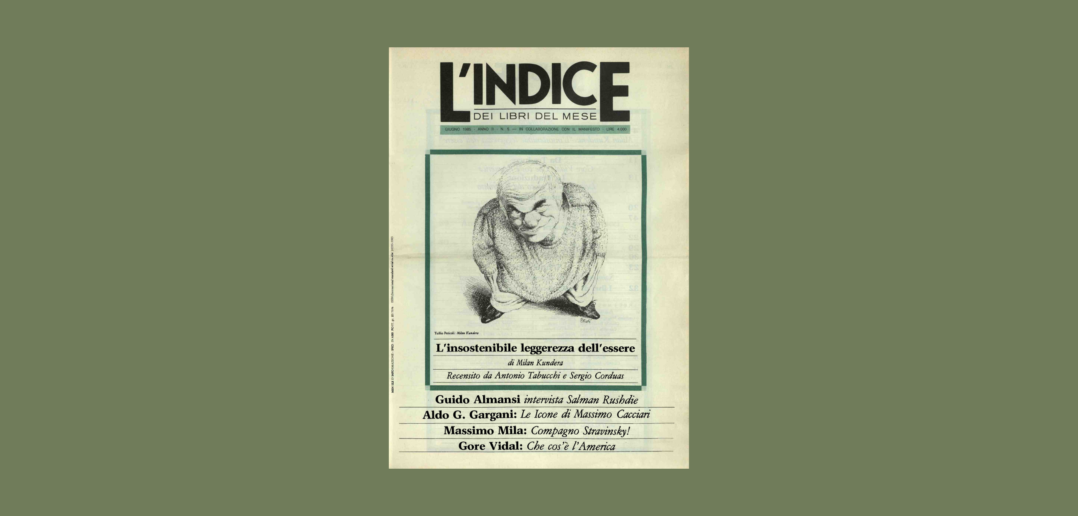L’irreversibile e la nostalgia
Antonio Tabucchi recensisce L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera
 C’è un concetto elementare che poniamo dentro di noi: che la vita è irripetibile. Ogni nostro istante, ogni nostra azione, ogni nostro gesto, insomma tutto ciò che ci è dato da vivere avviene una volta sola, non avverrà mai più. Eppure viviamo come se ciò fosse un concetto trascurabile, perché se provassimo a rifletterci mentre viviamo, la vita diventerebbe una paradossale nostalgia: la nostalgia del presente. Su questo concetto, insieme elementare e insostenibile, Milan Kundera ha scritto un intero romanzo, un grande romanzo. Un romanzo non è grande se non ha in sé almeno un’interrogazione metafisica. Interrogazione che non è incompatibile col realismo, come a volte si tende a credere, perché realismo e metafisica possono andare perfettamente d’accordo; anzi, più che il fantastico, che è la negazione della metafìsica, è spesso il reale che postula interrogativi metafisici, o che fa scattare quella metafisica del reale che il nostro secolo, a partire da Kafka e da Pirandello, ha visitato con i suoi autori maggiori. Kundera è appunto un romanziere realista e metafisico; di un realismo e di una metafisica estenuati e dolenti: e per questo capaci di lampi, di penose intuizioni, di apparizioni brucianti, di guizzi e di spasimi. Di colpi di coda, mi verrebbe da dire, come di un animale morente che sta lasciando il suo vecchio corpo e sotto i nostri occhi sta producendo un altro corpo a lui consanguineo e a noi sconosciuto, un essere vivente che gli esce dalle viscere e che si sta sostituendo a lui. Il romanzo di Kundera è infatti un testo in mutazione: non è più un romanzo ed è già un altro romanzo, non è tradizionale ma non è neppure quello che con un aggettivo un po’ logoro viene definito “sperimentale”.
C’è un concetto elementare che poniamo dentro di noi: che la vita è irripetibile. Ogni nostro istante, ogni nostra azione, ogni nostro gesto, insomma tutto ciò che ci è dato da vivere avviene una volta sola, non avverrà mai più. Eppure viviamo come se ciò fosse un concetto trascurabile, perché se provassimo a rifletterci mentre viviamo, la vita diventerebbe una paradossale nostalgia: la nostalgia del presente. Su questo concetto, insieme elementare e insostenibile, Milan Kundera ha scritto un intero romanzo, un grande romanzo. Un romanzo non è grande se non ha in sé almeno un’interrogazione metafisica. Interrogazione che non è incompatibile col realismo, come a volte si tende a credere, perché realismo e metafisica possono andare perfettamente d’accordo; anzi, più che il fantastico, che è la negazione della metafìsica, è spesso il reale che postula interrogativi metafisici, o che fa scattare quella metafisica del reale che il nostro secolo, a partire da Kafka e da Pirandello, ha visitato con i suoi autori maggiori. Kundera è appunto un romanziere realista e metafisico; di un realismo e di una metafisica estenuati e dolenti: e per questo capaci di lampi, di penose intuizioni, di apparizioni brucianti, di guizzi e di spasimi. Di colpi di coda, mi verrebbe da dire, come di un animale morente che sta lasciando il suo vecchio corpo e sotto i nostri occhi sta producendo un altro corpo a lui consanguineo e a noi sconosciuto, un essere vivente che gli esce dalle viscere e che si sta sostituendo a lui. Il romanzo di Kundera è infatti un testo in mutazione: non è più un romanzo ed è già un altro romanzo, non è tradizionale ma non è neppure quello che con un aggettivo un po’ logoro viene definito “sperimentale”.
Roman philosophique? Certo, ma non nell’accezione settecentesca del termine: L’insostenibile leggerezza dell’essere non è un romanzo moralistico e non è un romanzo sulla ragione, anche se parla di etica e di ragione (e di sentimenti). Se dovessi nominare un filosofo che presiede a questo libro farei il nome di Francis Bradley, del quale Borges ha scritto che “esclude l’avvenire e che riporta l’Attuale all’agonia del momento presente che si disintegra nel passato”. Fino dall’inizio il senso della finitudine congela le figure di questo romanzo in una luce livida, in una fissità da fotografia, nella dimensione dell’Irreversibile. “Sono già molti anni che penso a Tomài, ma soltanto alla luce di queste considerazioni l’ho visto con chiarezza. L’ho visto alla finestra del suo appartamento, gli occhi fissi al di là del cortile sul muro della casa di fronte, che non sa che cosa deve fare”. Le considerazioni del narratore riguardano l’idea dell’eterno ritorno e dell’inesistenza del ritorno, che si traducono nell’idea della leggerezza e della pesantezza e che introducono alla storia. Ma quando la storia comincia, quando cioè il narratore sorprende il suo personaggio alla finestra dell’appartamento, la storia è anche in qualche modo già conclusa. Noi non sappiamo perché, ma intuiamo che la vicenda che ci verrà raccontata è come una fotografia; una fotografia che, come ha detto Susan Sontag, è simultaneamente una pseudo-presenza e l’indicazione di un’assenza.
A metà del romanzo, per esempio, veniamo a sapere attraverso un altro personaggio che Tomài e Tereza sono già morti in un incidente: eppure la loro storia prosegue nel romanzo, essi continuano a vivere fatalmente per noi fino al momento in cui moriranno. La loro storia, già avvenuta, è irreversibile, la loro vita nella narrazione è solo una pseudo-presenza: essi sono un’assenza. Kundera durante il romanzo fa il nome di molti filosofi, da Parmenide a Scoto Eriugena a Nietzsche: manca tuttavia quello di Jankélévitch, il filosofo dell’irrevocabile e della nostalgia, che sono i concetti portanti dell’Insostenibile leggerezza dell’essere specialmente laddove il romanzo tocca, non solo con la storia, ma anche con le riflessioni extra-narrative dell’autore, temi come la resistenza all’irreversibile (il rallentamento del divenire, l’accelerazione del divenire, l’incomprensibilità del divenire), il consenso all’irreversibile (la libertà come potere a senso unico) e la questione dell’irrevocabile (l’attrazione dell’essere stato e del dover essere, la dizione della tautologia). Ha scritto Jankélévitch che “contro la tautologia ottusa, sorda e cieca, e soprattutto muta, protesta il paradosso della contraddizione”. Kundera ha un modo molto originale di definire il dover essere e la tautologia ottusa: il Kitsch. Egli definisce il Kitsch “un accordo categorico con l’essere”, la mancanza di paradosso e di contraddizione. In tal modo egli sposta il concetto di Kitsch dal piano estetico al piano ontologico, ne fa una vera e propria categoria dell’essere. Viene da pensare se nella visione di Kundera non ci sia un accordo un po’ troppo categorico con la sua stessa visione, il che gli potrebbe creare alcuni problemi, perché una teoria di questo genere mi pare plausibile purché essa preveda un margine di dubbio nei confronti di se stessa, insomma tolleri l’ironia e l’autoironia, altrimenti il problema cacciato dalla porta rischia di rientrare dalla finestra.
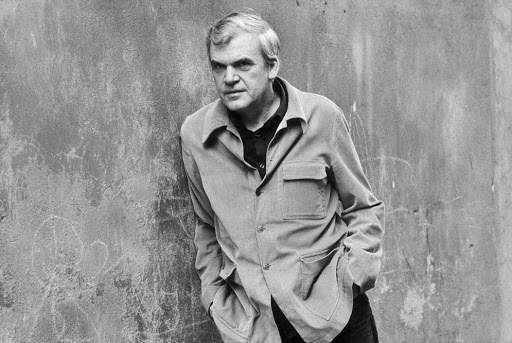
È comprensibile che, esule da un regime come quello cecoslovacco (il cui sistema di vita, come in altri regimi analoghi, è fondato sul Kitsch), Kundera sia portato a elevare a regola universale ciò che lo ha perseguitato fin dalla nascita. Ma in tal modo egli crea una categoria totalizzante che trasforma la vita in una mostruosa trappola senza scampo. Non mi pare infatti che la soluzione, o l’evasione da tale trappola, possa essere costituita, come il romanzo tende a far credere, dal comportamento della pittrice Sabina, seguace del “tradimento continuo” e figura letteraria forse un po’ esile che ricorda certe figure letterarie o cinematografiche degli anni cinquanta. Le figure di grande spessore de L’insostenibile leggerezza dell’essere sono invece proprio quelle alle quali il narratore non attribuisce funzioni metaforiche rigidamente esemplari: Tereza, Tomài e la loro assurda e “necessaria” storia d’amore. La requisitoria contro gli intellettuali occidentali e le loro manifestazioni politiche pecca forse di una certa presupponenza: essi vengono sostanzialmente presentati come una banda di citrulli guidati da un accordo categorico con l’essere (dunque il Kitsch) che certo semplifica molto le cose. Probabilmente a questa visione così radicale, anche se fondata su alcuni elementi legittimi, contribuisce in larga misura il disagio dell’esule, che può trasformare la coscienza ironica in coscienza cinica: quella coscienza cioè che sceglie le massime e gli esempi e che cerca freddamente la situazione senza uscita, la dimensione del tragico. Dove questa dimensione trova un’indimenticabile grandezza è invece, come dicevo, proprio dove “si fa carne”, dove diventa personaggio: nelle figure di Tereza e di Tomài, protagonisti di una sconfitta desolata e attonita che è una forma agghiacciante di tragedia. Perché se è vero che nei dannati di Dostoevskji il culmine della loro sconfitta è anche l’inizio del loro riscatto, Tereza e Tomài sono due figure senza riscatto e senza rinascita, spaventosamente prigioniere di una tragedia senza esito e senza catarsi. Una tragedia che sembra avere per coro il popolo cecoslovacco ma il cui coro più adeguato e misterioso è forse l’insostenibile “sorriso” del loro cane Karenin, che malato di cancro li precede nell’ombra.
dal numero di giugno 1985