Pessimista dalla vitalità eccezionale nel pulviscolo dell’ordinario
di Luca Bevilacqua
Ci sono autori che scrivono all’insegna di quella che Baudelaire chiamò (alludendo al suo Spleen de Paris) una “morale désagréable”. Immuni per vocazione alle sirene dei buoni sentimenti, e attratti invece dagli abissi della malafede, dai rancori ad orologeria, dagli sfaceli inconfessati, questi scrittori esplorano il male non tanto nelle sue forme clamorose o eclatanti (violenze efferate, delitti), ma nel pulviscolo della vita ordinaria. Un’implacabile ansia di verità accomuna i membri di questa tenebrosa famiglia il cui gene ha prodotto capolavori che recano alla coscienza “sgradevoli” conquiste, giacché l’immagine dell’essere umano risulta tragicamente ridotta. Molière, La Rochefoucauld, Gogol’, Schnitzler, Čechov, Céline, Musil. E di recente: Yasmina Reza.
 È come se l’umanità stessa (e perciò la letteratura) si dividesse in due enormi partiti: coloro che credono strenuamente nel progresso, nella comunità, nell’impegno. E quelli che ritengono tali categorie altrettante costruzioni necessarie all’uomo per celare a se stesso l’angoscia e l’insensatezza del suo breve passaggio sulla terra. Due visioni del mondo – l’ottimismo e il pessimismo – che si fronteggiano in uno dei libri più intensi di Yasmina Reza, dal titolo emblematico Una desolazione (1999; Bompiani, 2003). Protagonisti sono un padre e un figlio, ma è soltanto il padre a parlare, in un lungo e disperato monologo. Ormai anziano e con un cancro che lo condanna ad anticipare il congedo dai vivi, il padre accusa il figlio d’essere appunto un ottimista: uno che s’è sistemato la vita con i viaggi, con l’indifferenza verso tutto, approdando a una quiete che per il padre è incomprensibile. Per me – esclama il vecchio Samuel, con un orgoglio che ricalca, a ruoli invertiti, la Lettera al padre di Kafka – “l’unico terrore era la monotonia dei giorni”. Avrebbe bussato alle porte dell’Inferno pur di fuggire quel “nemico mortale”, la noia, e ora non riesce a capire come possa il figlio quarantenne dirsi “felice” su un’isola tropicale dove pare abbia trovato “un equilibrio”. Ma la vita non è questo, grida Samuel, e nella sua voce avvertiamo quella dell’autrice. Anche la ricerca dell’amore non può essere ridotta alla ricerca dell’equilibrio o della felicità.
È come se l’umanità stessa (e perciò la letteratura) si dividesse in due enormi partiti: coloro che credono strenuamente nel progresso, nella comunità, nell’impegno. E quelli che ritengono tali categorie altrettante costruzioni necessarie all’uomo per celare a se stesso l’angoscia e l’insensatezza del suo breve passaggio sulla terra. Due visioni del mondo – l’ottimismo e il pessimismo – che si fronteggiano in uno dei libri più intensi di Yasmina Reza, dal titolo emblematico Una desolazione (1999; Bompiani, 2003). Protagonisti sono un padre e un figlio, ma è soltanto il padre a parlare, in un lungo e disperato monologo. Ormai anziano e con un cancro che lo condanna ad anticipare il congedo dai vivi, il padre accusa il figlio d’essere appunto un ottimista: uno che s’è sistemato la vita con i viaggi, con l’indifferenza verso tutto, approdando a una quiete che per il padre è incomprensibile. Per me – esclama il vecchio Samuel, con un orgoglio che ricalca, a ruoli invertiti, la Lettera al padre di Kafka – “l’unico terrore era la monotonia dei giorni”. Avrebbe bussato alle porte dell’Inferno pur di fuggire quel “nemico mortale”, la noia, e ora non riesce a capire come possa il figlio quarantenne dirsi “felice” su un’isola tropicale dove pare abbia trovato “un equilibrio”. Ma la vita non è questo, grida Samuel, e nella sua voce avvertiamo quella dell’autrice. Anche la ricerca dell’amore non può essere ridotta alla ricerca dell’equilibrio o della felicità.
Amore, amicizia. Territori rischiosi e spesso disagevoli nei quali anziché pianificare una qualche riuscita dobbiamo arrangiarci un giorno dopo l’altro: pronti ad accogliere il bene – che a volte dura appena poche ore – come un dono momentaneo, perché la solitudine, il malinteso, la comunicazione mancata, sono lì ad attenderci, sempre, com’è vero che esiste il Mondo. Come è vero che esiste il tempo. Tutto questo, almeno, nella visione che emerge dall’insieme dell’opera di Yasmina Reza. La sua commedia più nota e rappresentata (che ha avuto fuori di Francia, nel 1998, due prestigiosi premi: il Tony Award e il Laurence Olivier Award) s’intitola “Arte” (1994). E racconta – come molti sapranno – del disastroso tentativo di un uomo di render partecipe un amico d’un avvenimento che lo entusiasma: l’acquisto d’un quadro costosissimo. Ma si dà il caso che il quadro, benché d’autore, sia una tela completamente bianca. E l’amico, convocato non tanto per esprimere un giudizio, ma per condividere l’entusiasmo, reagisce in modo del tutto imprevisto con ilarità e disprezzo. Si tratta, beninteso, d’una reazione sincera, e i buonisti, gli ottimisti, raccomandano sempre di essere schietti con gli amici. Eppure proprio tale sincerità (che ricorda per un attimo quella di Alceste nel Misantropo di Molière) riesce a demolire in poche battute, se non un’amicizia, qualsiasi speranza di condivisione. Utopia dell’empatia. E ironia di situazione, che scatena nel pubblico molte risate, coprendo con un velo iridescente il baratro scavato tra i due personaggi.
Non si tratta, come molti hanno superficialmente ritenuto, d’una pièce che ridicolizza la classe media occidentale, con le sue ansie e frustrazioni. Questo è forse l’equivoco maggiore che incombe sulla scrittura teatrale e narrativa di Yasmina Reza. Ovvero l’idea che essa voglia esprimere una critica – in forma satirica, o tragica, o tragicomica – dei guasti e delle nefandezze in cui oggi ci barcameniamo tutti, specie nelle questioni affettive e sentimentali. Niente di più lontano invece, da questa scrittrice, dell’idea di un’opera “a tesi”. Che è poi l’esito, da sempre, d’ogni comédie de mœurs. Se sono così frequenti, in Reza, i non-detti, le allusioni (spesso a fatti o desideri di cui è messo a parte il pubblico ma che restano ignoti agli altri personaggi); se si moltiplicano i discorsi che qualcuno è sul punto di fare – vorrebbe poter fare! – ma invece restano bloccati nelle viscere mentre la voce esprime concetti diametralmente opposti (si vedano a riguardo alcune pagine mirabili di Adam Haberberg, 2003/2009); se le dichiarazioni impossibili e gli sfoghi repressi costeggiano minacciosamente l’azione principale (penso alle “confessioni immaginarie” di Une pièce espagnole, 2004), ebbene, tutto ciò non avviene certo perché l’humus culturale di Yasmina Reza è il ceto benestante e un po’ snob della Francia degli ultimi trent’anni.
Se così fosse, dovremmo dar ragione a Franco Cordelli, che recensendo un allestimento recente di Bella figura (per la regia di Roberto Andò) denuncia nella scrittura reziana un eccesso di “sottintesi” e “sottotesti”: macchie imperdonabili, diremmo quasi provincialismi, per “questa mediocre scrittrice francese” che “gode di un incomprensibile prestigio intellettuale”. Ma così non è. Reza non svolge una critica dei costumi, non parla (soltanto) della sua epoca e del suo milieu. O almeno, non più di quanto non faccia Molière. E se insisto ancora una volta in un così spericolato accostamento, non è solo per dire che ritengo Reza una scrittrice che racconta con straordinaria intelligenza e qualità di scrittura l’unico vero argomento della letteratura d’ogni tempo, l’uomo, ma anche per ricordare che proprio con Molière Reza condivide un singolare primato: sono i due autori francesi di teatro più rappresentati oggi al mondo.
Tradotta in 35 lingue, successo teatrale planetario. In Italia i suoi libri sono pubblicati, dopo il 2011, da Adelphi (Il dio del massacro, Felici i felici, Babilonia, “Arte”, Bella figura). Certo non sono questi dati esteriori a fare la grandezza d’un autore. E nemmeno la pur notevole continuità delle opere. Accanto alla produzione drammatica e narrativa, detto per inciso, spiccano due brevi e intensi scritti autobiografici, Al sopra delle cose (titolo originale: Hammerklavier, 1997) e Da nessuna parte (2005) editi entrambi da Archinto (2000 e 2012).
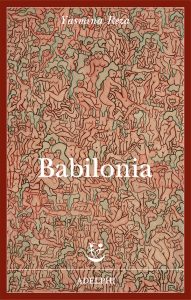 La grandezza letteraria la fa semmai la capacità dello scrittore di offrire, accanto allo stile, quella che – secondo l’espressione di Matthew Arnold – possiamo definire “una critica della vita”. Il ritmo della pagina, la scelta meticolosa della parola giusta, la precisione anatomica nel tratteggiare il carattere d’un personaggio, si applicano qui all’interno di una visione del mondo. E se questa visione, da un lato, può apparire semplicemente pessimista (o nichilista), dall’altro consiste più esattamente nel poter leggere e, di conseguenza, rappresentare l’esperienza umana solo in costante rapporto con la morte. “Il passato sprofonda così in fretta!”, esclama a un tratto Elisabeth, protagonista di Babilonia (2016). E poco oltre: “Non appena mettiamo piede sulla terra dobbiamo rinunciare a qualsiasi idea di permanenza”. Un pessimismo che si mescola peraltro col più vigoroso e insensato desiderio di vivere. Un’atmosfera cupa ma squarciata da luci abbaglianti, come soltanto nella più alta letteratura di ascendenza ebraica possiamo trovare. E le pulsioni aggressive serpeggiano incontrastate. Il “dio del massacro” ci induce in folli paralogismi e atroci dispute sentimentali e morali, fino ad annientarci l’uno con l’altro (molti avranno in mente il furore glaciale del film Carnage di Polanski, del 2011, tratto dalla commedia Le Dieu du carnage del 2006). E tutto, in fondo, per puro istinto di sopravvivenza. Consolazioni ne esistono poche – tale il messaggio di fondo – e tra queste una è proprio la letteratura, come il teatro, e la musica. Ma un’altra risorsa fondamentale è il saper ridere. Saper gioire e saper ridere: con un amante, o un amico, o un figlio. Finché è possibile.
La grandezza letteraria la fa semmai la capacità dello scrittore di offrire, accanto allo stile, quella che – secondo l’espressione di Matthew Arnold – possiamo definire “una critica della vita”. Il ritmo della pagina, la scelta meticolosa della parola giusta, la precisione anatomica nel tratteggiare il carattere d’un personaggio, si applicano qui all’interno di una visione del mondo. E se questa visione, da un lato, può apparire semplicemente pessimista (o nichilista), dall’altro consiste più esattamente nel poter leggere e, di conseguenza, rappresentare l’esperienza umana solo in costante rapporto con la morte. “Il passato sprofonda così in fretta!”, esclama a un tratto Elisabeth, protagonista di Babilonia (2016). E poco oltre: “Non appena mettiamo piede sulla terra dobbiamo rinunciare a qualsiasi idea di permanenza”. Un pessimismo che si mescola peraltro col più vigoroso e insensato desiderio di vivere. Un’atmosfera cupa ma squarciata da luci abbaglianti, come soltanto nella più alta letteratura di ascendenza ebraica possiamo trovare. E le pulsioni aggressive serpeggiano incontrastate. Il “dio del massacro” ci induce in folli paralogismi e atroci dispute sentimentali e morali, fino ad annientarci l’uno con l’altro (molti avranno in mente il furore glaciale del film Carnage di Polanski, del 2011, tratto dalla commedia Le Dieu du carnage del 2006). E tutto, in fondo, per puro istinto di sopravvivenza. Consolazioni ne esistono poche – tale il messaggio di fondo – e tra queste una è proprio la letteratura, come il teatro, e la musica. Ma un’altra risorsa fondamentale è il saper ridere. Saper gioire e saper ridere: con un amante, o un amico, o un figlio. Finché è possibile.
Ai nomi evocati qui all’inizio, Reza aggiungerebbe Emil Cioran e Thomas Bernhard. Lei stessa li ricorda in un’intervista (a Philippe Bilger) come “pessimisti d’una vitalità eccezionale”. E il pessimismo, aggiunge, è la condizione essenziale per ridere: “Non si ride granché con le persone ottimiste”. Nella stessa intervista, Reza (che non appare quasi mai in contesti mediatici) racconta il suo passato di studentessa e attrice approdata poi alla scrittura di pièces teatrali. Un modo, a suo dire, di entrare nella letteratura “dalla porta di servizio”, poiché come giovane e devota lettrice della narrativa ottocentesca, in particolare russa, non avrebbe osato porsi in competizione con i grandi.
Formulo un’ipotesi. Questa importante scrittrice dei nostri giorni, che ha cominciato come autrice di teatro, non è in realtà interessata a portare in scena nulla. Si limita a rispondere, tramite lo scrivere, a un tratto caratteriale che è quasi un vizio d’origine: essere eternamente spettatrice. Osservare cioè con distacco (quello dell’immaginaria quarta parete) lo spettacolo degli esseri umani: i dolori e le fatiche che lambiscono spesso il ridicolo, nello sforzo di opporsi individualmente, con la volontà e la ragione, al dominio delle nevrosi. Da questa necessità di registrare freddamente gli affanni e le chimere nasce la passione creatrice, la possibilità di costruire mondi. Come una rivalsa, o come un debito, in fondo, verso gli altri: “Vorrei toccare le persone, tendere uno specchio nel quale ci si riconosca, con semplicità. Una funzione dell’arte è diminuire la solitudine”. Quasi una missione per chi potrebbe ripetere, con Fénelon, “la sofferenza è la vita segreta delle anime”.
lucabevi@yahoo.it
L. Bevilacqua insegna letteratura francese all’Università di Tor Vergata di Roma


