In tutto ignoravo la misura
di Giulia De Florio
“A voi tutti – cari o estranei, poco importa a me che in tutto ignoravo la misura – mi rivolgo esigendo fede e chiedendo amore”.
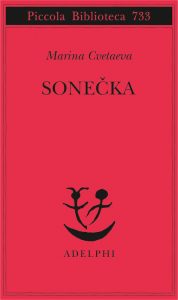 La smisurata preghiera condensata in questa frase rende ragione dell’arte di Marina Cvetaeva, che a uno sguardo complessivo è davvero un lunghissimo atto d’amore, espresso con l’unico mezzo che il poeta conosce: la parola, vale a dire, tutto se stesso. In quanto poeta, Cvetaeva è il paria per eccellenza, l’emigrato dall’eternità nel tempo, colui che più di ogni altro è riconoscibile da un marchio: il “disagio della randagità”. Eppure è proprio questo randagismo che porta la sua voce a risuonare ancora una volta in tutt’altro spazio-tempo e in nuove vesti, arricchendo il corpo testuale di Cvetaeva in lingua italiana di due nuovi volumi: Il racconto su Sonečka (ed. orig. 1937, a cura di Serena Vitale, trad. dal russo di Luciana Montagnani, pp. 287, € 14, Adelphi 2019) e Sette poemi (a cura di Paola Ferretti, trad. dal russo di Paola Ferretti, pp. 254, € 16, Einaudi). Due libri molto diversi eppure emblematici, capaci di svelare tutta l’ampiezza del dono poetico – e d’amore – di Cvetaeva. La prosa dei poeti è un affascinante ibrido letterario di cui la storia della letteratura russa ci regala molti esempi, alcuni dettati da necessità artistiche, altri dovuti a ragioni storiche e contingenti. Andrej Belyj, Osip Mandel’štam, Boris Pasternak, Iosif Brodskij – per citare solo alcuni poeti, assai diversi tra loro – hanno lasciato molti scritti in prosa che con i versi intrattengono un dialogo serrato, quasi che nella penna o sulle labbra di ciascuno di loro la netta differenziazione di genere sia un inutile sforzo a posteriori.
La smisurata preghiera condensata in questa frase rende ragione dell’arte di Marina Cvetaeva, che a uno sguardo complessivo è davvero un lunghissimo atto d’amore, espresso con l’unico mezzo che il poeta conosce: la parola, vale a dire, tutto se stesso. In quanto poeta, Cvetaeva è il paria per eccellenza, l’emigrato dall’eternità nel tempo, colui che più di ogni altro è riconoscibile da un marchio: il “disagio della randagità”. Eppure è proprio questo randagismo che porta la sua voce a risuonare ancora una volta in tutt’altro spazio-tempo e in nuove vesti, arricchendo il corpo testuale di Cvetaeva in lingua italiana di due nuovi volumi: Il racconto su Sonečka (ed. orig. 1937, a cura di Serena Vitale, trad. dal russo di Luciana Montagnani, pp. 287, € 14, Adelphi 2019) e Sette poemi (a cura di Paola Ferretti, trad. dal russo di Paola Ferretti, pp. 254, € 16, Einaudi). Due libri molto diversi eppure emblematici, capaci di svelare tutta l’ampiezza del dono poetico – e d’amore – di Cvetaeva. La prosa dei poeti è un affascinante ibrido letterario di cui la storia della letteratura russa ci regala molti esempi, alcuni dettati da necessità artistiche, altri dovuti a ragioni storiche e contingenti. Andrej Belyj, Osip Mandel’štam, Boris Pasternak, Iosif Brodskij – per citare solo alcuni poeti, assai diversi tra loro – hanno lasciato molti scritti in prosa che con i versi intrattengono un dialogo serrato, quasi che nella penna o sulle labbra di ciascuno di loro la netta differenziazione di genere sia un inutile sforzo a posteriori.
Anche quella di Marina Cvetaeva è una prosa a forte impronta poetica, sonora: la muscolatura della frase, il respiro a singhiozzo che esige dal lettore uno sforzo polmonare, ancor prima che mentale, si ritrova anche nelle poesie e nei poemi, cui però si aggiunge una dilatazione drammaturgica, una narrazione straordinariamente all’avanguardia, una prosa “a montaggio” che inquadra di volta in volta gli spazi, i volti e le emozioni su cui cade l’occhio di chi scrive. Nella Mosca che balugina tra i fuochi della rivoluzione, Cvetaeva è sola, isolata, già madre di due bambine; cerca e trova il poeta Pavel Antokol’skij, con il quale instaura una profonda amicizia. È lui il tramite che le permette di conoscere gli allievi del Secondo e Terzo Studio, i laboratori teatrali sorti nella fucina del MchAT, leggendario teatro ideato da Stanislavskij e Nemirovič-Dančenko e legato al nome del maggior drammaturgo a cavallo dei due secoli: Anton Pavlovič Čechov.
 Qui Cvetaeva, all’epoca poetessa in divenire con le due raccolte Album serale e La lanterna magica già pubblicate, incontra il teatro: tra il 1918 e il 1919 scrive sei pièces in versi che guardano al Settecento, un’epoca lontana anni luce dal presente, non cronologicamente ma per stile e comportamento. Sembrerebbero corpi estranei alla sua produzione – lei stessa aveva sempre sostenuto di non amare il teatro – e in un certo senso lo sono: Cvetaeva le definisce una “festa”, un momento di prodigio, stagliato su un destino che da lì in poi assumerà contorni sempre più neri. Una festa che Cvetaeva ritrova, per quel breve tratto di esistenza, in Sof’ja Evgen’evna Gollidej – russificazione di Hollyday, “festa” appunto, giacché la poeta si muove di suono in suono – , attrice che nel 1916, poco più che ventenne, è ammessa al Secondo Studio diretto da Vachtang Mčeledov dove, nel giro di pochi mesi, inizia a riscuotere grandi successi. Lunghe trecce nere, occhi enormi, complessione da bambina: così nell’aprile del 1919 – “il più nero, mortale, pestilenziale”, in quella città, Mosca, “dove non c’erano più poeti, come su tutta la terra” – Sonečka si presenta a Cvetaeva, come un “vivo incendio”. Sonečka e Marina sono al centro di una fittissima trama amorosa che coinvolge Pavlik, Jura e Volodja, rispettivamente Pavel Antokol’skij, Jurij Zavadskij e Vladimir Alekseev, legati a filo doppio da tormentate e spesso non corrisposte passioni.
Qui Cvetaeva, all’epoca poetessa in divenire con le due raccolte Album serale e La lanterna magica già pubblicate, incontra il teatro: tra il 1918 e il 1919 scrive sei pièces in versi che guardano al Settecento, un’epoca lontana anni luce dal presente, non cronologicamente ma per stile e comportamento. Sembrerebbero corpi estranei alla sua produzione – lei stessa aveva sempre sostenuto di non amare il teatro – e in un certo senso lo sono: Cvetaeva le definisce una “festa”, un momento di prodigio, stagliato su un destino che da lì in poi assumerà contorni sempre più neri. Una festa che Cvetaeva ritrova, per quel breve tratto di esistenza, in Sof’ja Evgen’evna Gollidej – russificazione di Hollyday, “festa” appunto, giacché la poeta si muove di suono in suono – , attrice che nel 1916, poco più che ventenne, è ammessa al Secondo Studio diretto da Vachtang Mčeledov dove, nel giro di pochi mesi, inizia a riscuotere grandi successi. Lunghe trecce nere, occhi enormi, complessione da bambina: così nell’aprile del 1919 – “il più nero, mortale, pestilenziale”, in quella città, Mosca, “dove non c’erano più poeti, come su tutta la terra” – Sonečka si presenta a Cvetaeva, come un “vivo incendio”. Sonečka e Marina sono al centro di una fittissima trama amorosa che coinvolge Pavlik, Jura e Volodja, rispettivamente Pavel Antokol’skij, Jurij Zavadskij e Vladimir Alekseev, legati a filo doppio da tormentate e spesso non corrisposte passioni.
Sullo sfondo di un paese in preda agli smottamenti e cataclismi rivoluzionari di cui Cvetaeva è testimone precisa – “La mia precisione è la mia estrema, postuma fedeltà” – e disincantata – “Scriverò un giorno una Storia della vita quotidiana nella Mosca del 1919. Non conosco altra Rivoluzione!” – , si svolgono i tormenti amorosi dei vari personaggi che in realtà fungono soltanto da molla per far scaturire i ricordi: “In sostanza nel mio racconto non c’erano personaggi. C’era l’amore. Era lui ad agire ‘attraverso i personaggi’”. È Sonečka il perno attorno al quale tutto ruota, il motore primo, l’essenza dell’amore: per quella ragazza piccola e volitiva, pungente e sarcastica, capricciosa per carattere e professione, “amare” significa “essere”, “annientarsi nell’altro – per compiersi”. Eterna innamorata dell’amore, gli dà un nome e un cognome – sempre diverso – soltanto per potersi gettare ai suoi piedi, per adorarlo in ginocchio. Per Cvetaeva, che alimenterà la poesia degli anni futuri con l’amore, o meglio con l’assenza di questo, Sonečka è uno snodo fondamentale che richiede tutto l’armamentario stilistico e lessicale del poeta per essere raccontato – “Sonečka, per te sto saccheggiando tre vocabolari!” –, molti anni dopo, quando Cvetaeva vive da tempo fuori dalla Russia.  È infatti nel maggio del 1937 che la poetessa riceve dalla figlia Alja una lettera da Mosca con la notizia della morte dell’attrice. Sonja Gollidej se ne era andata il 6 settembre 1934 per un cancro al fegato, quasi a suggellare amaramente il suo finale ossequio a Dostoevskij – che di fegati malati se ne intendeva –, scrittore a lei così caro: la sua magistrale interpretazione delle Notti bianche (1848) l’aveva portata alla ribalta, lei stessa rivedeva in Netočka Nezvanova (1849) la storia con Marina – “È una storia che parla di noi due, ed è anche incompiuta – come la nostra…” – . Nell’estate del 1937, in vacanza a Lacanau Océan, Cvetaeva si guarda indietro e scrive il suo epitaffio per Sonečka, traboccante di vita e di luce, la sua “ultima vampata”, che, anche nella splendida versione italiana, vibra della stessa “prodigiosa” forza. In realtà il cuore di Cvetaeva sussulta ancora molte volte dopo l’abbandono della Russia nel 1922, ma al contempo si consolida sempre di più quella poetica del distacco che non è mai in Cvetaeva mero espediente estetico, ma memoria di un’esistenza tragicamente sofferta e semmai distillata e decantata nell’arte.
È infatti nel maggio del 1937 che la poetessa riceve dalla figlia Alja una lettera da Mosca con la notizia della morte dell’attrice. Sonja Gollidej se ne era andata il 6 settembre 1934 per un cancro al fegato, quasi a suggellare amaramente il suo finale ossequio a Dostoevskij – che di fegati malati se ne intendeva –, scrittore a lei così caro: la sua magistrale interpretazione delle Notti bianche (1848) l’aveva portata alla ribalta, lei stessa rivedeva in Netočka Nezvanova (1849) la storia con Marina – “È una storia che parla di noi due, ed è anche incompiuta – come la nostra…” – . Nell’estate del 1937, in vacanza a Lacanau Océan, Cvetaeva si guarda indietro e scrive il suo epitaffio per Sonečka, traboccante di vita e di luce, la sua “ultima vampata”, che, anche nella splendida versione italiana, vibra della stessa “prodigiosa” forza. In realtà il cuore di Cvetaeva sussulta ancora molte volte dopo l’abbandono della Russia nel 1922, ma al contempo si consolida sempre di più quella poetica del distacco che non è mai in Cvetaeva mero espediente estetico, ma memoria di un’esistenza tragicamente sofferta e semmai distillata e decantata nell’arte.
I sette poemi inclusi nella raccolta tradotta e curata con maestria da Paola Ferretti sono stati composti tra il 1926 e il 1930, tra la Boemia e la Francia, e sono “la massima testimonianza spirituale” della poetessa: in queste grandi composizioni in versi degli anni venti affiorano a più riprese tutte le impronte digitali della sua scrittura. Ancora una volta “pre-testo” delle creazioni poetiche sono incontri – anzi, assenze – amorose, fuochi, più o meno fatui che hanno un solo scopo: alimentare la fiamma “come una grandissima stufa che, per funzionare, ha bisogno di legna, legna, legna… e la qualità della legna non è molto importante”, come osserva con lucidità il marito Sergej Efron in una lettera dei primi anni venti all’amico Maksimilian Vološin. C’è però legna e legna e tre sono le figure che fanno capolino tra i versi: Konstantin Rodzevič, il vitale “Arlecchino russo” conosciuto e amato nel 1923, dedicatario del Poema della montagna e del Poema della fine. 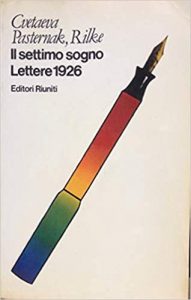 A tutt’altro livello di intensità lirica sono invece Boris Pasternak e Rainer Maria Rilke, la cui presenza dilaga negli altri poemi, in un gioco di rimandi e riflessi tra poesia e carteggio – nel 1926 si svolge la bellissima corrispondenza a tre, pubblicata in italiano nel 1994 da Editori Riuniti con il titolo Il settimo sogno, a cura di Serena Vitale. La preziosa Introduzione al volume guida e orienta il lettore nella selva tematica e sonora dei versi in cui la materia verbale è sottoposta a una costante tensione espressiva che testimonia il percorso di ricerca, mai concluso, del poeta. Quanto era racchiuso in nuce nelle prime raccolte, trova qui precisazione, sviluppo, approfondimento: la ben nota scrittura sincopata di Cvetaeva si frammenta in miriadi di segni interpuntivi – i prediletti tirés e le non meno amate parentesi – e negli ossessivi enjambements, nelle anafore e nella martellante paronomasia. Come nota Michail Gasparov, attentissimo lettore di Cvetaeva, “l’arte del refrain” che era apparsa nelle pièces giovanili, si manifesta appieno nella maturità.
A tutt’altro livello di intensità lirica sono invece Boris Pasternak e Rainer Maria Rilke, la cui presenza dilaga negli altri poemi, in un gioco di rimandi e riflessi tra poesia e carteggio – nel 1926 si svolge la bellissima corrispondenza a tre, pubblicata in italiano nel 1994 da Editori Riuniti con il titolo Il settimo sogno, a cura di Serena Vitale. La preziosa Introduzione al volume guida e orienta il lettore nella selva tematica e sonora dei versi in cui la materia verbale è sottoposta a una costante tensione espressiva che testimonia il percorso di ricerca, mai concluso, del poeta. Quanto era racchiuso in nuce nelle prime raccolte, trova qui precisazione, sviluppo, approfondimento: la ben nota scrittura sincopata di Cvetaeva si frammenta in miriadi di segni interpuntivi – i prediletti tirés e le non meno amate parentesi – e negli ossessivi enjambements, nelle anafore e nella martellante paronomasia. Come nota Michail Gasparov, attentissimo lettore di Cvetaeva, “l’arte del refrain” che era apparsa nelle pièces giovanili, si manifesta appieno nella maturità.
Questa esuberante forza primigenia, vero e proprio stichija verbale, trova corrispondenza naturale nelle forze elementari che ricorrono, in dosaggi alternati, nei poemi. Acqua, aria, terra, fuoco veicolano di volta in volta significati diversi: il culto della verticalità, ritrovato nelle scabre pendici della montagna, la separazione sublimata nell’acqua dell’oceano, del fiume, delle lacrime, la devastazione purificatrice del fuoco e infine l’invisibile orizzonte aereo, ambigua meta in equilibrio tra un sogno di morte e l’eternità. Immagini già di per sé pregne di simboli, ulteriormente arricchite di rimandi biblici, folklorici e mitologici, serbatoi cui Cvetaeva attinge con generosità e che contribuiscono alla stratificazione del senso ultimo, perennemente rincorso dal poeta.
Come in Sonečka, la protagonista è data per oggetti e concetti – poltrona, baule, ordine, cassa da morto – con inquadrature che ricordano il miglior Ejzenštejn. Anche nei poemi Cvetaeva cede spesso alla tentazione reificatrice: così la parete della stanza si fa “schiena ricurva sul piano”, dei clacson si sente l’insistente “ululare”, fino all’apoteosi della “cosa”, vešč’, che imperversa in Poema della scala. Nel turbine poetico di Cvetaeva, infatti, vita, morte o sogno – il sublime e l’inferno dell’esistenza (bytie) – si scontrano in un perenne corpo a corpo con la claustrofobia del quotidiano (byt): i due mondi si toccano e al poeta non è data via di fuga dall’angusto durare dei giorni, se non nella perdita dei sensi, nel puro suono, nell’estasi dell’aria – forse presagio funesto del suicidio “aereo” di Cvetaeva? –, unico spazio in cui la separazione cede il passo al ricongiungimento.
Alla fine di Sonečka, Cvetaeva scrive: “Non ritengo necessario aggiungere che dopo di lei non ho più amato nessun essere femminile, né mai, certamente, lo farò: amo sempre meno, conservando il poco calore che mi resta per quelli che ormai non può più riscaldare”. Quattro anni dopo aver scritto quelle parole, il calore si esaurisce del tutto: Cvetaeva si impicca a Elabuga il 31 agosto 1941; nel momento in cui non c’è più scintilla né fiamma a scaldarla, la sua vita finisce. A noi, invece, quell’amore rimane, riconosciuto, distillato e rifratto in parole – tradotte e ancora da tradurre – , fissato nella memoria verbale delle prose, delle lettere, degli appunti e delle poesie, dell’arte che eternamente consola e instancabilmente ricuce, per ricordarci che, se si risponde a quella richiesta di amore, non si muore mai.
giulia.deflorio@unimore.it
G. De Florio insegna lingua e cultura russa all’Università di Modena e Reggio Emilia


