Quelle che vanno, quelle che restano: le parole del traduttore
di Anna D’Elia
 Molti anni fa, quando ero ancora giovane e tremebonda, andai a parlare con un grande autore di teatro francese di cui stavo traducendo un testo. Tesissima, gli esposi i tanti dubbi e le poche, timorose proposte che mi venivano in mente, e lui, guardandomi divertito, mi disse, indicando un punto sulla pagina: «Faccia come crede, l’importante è che qui ci sia una rima». Negli anni che seguirono quel lontanissimo incontro, mi è capitato di pensare spesso a quella ‘famosa’ rima e al sollievo che ne ricavai. Credo in fondo di essermi dotata, nella mia esistenza di traduttore, di una modesta cassetta degli attrezzi che mi permette di fare proprio questo: ancorare la pagina con dei bulloni là dove serve, agganciarci dei tiranti, e tenerla su grazie a un sistema di spinte e controspinte. Sono insomma sempre stata sensibile agli ancoraggi ritmici che ho imparato a riconoscere negli anni in cui traducevo per la scena. Avere per le mani un meccanismo che ‘deve assolutamente funzionare’ quando viene detto, cantato o recitato è una condizione benedetta che auguro ad ogni traduttore. Tradurre per degli attori, e dunque per degli spettatori, mette per sempre al riparo dalla sterile soddisfazione di avere fatto un lavoro corretto che basta a se stesso. In teatro, la folla muta dei ‘normali’ lettori si trasforma infatti in un parterre di occhi e orecchie attenti ed assassini, che vanno agguantati e trascinati finché ci sono. Dopo cala il sipario e ad aleggiare rimane un’assonanza, un suono, un vuoto. Dicono che non si arrivi mai a tradurre un testo per caso, ma che si finisca quasi sempre a occuparsi di un autore per misteriose e telluriche ragioni, ignote solo a chi ne è attraversato.
Molti anni fa, quando ero ancora giovane e tremebonda, andai a parlare con un grande autore di teatro francese di cui stavo traducendo un testo. Tesissima, gli esposi i tanti dubbi e le poche, timorose proposte che mi venivano in mente, e lui, guardandomi divertito, mi disse, indicando un punto sulla pagina: «Faccia come crede, l’importante è che qui ci sia una rima». Negli anni che seguirono quel lontanissimo incontro, mi è capitato di pensare spesso a quella ‘famosa’ rima e al sollievo che ne ricavai. Credo in fondo di essermi dotata, nella mia esistenza di traduttore, di una modesta cassetta degli attrezzi che mi permette di fare proprio questo: ancorare la pagina con dei bulloni là dove serve, agganciarci dei tiranti, e tenerla su grazie a un sistema di spinte e controspinte. Sono insomma sempre stata sensibile agli ancoraggi ritmici che ho imparato a riconoscere negli anni in cui traducevo per la scena. Avere per le mani un meccanismo che ‘deve assolutamente funzionare’ quando viene detto, cantato o recitato è una condizione benedetta che auguro ad ogni traduttore. Tradurre per degli attori, e dunque per degli spettatori, mette per sempre al riparo dalla sterile soddisfazione di avere fatto un lavoro corretto che basta a se stesso. In teatro, la folla muta dei ‘normali’ lettori si trasforma infatti in un parterre di occhi e orecchie attenti ed assassini, che vanno agguantati e trascinati finché ci sono. Dopo cala il sipario e ad aleggiare rimane un’assonanza, un suono, un vuoto. Dicono che non si arrivi mai a tradurre un testo per caso, ma che si finisca quasi sempre a occuparsi di un autore per misteriose e telluriche ragioni, ignote solo a chi ne è attraversato.
Mi piace credere che sia così e che dunque misteriose e telluriche ragioni mi colleghino all’edificio post esotico e ai libri di Antoine Volodine. Ci sono entrata dal tetto, dall’alto, e vado avanti a ritroso, scendendo un piano dopo l’altro dentro la sua imponente costruzione. Della teatralità dei suoi romanzi si è scritto e detto molto, anche se non tanto, forse, quanto del suo occhio cinematografico, della sua fascinazione per il singolo fotogramma, i piani sequenza, la composizione visiva, lo zoom. Eppure la creazione di uno spazio scenico dove far muovere personaggi e parole è onnipresente nei suoi testi, insieme a un’attenzione ossessiva per il ritmo e il timbro della frase che danno vita a una étrange partition sonore, dove suoni e immagini ‘sprigionati’ dalle parole, concorrono a dar vita a un’opera-mondo. [1] Pensiamo a Umrug Batiuchine, ad esempio, ragazzino solitario abbandonato dalla madre in mezzo alla foresta in Terminus radioso, per il quale:
Le giornate erano infinite e lui le riempiva ripetendo in maniera stentata i testi su cui aveva imparato a leggere. Oltre a nugoli di mosche e zanzare, un pubblico di piccole dimensioni si radunava ad ascoltarlo, due o tre bruchi pelosi, qualche formica, a volte un volpacchiotto che aveva ancora tutto da imparare.
O, sempre in Terminus, al bardo Matthias Boyol che:
Vagava dunque ai margini dei dormitori o lungo interminabili viali fiancheggiati da tende dell’esercito e continuava a proporre rappresentazioni, pur se estemporanee e basate su un unico attore. Il suo repertorio si limitava a monologhi da folle o a rimuginii post-esotici in versi liberi.
Per non parlare dell’anfiteatro che emerge dai calcinacci di Pollaio Quattro in Sogni di Mevlidò, dove si svolge il duello finale tra l’eroe e l’avvoltoio Gluck dinanzi a un pubblico composto da topi, ragni e gallinacei mutanti:
Si trascinò in quel modo fino a un punto in cui il terreno diventava piano e sgombro per qualche metro, delimitando uno spazio scenico circondato da cumuli nerastri. I detriti formavano la metà di un cratere. Sembra un piccolo teatro, pensò. Un piccolo anfiteatro con delle specie di gradini nerastri. Per la scena finale.
Gli spettatori delle pièces post esotiche sono tanti, spesso minuscoli e insignificanti, o reietti allo sbando o sfaccendati, umani, sub-umani, animali o piante, attratti dal suono della voce narrante, dalle pause, dal ritmo cadenzato della prosa. Si assembrano e rimangono zitti ad ascoltare l’epopea del mondo, affidata a una lingua «che viene dall’altrove e incede verso l’altrove», una lingua misteriosa e aliena che arriva sino a noi in traduzione. Priva di espressioni gergali, di regionalismi, di strizzatine d’occhio a contesti storici identificabili, di coloriture nazionali, la lingua post esotica è uno strano oggetto, di sovrano interesse per un traduttore. È una lingua limpida ma imperiosa che, come un fronte lavico, avanza inesorabile, inglobando sul suo cammino ogni altra lingua, ogni altra cosa.
La massa dei romanzi post esotici, insomma – per citare lo stesso Volodine – «costituisce un oggetto letterario pubblicato in francese, ma pensato in una lingua esterna al francese, indistinta, quanto a nazionalità. Una lingua non riferibile a una determinata area geografica ed evidentemente ‘straniera’ (…) Quella lingua è un vasto territorio indifferenziato che ha ricevuto le traduzioni di numerosissime altre lingue e non solo le ha ricevute, ma le ha adottate e integrate. Mi sono sempre sforzato di scrivere i miei libri in questa lingua di traduzione ». [2]
Ma questa lingua monstrum ‘orizzontale’, che si trascina dietro e ingloba tanti mondi, li fa propri e li digerisce, non è forse quella di ogni traduttore? Non traccia, forse, anche quest’ultimo una curiosa partitura sonora che pesca nella sua biblioteca e nelle tante voci che vi si annidano? Non organizza forse oculatamente anch’egli il brusio di fondo prodotto dai suoi libri, dalle pagine sfogliate, dalle parole rimaste impigliate nella sua memoria? Ho sempre pensato che nelle diverse traduzioni di uno stesso testo non si affrontino solo due traduttori, ma due bibliotecari (e sorrido pensando all’incubo dell’uomo sfogliato dai suoi stessi libri) e che se mai dovessi tenere un diario di bordo del mio lavoro di traduzione, finirei per disegnare un immenso e madreporico rizoma che corre intorno alla pagina, comprensivo di parole, immagini, rimandi, assonanze, telefonate, pagine web, canzoni, Google Maps, prescrizioni mediche, sms, articoli di giornale e trasmissioni che entrano ed escono dalla mia testa e dal mio testo. Un rizoma che tenga conto insomma delle intromissioni sonore e visive di altri testi in quello che vado scrivendo. Alle prese, in Terminus radioso, con i sulfurei poemi di Soloviei, ad esempio, lo stregone usignolo delle biline russe, non riuscivo a sbarazzarmi, sempre a proposito di ancoraggi ritmici, del famoso «letto incendiato sulla strada di Trento e del pettirosso da combattimento» di italianissima memoria.
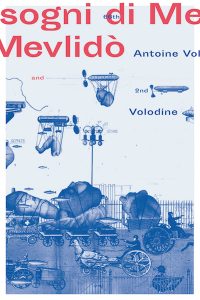 Lingua ‘lavica’ dunque, lingua inglobante, che regge grazie a una ferrea struttura ritmica che va assolutamente ricreata, ricodificandola però in un’ulteriore lingua, quella del secondo traduttore. Ed è qui che la cosa si fa più interessante, perché, come ha scritto acutamente qualcuno, siamo tutti diventati dei blasé dello spazio e insieme dei provinciali del tempo.[3] Abbiamo un’enorme dimestichezza a maneggiare mentalmente e fisicamente la distanza spaziale – paesi lontani, città lontane, lingue lontane – meno quella temporale che si estende sotto i nostri piedi come un immenso mare ignoto. Usiamo tranquillamente parole che vengono dal fondo di quel mare ignorando spesso quasi tutto del loro lungo viaggio sino a noi, sino alla superficie increpata dei secoli da cui fanno capolino. Le maggiori difficoltà che ho incontrato nel ri-criptare la lingua post esotica è proprio in quel fare i conti con il peso temporale di una parola, con il suo passato e la sua polvere di tempo. Là dove la frase volodiniana risuona limpida e metatemporale, la sua trasposizione in un altro codice va a cozzare contro ostacoli che hanno proprio a che fare col tempo, con la stratificazione di significati che la parola si trascina dietro dal fondo di altre epoche e che finché saranno vivi e ‘irradianti’, non possono essere ignorati. E qui vale un esempio per tutti, quell’éloge des camps’, in cui la carica ossimorica della prima traduzione (éloge des camps) si perderebbe nella seconda (elogio dei campi) e porta il secondo traduttore a ‘ricaricare la frase’ come un meccanismo a molla, affinché continui a sprigionare distopico senso. [4]
Lingua ‘lavica’ dunque, lingua inglobante, che regge grazie a una ferrea struttura ritmica che va assolutamente ricreata, ricodificandola però in un’ulteriore lingua, quella del secondo traduttore. Ed è qui che la cosa si fa più interessante, perché, come ha scritto acutamente qualcuno, siamo tutti diventati dei blasé dello spazio e insieme dei provinciali del tempo.[3] Abbiamo un’enorme dimestichezza a maneggiare mentalmente e fisicamente la distanza spaziale – paesi lontani, città lontane, lingue lontane – meno quella temporale che si estende sotto i nostri piedi come un immenso mare ignoto. Usiamo tranquillamente parole che vengono dal fondo di quel mare ignorando spesso quasi tutto del loro lungo viaggio sino a noi, sino alla superficie increpata dei secoli da cui fanno capolino. Le maggiori difficoltà che ho incontrato nel ri-criptare la lingua post esotica è proprio in quel fare i conti con il peso temporale di una parola, con il suo passato e la sua polvere di tempo. Là dove la frase volodiniana risuona limpida e metatemporale, la sua trasposizione in un altro codice va a cozzare contro ostacoli che hanno proprio a che fare col tempo, con la stratificazione di significati che la parola si trascina dietro dal fondo di altre epoche e che finché saranno vivi e ‘irradianti’, non possono essere ignorati. E qui vale un esempio per tutti, quell’éloge des camps’, in cui la carica ossimorica della prima traduzione (éloge des camps) si perderebbe nella seconda (elogio dei campi) e porta il secondo traduttore a ‘ricaricare la frase’ come un meccanismo a molla, affinché continui a sprigionare distopico senso. [4]
Quando penso al lavoro del traduttore mi riconosco profondamente in questo doppio e faticoso ruolo: seguire la lingua dove essa va – Volodine direbbe verso dove essa incede – e al contempo guardare alle proprie spalle (o sotto i piedi) per ‘portarsi dietro’ l’altrove da cui essa viene, spaziale o temporale che sia. In questo gioco fascinoso e logorante il traduttore e la sua lingua sono legati anch’essi, come nelle poesie di Giulia Martini, in una feroce ‘coppia minima’[5] – Tu vai verso quello che credi/io verso quello che rimane – dove animano spietati scambi. (E qui, a proposito di tracce, non posso non pensare alla scia impalpabile, al ronzio digitale che ogni traduttore lascia dietro di sé, annidato nella cache del suo computer, mentre controlla lemmi sui motori di ricerca).
Il ritmo dicevamo, riconoscibilissimo, unico, pervasivo, delle pagine post esotiche, dà origine a una musica di fondo che assume di volta in volta le sembianze del «ronzio regolare della caldaia» o del «leggero ronzio atomico proveniente dalle viscere della Terra» (…) o di un tremolio «buono per far capire e amare l’ignoto e la non-conoscenza», e che finisce per sovrapporsi, o forse per incarnare, il ritmo cui risponde la respirazione post esotica tutta, quella dei suoi tanti autori, ma soprattutto dei lettori:
Proseguì a rombare in quel modo sino a che Mevlidò non si assopì e, anche allora, la vibrazione continuò a prolungarsi, la musica delle fiamme non si chetò, la melodia della distruzione e poi del viaggio che, sia come sia, abita in noi, da sempre, e che al momento del sonno ciascuno confonde con la propria esistenza o con la morte.
In queste poche righe consegnate da Volodine a Sogni di Mevlidò, la mise en abîme del testo, meccanismo tanto caro all’edificio post esotico, si dispiega in tutta la sua potenza. Il funzionario Migrelian, novello amanuense emerso dalle notte dei tempi, incaricato dagli Organi di redigere per i loro archivi le disavventure di Mevlidò, riprende a sua volta la frase e il suo ritmo, lo amplifica, e lo riconsegna al lettore popolandolo dei suoi privati fantasmi:
La musica delle fiamme non si chetò, scrisse più tardi Mingrelian nel suo rapporto, la melodia della distruzione e poi del viaggio, il canto gutturale, armonioso, regolare, (…) quel frastuono oscuro che, sia come sia, abita in noi, riposa in noi da sempre, come sorto sciamanicamente da un mare immobile, untuoso, greve, non visitabile, affatturante, sordo, senza rive né profumi, risplendente, nero, senza struttura che non sia l’infinito, senza colore né mitezza, un mare primigenio totalmente nero, ma che chiudendo gli occhi Mevlidò immaginava rosso, o arancione, e che al momento del sonno, quando in lui svaporava ogni coscienza, ogni intelligenza, vedeva in verità amichevole e arancione, ospitale, seduttivo e rosso, accogliente, ed arancione.
Il Volodine-Mevlidò, e poi il Volodine-Migrelian, raggiungono così, riscrivendo e caricando ogni volta il testo di ulteriore senso, il primo, il secondo, il terzo, i mille altri lettori-traduttori chiamati a batterne il tempo, a mantenerne il ritmo, contribuendo così a una respirazione cosmica, abissale, pulsante che è forse semplicemente quella della risacca del nostro mare nero e della grande, grandissima letteratura.
[1] Cfr. «Jazzosphère», hors série. n° 1, L’étrange partition sonore : livre-disque Musique et univers imaginaires, Paris 2007, (Considerazioni sui rapporti tra l’universo grafico o letterario e la musica, con la partecipazione di Enki Bilal, François Schuiten, Antoine Volodine e Christian Volckman). Sui rapporti tra Enki Bilal e il post esotismo, almeno in Italia, c’è ancora tutto da scrivere, a cominciare dal ricorso agli uccelli mutanti, e alle eroine androgine à la Jill Bioskop, la Donna Trappola.
[2] A. Volodine, «Écrire en français une littérature étrangère », Chaoïd [en ligne]: International, automne-hiver 2002, n° 6.
[3] Maurizio Bettini, A che servono i Greci e i Romani, Einaudi, 2017, pp. 52-55.
[4] Tedx Talk Matera, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=QcierOXq4Ps
[5] Giulia Martini, Coppie Minime, Interno poesia, 2018
A. D’Elia è traduttrice letteraria dal francese


