Il presente non inquini il passato
di Giuseppe Sergi
Nell’Indice di gennaio e di marzo 2019 due eccellenti medievisti, Chris Wickham e Walter Pohl, sono stati chiamati a esprimersi sul contributo delle loro ricerche alla storia dell’Europa. Wickham afferma di non aver riconosciuto all’Europa il carattere di “campo di studi privilegiato” e di essersi quindi orientato verso la comparazione con altri ambiti di civiltà. Individua nell’Italia “una grande regione interamente dominata dalle città”. Ricorda di aver applicato in passato alla storia socio-economica un registro “forse anche troppo” analitico: autocritica da non condividere, perché grazie alle ricerche analitiche ha dimostrato, per gran parte del continente europeo, la “cristallizzazione delle strutture del potere locale durante un ‘lungo’ XI secolo”. Pohl denuncia non solo le “semplificazioni”, ma anche le “mistificazioni” delle storie nazionali raccontate con “grandi narrazioni lineari” ancora molto presenti nelle “percezioni popolari”. La ricerca medievistica ha dimostrato “senza ombra di dubbio che l’appartenenza a un popolo non è determinata dai geni e dalle origini biologiche”. Di più: “nel corso della storia cambiano non soltanto le etnie” ma “si modifica anche il significato dell’etnicità stessa”.
 Due studiosi di formazione diversa provano dunque che una buona conoscenza del medioevo serve a contrastare le storture che derivano dal “mito delle origini” già denunciato da Marc Bloch. Un mito alimentato dall’“oscurità” dell’alto medioevo, che lo rende – per usare le parole dello storico americano Patrick Geary – “facile preda dei sostenitori del nazionalismo etnico: alcune rivendicazioni possono essere fondate impunemente su un’appropriazione del periodo delle migrazioni, proprio in quanto pochissimi lo conoscono davvero”. Le due interviste confermano che né l’Europa né le nazioni sono “realtà sociali e culturali distinte, stabili e oggettivamente identificabili”. La ricerca di radici è un motore importante dell’interesse non professionale per la storia. È una dinamica operante non solo nei nazionalismi maggiori, come già si desume da L’invenzione della tradizione di Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Ad esempio non è del tutto da inserire nel pangermanesimo, come affermato da Pohl, il ricorso al passato da parte dell’Austria: non sono mancate fra Otto e Novecento ricostruzioni identitarie tirolesi volte a rivendicare la specificità di una “piccola patria”. Spesso, al di fuori della medievistica universitaria, si constata che il massimo di falsificazione è reperibile in storiografie che possiamo definire rivendicative: è vero per scozzesi, bretoni, occitani, baschi. In forma estrema – e per una fase politica già chiusa – per i presunti padani in Italia.
Due studiosi di formazione diversa provano dunque che una buona conoscenza del medioevo serve a contrastare le storture che derivano dal “mito delle origini” già denunciato da Marc Bloch. Un mito alimentato dall’“oscurità” dell’alto medioevo, che lo rende – per usare le parole dello storico americano Patrick Geary – “facile preda dei sostenitori del nazionalismo etnico: alcune rivendicazioni possono essere fondate impunemente su un’appropriazione del periodo delle migrazioni, proprio in quanto pochissimi lo conoscono davvero”. Le due interviste confermano che né l’Europa né le nazioni sono “realtà sociali e culturali distinte, stabili e oggettivamente identificabili”. La ricerca di radici è un motore importante dell’interesse non professionale per la storia. È una dinamica operante non solo nei nazionalismi maggiori, come già si desume da L’invenzione della tradizione di Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Ad esempio non è del tutto da inserire nel pangermanesimo, come affermato da Pohl, il ricorso al passato da parte dell’Austria: non sono mancate fra Otto e Novecento ricostruzioni identitarie tirolesi volte a rivendicare la specificità di una “piccola patria”. Spesso, al di fuori della medievistica universitaria, si constata che il massimo di falsificazione è reperibile in storiografie che possiamo definire rivendicative: è vero per scozzesi, bretoni, occitani, baschi. In forma estrema – e per una fase politica già chiusa – per i presunti padani in Italia.
L’invenzione del passato propagandistica e volontaria ha avuto negli ultimi decenni, dopo la disgregazione del blocco sovietico, un rilancio nell’est europeo: con interventi anche sui programmi scolastici, allo scopo di valorizzare eroi-personaggi “mitomotori” e periodi esaltati come “età dell’oro” di ogni nazione. “Età dell’oro” non è quasi mai un concetto difensivo, usato per riconquistare e per tutelare autonomie circoscritte: è un concetto intrinsecamente imperialista e aggressivo, perché la propaganda evoca con nostalgia fasi di dominio sui vicini. Vediamo realtà politiche per lo più nuove che pretendono di essere antiche: è un ossimoro che condiziona il rapporto popolare con la storia, una pratica selettiva (e spesso inventiva) volta a costruire una memoria che gli storici – e i medievisti in particolare – sono sempre in grado di smentire.
Questi richiami al passato, quando sono volontari, sono tuttavia abbastanza facili da smascherare. Più insidiosi sono i luoghi comuni che derivano dalla “deformazione prospettica” su cui ho insistito in passato: l’istinto che ci conduce a proiettare sul “prima” realtà più vicine a noi, più visibili e conoscibili. È la meno consapevole fra le cause delle “retroproiezioni” denunciate da vari storici. Con la complicità di una quasi naturale propensione per la linearità dello sviluppo storico, la cultura comune interpreta come residui del passato aspetti sociali, economici e culturali che appaiono dissonanti dalla cornice dominante del presente: e li interpreta o prendendo le distanze o con nostalgia. Che le domande sul passato derivino da un questionario imposto dal presente non è di per sé un errore – su questo Bloch non era soltanto assolutorio, ma addirittura auspicante – ma ciò che il mestiere di storico ha il compito di correggere è la selezione, l’invenzione, la cecità rispetto ad esperienze che, non vincenti, hanno lasciato poche tracce.
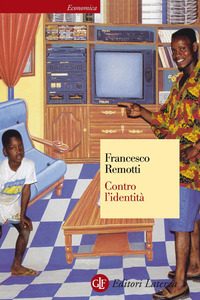 L’Europa attuale, pur confusa e contraddittoria, non deve indurre a domande che la entifichino per cercare tappe della sua formazione: Jacques Le Goff era polemico contro una presunta idea d’Europa presente già in Carlo Magno; Pohl insiste sulla necessità di concentrarsi sulla complessità del “sistema di equilibrio fra popoli e stati”; Wickham non è attratto dalla specifica dimensione europea come campo di ricerca. Nazioni grandi e piccole non devono guardare al proprio passato considerandolo soltanto “proprio”, con infondati condizionamenti identitari (ricordiamo Francesco Remotti e il suo Contro l’identità, Laterza 2007; Jean-Loup Amselle e i suoi Logiche meticce – Bollati Boringhieri, 1999 e L’identità etnica – Carocci, 2013). Non è scontro fra due ideologie, quella degli esperti non lo è. Il dibattito fra medievisti riflette su dati concreti e dà prova di forti convergenze nel valutare definizioni di popoli come goti, bulgari, ungari, longobardi, alamanni, franchi. Su una sponda estrema e decostruzionista si pone Walter Goffart che nega l’identificabilità di quei popoli, attribuendo la loro identità – prevalentemente terminologica – alle costruzioni dei loro “narratori”. C’è invece larga condivisione dei risultati della scuola di Vienna di Herwig Wolfram (in cui è inserito Pohl) che nega, sì, l’identità etnica compatta e stabile, e osserva popoli in movimento come aggregati tribali misti in cui la prevalenza di un clan-guida determina anche la nomenclatura di spedizioni e insediamenti: c’è di tutto nell’esercito longobardo – quindi non tale “per sangue” – che entra in Italia, c’è di tutto nel successivo regno longobardo. Le definizioni apparentemente nazionali non sopravvivono soltanto per comodità comunicativa – che pure ha un suo peso – ma anche perché mostrano la loro vitalità nel passaggio dalle migrazioni allo stanziamento. L’aggregato misto guidato dalla tribù dei burgundi si insedia nella Gallia sud-orientale nel secolo V; il regno prende il nome di Burgundia (Borgogna), mentre in quella regione vivono gallo-romani e altri diversi germani; dopo l’anno 1000 è burgundo-borgognone chi vive in quella regione o da essa proviene, con una definizione territoriale che non è più un etnonimo, non ha rapporti con gli ascendenti tribali.
L’Europa attuale, pur confusa e contraddittoria, non deve indurre a domande che la entifichino per cercare tappe della sua formazione: Jacques Le Goff era polemico contro una presunta idea d’Europa presente già in Carlo Magno; Pohl insiste sulla necessità di concentrarsi sulla complessità del “sistema di equilibrio fra popoli e stati”; Wickham non è attratto dalla specifica dimensione europea come campo di ricerca. Nazioni grandi e piccole non devono guardare al proprio passato considerandolo soltanto “proprio”, con infondati condizionamenti identitari (ricordiamo Francesco Remotti e il suo Contro l’identità, Laterza 2007; Jean-Loup Amselle e i suoi Logiche meticce – Bollati Boringhieri, 1999 e L’identità etnica – Carocci, 2013). Non è scontro fra due ideologie, quella degli esperti non lo è. Il dibattito fra medievisti riflette su dati concreti e dà prova di forti convergenze nel valutare definizioni di popoli come goti, bulgari, ungari, longobardi, alamanni, franchi. Su una sponda estrema e decostruzionista si pone Walter Goffart che nega l’identificabilità di quei popoli, attribuendo la loro identità – prevalentemente terminologica – alle costruzioni dei loro “narratori”. C’è invece larga condivisione dei risultati della scuola di Vienna di Herwig Wolfram (in cui è inserito Pohl) che nega, sì, l’identità etnica compatta e stabile, e osserva popoli in movimento come aggregati tribali misti in cui la prevalenza di un clan-guida determina anche la nomenclatura di spedizioni e insediamenti: c’è di tutto nell’esercito longobardo – quindi non tale “per sangue” – che entra in Italia, c’è di tutto nel successivo regno longobardo. Le definizioni apparentemente nazionali non sopravvivono soltanto per comodità comunicativa – che pure ha un suo peso – ma anche perché mostrano la loro vitalità nel passaggio dalle migrazioni allo stanziamento. L’aggregato misto guidato dalla tribù dei burgundi si insedia nella Gallia sud-orientale nel secolo V; il regno prende il nome di Burgundia (Borgogna), mentre in quella regione vivono gallo-romani e altri diversi germani; dopo l’anno 1000 è burgundo-borgognone chi vive in quella regione o da essa proviene, con una definizione territoriale che non è più un etnonimo, non ha rapporti con gli ascendenti tribali.
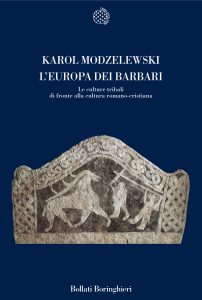 Durante gli spostamenti e gli insediamenti provvisori si verificano processi di successive e mutevoli etnogenesi – sono questi a essere contestati dai negazionisti radicali – che ogni volta ridefiniscono la storia di popoli intrecciati e sovrapposti e contaminano le loro tradizioni. Ci sono differenze fra regioni lontane. Nell’Europa settentrionale le leggi (soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia) sono territoriali, con tendenza all’uniformità; a sud, e in particolare in Italia, le leggi sono invece personali: in tribunale si applicano le norme longobarde, romane o alamanne a seconda della “dichiarazione di legge” pronunciata da ogni singola famiglia. Oltre al diritto, anche la lingua sembra giustificare l’insistenza di alcuni sulla definibilità di ambiti circoscrivibili di civiltà: l’uso comune di lingue slave nell’est europeo ha frenato Karol Modzelewski (L’Europa dei barbari, Bollati Boringhieri, 2008) nell’aderire in pieno alla diluizione identitaria proposta dalla scuola di Vienna. Ma si può obiettare che, anche se la territorializzazione comporta l’affermarsi – pur stentato – di una lingua prevalente, non per questo si cancella il carattere composito dell’insediamento e la coesistenza di diverse tradizioni in progressivo e reciproco adattamento.
Durante gli spostamenti e gli insediamenti provvisori si verificano processi di successive e mutevoli etnogenesi – sono questi a essere contestati dai negazionisti radicali – che ogni volta ridefiniscono la storia di popoli intrecciati e sovrapposti e contaminano le loro tradizioni. Ci sono differenze fra regioni lontane. Nell’Europa settentrionale le leggi (soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia) sono territoriali, con tendenza all’uniformità; a sud, e in particolare in Italia, le leggi sono invece personali: in tribunale si applicano le norme longobarde, romane o alamanne a seconda della “dichiarazione di legge” pronunciata da ogni singola famiglia. Oltre al diritto, anche la lingua sembra giustificare l’insistenza di alcuni sulla definibilità di ambiti circoscrivibili di civiltà: l’uso comune di lingue slave nell’est europeo ha frenato Karol Modzelewski (L’Europa dei barbari, Bollati Boringhieri, 2008) nell’aderire in pieno alla diluizione identitaria proposta dalla scuola di Vienna. Ma si può obiettare che, anche se la territorializzazione comporta l’affermarsi – pur stentato – di una lingua prevalente, non per questo si cancella il carattere composito dell’insediamento e la coesistenza di diverse tradizioni in progressivo e reciproco adattamento.
Eliminata (com’è doveroso) l’idea dell’inesistente paura dell’anno 1000, è da confermare che il cuore del medioevo è nel secolo XI delle signorie rurali e delle città, con un frazionamento attivo che si ricompone lentamente e variamente nei secoli successivi: una realtà indiscutibile che, anche se si presta a innocui localismi, non lascia spazio alle grandi narrazioni identitarie.
giuseppe.sergi@unito.it
G. Sergi è professore emerito di storia medievale dell’Università di Torino


