L’uso sibillino dei due punti
dal numero di marzo 2019
di Gandolfo Cascio
Pietro Citati
IL SILENZIO E L’ABISSO
pp. 318, € 22
Mondadori, Milano 2018
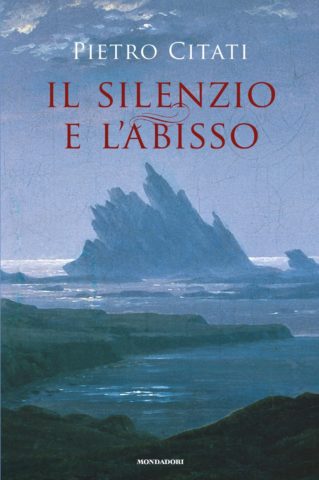 Con la spavalderia e la noncuranza del guappo, Harold Bloom sostiene che “la critica, o è parte della letteratura o non è niente” (The Anxiety of Influence, 1997). Il solenne motto tocca questioni care all’americano, ma ne spillo il corollario che un buon saggio – oltre a contenuti tersi e ad argomentazioni assennate – deve godere d’uno stile inedito, d’un suo ritmo inimitabile. Per cominciare, ciò andrebbe a vantaggio di chi legge; e poi perché “lo stile non è altro che l’ordine e il movimento che si mette nei propri pensieri”, come decretò tempo fa il conte di Buffon nel Discorso sullo stile; un tipo di cui mi fido ché con la letteratura non aveva molto a che fare. In Italia l’esempio più familiare e, forse, insuperato, è quello di De Sanctis: “All’ingresso del secolo incontriamo Machiavelli e l’Ariosto, come all’ingresso del Trecento trovammo Dante. Machiavelli aveva già trentun anno, e ventisei ne aveva l’Ariosto”. Come non lasciarsi frastornare e allettare da un’apertura come questa, dove le tende del teatro s’alzano su degli imprevisti giovanotti? Altrettanto esclusiva è stata la maniera di Croce e Borgese, Cecchi, Debenedetti e Praz, Solmi, Longhi, Macchia, Gramsci, del nobile Contini; più recentemente, di Garboli (smodatamente esteta), del trascurato Baldacci e, infine, di Citati: premiato infatti, insieme ad altri dei nominati, con un “Meridiano” (La civiltà letteraria europea da Omero a Nabokov, 2005). In una una comitiva a parte, scrittori-critici come Moravia o Montale (perfetto e perfido), Sciascia e Pasolini, oggi Montefoschi e Magris.
Con la spavalderia e la noncuranza del guappo, Harold Bloom sostiene che “la critica, o è parte della letteratura o non è niente” (The Anxiety of Influence, 1997). Il solenne motto tocca questioni care all’americano, ma ne spillo il corollario che un buon saggio – oltre a contenuti tersi e ad argomentazioni assennate – deve godere d’uno stile inedito, d’un suo ritmo inimitabile. Per cominciare, ciò andrebbe a vantaggio di chi legge; e poi perché “lo stile non è altro che l’ordine e il movimento che si mette nei propri pensieri”, come decretò tempo fa il conte di Buffon nel Discorso sullo stile; un tipo di cui mi fido ché con la letteratura non aveva molto a che fare. In Italia l’esempio più familiare e, forse, insuperato, è quello di De Sanctis: “All’ingresso del secolo incontriamo Machiavelli e l’Ariosto, come all’ingresso del Trecento trovammo Dante. Machiavelli aveva già trentun anno, e ventisei ne aveva l’Ariosto”. Come non lasciarsi frastornare e allettare da un’apertura come questa, dove le tende del teatro s’alzano su degli imprevisti giovanotti? Altrettanto esclusiva è stata la maniera di Croce e Borgese, Cecchi, Debenedetti e Praz, Solmi, Longhi, Macchia, Gramsci, del nobile Contini; più recentemente, di Garboli (smodatamente esteta), del trascurato Baldacci e, infine, di Citati: premiato infatti, insieme ad altri dei nominati, con un “Meridiano” (La civiltà letteraria europea da Omero a Nabokov, 2005). In una una comitiva a parte, scrittori-critici come Moravia o Montale (perfetto e perfido), Sciascia e Pasolini, oggi Montefoschi e Magris.
Epperò, alla resa dei conti, i critici-scrittori sono fatti della stessa pasta degli scrittori-critici, perché pure loro per mestiere sfruttano gli affari altrui, invocano creature sepolte o forestiere, e con esse hanno dei rapporti strampalati: senza distinzione tra creature genuine e fantastiche, proprio come Dante che nomina uno dietro l’altro Semiramide e Cleopatra, Elena e Achille, Paride e Tristano. Qualcosa del genere avviene in Citati, per cui protagonisti, luoghi e peripezie altrui, per quanto contraffatti o favolosi, risultano comunque convenienti ad essere (ri-)narrati. Fin dalla prima antologia, Il tè del cappellaio matto (1972), a parte ad aggiornare il suo lettore, s’è proposto di sedurlo, riportando, al di là dell’intreccio o dei casi dell’autore, anche i proprî incantamenti. In quel libro la prova più appagata è data dal Cuore arido di Cassola. Ha poi proseguito a rendere pubblici una serie di libri ariosi e seducenti; devoti, di volta in volta, a opera magna e a uomini e donne egregî. Tra i tanti, i più intriganti sono quelli con dei titoli mondi, dei nomi paurosi e accecanti che andrebbero acclamati senza posa, come un festone: Goethe Tolstoj Kafka Leopardi. Si giunge alla conclusione che la misura più conveniente per Citati non sia quella del “romanzo” – così vanno definite le monografie – ma quella breve del “racconto”, cioè le recensioni, i ritratti, le note sparsi sui giornali. Fedele a sé stesso, lo scrittore li accumula e poi li mette insieme, con un’impalcatura messa a punto: un personale cunto de li cunti che si affida alle atmosfere seduttive del “c’era una volta”. Anche nell’ultima collezione, Il silenzio e l’abisso, ogni pezzo, per quanto autonomo, risolto, soddisfatto della propria condizione, si completa in quella sede. Il titolo, come nella Certosa, s’intuirà solamente al termine.
Per l’allestimento Citati non privilegia né il sillabario, né il journal, che sovente è un atto di superbia. Preferisce praticare l’indifferente campione desanctisiano, sebbene egli parta da luoghi più remoti e da miti antichissimi. Se anche Citati però, come De Sanctis, creda a un sicuro progresso, non è chiaro; tuttavia nel finale, dopo gli eventi spietati e sciagurati del Novecento, si avverte con il Don Milani almeno la lusinga dell’illusione. Gli episodî più affascinanti sono quelli dedicati a san Francesco e a Lorenzo de’ Medici, esaltato per la sua scaltrezza; con il Tristram Shandy riesce a dire con invidiabile franchezza qualcosa sull’Inghilterra (di allora e magari d’oggi): “un paese inquieto, bizzarro, sregolato, eccentrico”. La parte più commossa e turbata è quella del retablo per Dostoevskji che, a dire di Citati, forse “non era vanitoso, ma solo cosciente del proprio talento, in un ambiente che non lo comprendeva e non lo riconosceva”. I cinque paragrafi sullo scrittore russo sono, in pratica, una breve ma veridica biografia da pubblicare a sé come strenna.
Selezionando i classici, si potrebbe avere l’impressione che Citati abbia costruito un museo, ma non è così. In verità, una scelta talmente severa è un giudizio sull’attualità, un rimprovero; e, del resto, come metteva in guardia Segre: “Guai se la critica si occupasse solo della contemporaneità, lasciando il passato agli eruditi” (Critica e critici, 2012). E poi Citati non ne è per niente intimorito, anzi, il suo understatement, tipico di molti galantuomini siciliani, si scioglie in non pochi ragionamenti spassosissimi. Riedizione, dunque, di storie (storie di libri, beninteso) che a volte si accentrano sulla trama e le gesta dei personaggi; e altre, ben volentieri, si adunano attorno allo scrittore. Il critico-scrittore, insomma, non sa se essere con o contro Sainte-Beuve. A sorreggerlo nella scelta è l’opportunità e lo sguardo, anch’esso mutevole ed efficiente, capace di adattarsi alla situazione. E poi c’è, dicevo, lo stile. Il tono brioso del passo su Sterne si mette da parte quando è vantaggioso essere quieti o addirittura mesti, come con Virginia Woolf. L’amplissima eleganza, la puntualità del tecnico, la lussuria del pettegolezzo vengono sottolineate dall’uso malizioso, e a volte sibillino, dei due punti: quasi un sigillo come il circonflesso di Contini.
Il rischio di tanto talento, manco a dirlo, è quello dell’autoritratto; ma che ben venga. A me è rimasta l’immagine d’un uomo “cortese e ardito, ma sdegnoso e solitario e intento allo studio” (Dino Compagni su Cavalcanti nella Cronica). Un volto, si capisce, affatto libresco e demodé.
G. Cascio insegna letteratura italiana all’Università di Utrecht


