Nelle settimane che precedono Book Pride, la Fiera nazionale dell’editoria indipendente a Milano dal 15 al 17 marzo, la redazione dell’Indice online pubblicherà una breve serie di recensioni dei libri di cui si parlerà nei giorni della rassegna.
di Mariolina Bertini
Pierre Pachet
AUTOBIOGRAFIA DI MIO PADRE
pp. 192, € 16
trad. dal francese di Marco Lapenna, ed. orig. 1987
L’orma, Roma 2019
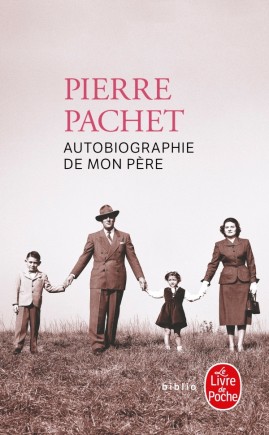 Pierre Pachet (1937-2016) è stato tra i più lucidi e rigorosi saggisti della cultura francese contemporanea. Docente di filosofia greca all’università, ha tradotto per Gallimard la Repubblica di Platone e ha pubblicato una ventina di volumi, approfondendo temi letterari (il pensiero politico di Baudelaire, le origini e lo sviluppo del journal intime , le opere di Naipaul e Rushdie), psicologici (il sonno, l’invecchiamento, il lutto) e storici (con particolare interesse per la storia dell’Europa orientale). Per una quarantina d’anni ha fatto parte della redazione della “Quinzaine littéraire” di Maurice Nadeau, pubblicandovi recensioni, cronache culturali e pagine autobiografiche di penetrante originalità. In questa Autobiographie de mon père ha scelto di raccontare, in prima persona, la vita di suo padre, Simkha Apatchevsky, ebreo della Russia meridionale nato nel 1895, emigrato in Francia nel 1913, morto nel 1965. È una vita apparentemente senza grandi tragedie, ad esclusione della lunga malattia che la conclude. Apatchevsky studia medicina a Bordeaux, diventa dentista, si sposa, ha due figli e riesce, nascondendosi in provincia con documenti falsi, a sfuggire alla deportazione, insieme ai suoi familiari. Tuttavia la superficie banale, fattuale di questa esistenza, meno terribile di tante altre, dissimula una sofferenza costante, che Pachet scandaglia, con delicatezza, sino in fondo. La forma originaria di questa sofferenza è la scomparsa della madre, che muore quando Simkha ha cinque anni; tutta la sua vita successiva ne porta il segno, il segno di quella stessa mancanza su cui è imperniato W o il ricordo d’infanzia di Georges Perec. Lo sradicamento dalla Russia e dalla tradizione ebraica, in qualche modo, allarga e rende irrimediabile la ferita di quella sofferenza prima. Tutto questo non è esposto in forma diretta da Pachet ma emerge da un racconto oggettivo e minuzioso; piccole difficoltà di ordine pratico, smarrimenti momentanei, disagi materiali, disturbi psicosomatici sono le tessere che compongono l’immagine di una sopravvivenza faticosa che trasforma Simkha (il cui nome dovrebbe significare “gioia”) in un individuo triste e introverso. Pessimista e conservatore, Simkha è ammirato da amici e familiari per la sua lucidità; questo rende più crudele il destino che segna gli ultimi anni della sua vita, quando un’oscura malattia, di cui i neurologi non riescono a comprendere nulla, lo priva prima della vista, poi della memoria e della padronanza dei movimenti. Ricostruendo la sua voce di malato, Pachet ci fa vivere dall’interno i suoi disorientamenti e le sue umiliazioni, con un’intensità quasi insostenibile.
Pierre Pachet (1937-2016) è stato tra i più lucidi e rigorosi saggisti della cultura francese contemporanea. Docente di filosofia greca all’università, ha tradotto per Gallimard la Repubblica di Platone e ha pubblicato una ventina di volumi, approfondendo temi letterari (il pensiero politico di Baudelaire, le origini e lo sviluppo del journal intime , le opere di Naipaul e Rushdie), psicologici (il sonno, l’invecchiamento, il lutto) e storici (con particolare interesse per la storia dell’Europa orientale). Per una quarantina d’anni ha fatto parte della redazione della “Quinzaine littéraire” di Maurice Nadeau, pubblicandovi recensioni, cronache culturali e pagine autobiografiche di penetrante originalità. In questa Autobiographie de mon père ha scelto di raccontare, in prima persona, la vita di suo padre, Simkha Apatchevsky, ebreo della Russia meridionale nato nel 1895, emigrato in Francia nel 1913, morto nel 1965. È una vita apparentemente senza grandi tragedie, ad esclusione della lunga malattia che la conclude. Apatchevsky studia medicina a Bordeaux, diventa dentista, si sposa, ha due figli e riesce, nascondendosi in provincia con documenti falsi, a sfuggire alla deportazione, insieme ai suoi familiari. Tuttavia la superficie banale, fattuale di questa esistenza, meno terribile di tante altre, dissimula una sofferenza costante, che Pachet scandaglia, con delicatezza, sino in fondo. La forma originaria di questa sofferenza è la scomparsa della madre, che muore quando Simkha ha cinque anni; tutta la sua vita successiva ne porta il segno, il segno di quella stessa mancanza su cui è imperniato W o il ricordo d’infanzia di Georges Perec. Lo sradicamento dalla Russia e dalla tradizione ebraica, in qualche modo, allarga e rende irrimediabile la ferita di quella sofferenza prima. Tutto questo non è esposto in forma diretta da Pachet ma emerge da un racconto oggettivo e minuzioso; piccole difficoltà di ordine pratico, smarrimenti momentanei, disagi materiali, disturbi psicosomatici sono le tessere che compongono l’immagine di una sopravvivenza faticosa che trasforma Simkha (il cui nome dovrebbe significare “gioia”) in un individuo triste e introverso. Pessimista e conservatore, Simkha è ammirato da amici e familiari per la sua lucidità; questo rende più crudele il destino che segna gli ultimi anni della sua vita, quando un’oscura malattia, di cui i neurologi non riescono a comprendere nulla, lo priva prima della vista, poi della memoria e della padronanza dei movimenti. Ricostruendo la sua voce di malato, Pachet ci fa vivere dall’interno i suoi disorientamenti e le sue umiliazioni, con un’intensità quasi insostenibile.
Questa Autobiografia di mio padre ha due grandi punti di forza. Il primo è la capacità analitica di Pachet che coglie ogni sfumatura delle sofferenze del padre, penetrando in modo stupefacente nell’interiorità di un uomo silenzioso, burbero e solitario, con cui per gran parte della vita ebbe rapporti non facili. Il secondo punto di forza è più specifico, ed è legato all’ebraismo di Simkha, che ha fatto i primi studi alla scuola ebraica di Odessa. I suoi ricordi e la sua cultura plurilingue intrecciano al filo della sua vita in Francia una materia più antica e suggeriscono intepretazioni singolari del suo stesso destino. Parlando della tipografie deformate di certe insegne moderne, che rendono difficile la lettura ai suoi occhi indeboliti, il vecchio Simkha ad esempio dice: “Se poi sono malato, deve essere il contraccolpo di una malattia anche più grave, che si è abbattuta sul mondo già venti anni fa. A proposito di tipografia deformata, come dimenticare i caratteri gotici riportati in auge da Hitler, quelle linee complicate e minacciose, e soprattutto un altro mostro della scrittura: le lettere JUDE ricamate o disegnate sulle stelle gialle, lettere di per sé gotiche ma le cui odiose contorsioni, inautenticamente medievali, cercavano di ricordare le forme tradizionali delle nostre lettere ebraiche. Il matrimonio che il nazismo ha quasi suggellato tra la nostra rovina e a propria ascesa si riassumeva tutto in quei caratteri ambigui: da una parte evocavano nei popoli sottomessi un salutare terrore della barbarie germanica (…); dall’altro, designando una vittima precisa, già intrappolata in quelle lettere che si contorcevano come tra le fiamme rassicuravano gli ariani promettendo loro pace e protezione; starete fuori dal gioco esaltante del barbaro e dell’indegno, né vittime né carnefici, solo spettatori terrorizzati”. Senza essere stato il protagonista di eventi eccezionali, Simkha è in queste pagine il testimone di un destino esemplare all’insegna dell’esilio, dell’incompiutezza e del fallimento; la voce che suo figlio gli restituisce racconta una storia che merita di essere ascoltata.


