Anche gli storici sono esseri emotivi
recensione di Francesco Cassata
dal numero di novembre 2018
Jan Plamper
STORIA DELLE EMOZIONI
ed. orig. 2012, trad. dal tedesco di Simona Leonardi
pp. 532, € 30
il Mulino, Bologna 2018
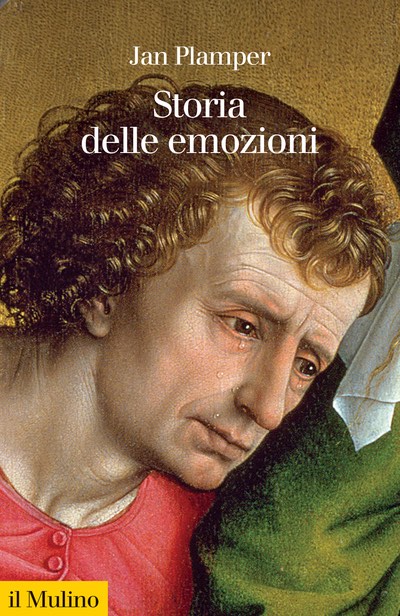 Nella Virginia del diciottesimo secolo, un ricco proprietario di schiavi di nome William Byrd perse un figlio. Byrd registrò l’evento nel suo diario senza alcuna espressione di dolore. Nel 1979, lo storico Michael Zuckerman studiò questo documento e concluse, sulle orme di Philippe Ariès, che nell’età moderna i genitori non provavano nei confronti dei figli un amore paragonabile al nostro. Quasi dieci anni dopo, nel 1987, un altro storico, Kenneth A. Lockridge, rilesse lo stesso caso e notò che, negli stessi giorni della morte del figlio, Byrd era stato colpito da insopportabili dolori allo stomaco. Pur non avendo espresso la sua sofferenza nel diario, Byrd l’aveva somatizzata. Alcuni anni fa, Nicole Eustace, autrice di Passion Is the Gale: Emotion, Power, and the Coming of the American Revolution (2008) è ritornata su questa vicenda, aggiungendo un’osservazione importante: la moglie di William Byrd, Lucy, aveva pianto moltissimo per la scomparsa del figlio e, nel suo diario, il marito aveva descritto in dettaglio gli sforzi da lui compiuti per indurla a controllare le sue emozioni.
Nella Virginia del diciottesimo secolo, un ricco proprietario di schiavi di nome William Byrd perse un figlio. Byrd registrò l’evento nel suo diario senza alcuna espressione di dolore. Nel 1979, lo storico Michael Zuckerman studiò questo documento e concluse, sulle orme di Philippe Ariès, che nell’età moderna i genitori non provavano nei confronti dei figli un amore paragonabile al nostro. Quasi dieci anni dopo, nel 1987, un altro storico, Kenneth A. Lockridge, rilesse lo stesso caso e notò che, negli stessi giorni della morte del figlio, Byrd era stato colpito da insopportabili dolori allo stomaco. Pur non avendo espresso la sua sofferenza nel diario, Byrd l’aveva somatizzata. Alcuni anni fa, Nicole Eustace, autrice di Passion Is the Gale: Emotion, Power, and the Coming of the American Revolution (2008) è ritornata su questa vicenda, aggiungendo un’osservazione importante: la moglie di William Byrd, Lucy, aveva pianto moltissimo per la scomparsa del figlio e, nel suo diario, il marito aveva descritto in dettaglio gli sforzi da lui compiuti per indurla a controllare le sue emozioni.
Questo esempio non è riportato nel corposo volume di Jan Plamper, pubblicato in tedesco nel 2012 e tradotto ora dal Mulino. Esso tuttavia può esserci utile per cogliere uno dei problemi cruciali della storia delle emozioni, al centro dell’analisi di Plamper: quello del rapporto tra “esperienza” ed “espressione”. Come storici, non sapremo mai cosa provasse realmente William Byrd. Probabilmente nemmeno lui, come abbiamo visto, ne era del tutto consapevole. Eppure, la ricostruzione filologica dei percorsi di espressione e di regolazione delle emozioni ci può fornire indicazioni molto utili sul versante dell’organizzazione sociale e del controllo politico.
A partire da questo rapporto tra linguaggio ed esperienza, un primo punto su cui si sofferma il saggio di Plamper è indubbiamente il ruolo della storia delle emozioni nel decostruire quella visione essenzialista e universalizzante che dalle celebri “grandi narrazioni” di Johan Huizinga e Norbert Elias giunge fino alla recente neurostoria di Daniel Lord Smail. La sintesi di antropologia e di psicologia cognitiva nella teoria storica degli “emotives” e dei “regimi emotivi” di William Reddy (in particolare con il suo The Navigation of Feeling, del 2001); la critica del modello “idraulico” delle emozioni – la visione freudiana delle emozioni come processi fluidi all’interno del corpo – condotta da Barbara Rosenwein e la sua concettualizzazione, in Emotional Communities in the Early Middle Ages (2006), delle “comunità emotive”, ovvero comunità sociali definite da precisi e condivisi sistemi di emozioni; la bourdieiana analisi delle “pratiche emotive” di Monique Scheer in Are Emotions a Kind of Practice? (2012), non limitata ai soli atti linguistici verbali, ma estesa a tutte le tracce fisiche e materiali delle emozioni: sono questi, per Plamper, i maggiori risultati metodologici di un emotional turn – come alcuni già lo etichettano – che negli ultimi anni ha profondamente trasformato il modo di fare storia sociale, politica, culturale. Ai lavori di Reddy, Rosenwein, Scheer vanno poi aggiunte le acquisizioni della storia della scienza, il settore che forse più di ogni altro, nel campo dello studio delle emozioni, ha contribuito a mettere in discussione il mito della razionalità moderna à la Elias: i lavori di Lorraine Daston sulle “meraviglie del mondo”; di Jessica Riskin sull’“empirismo sentimentale” dell’Illuminismo; di Deborah Coen sull’impatto delle relazioni affettive familiari nella razionalità moderna della Vienna ottocentesca; di Otniel E. Dror sulla “scienza delle emozioni” tra il 1850 e il 1940 – a partire proprio dagli studi sulla paura del nostro Angelo Mosso – sono soltanto alcuni tra i molti, affascinanti esempi possibili.
La critica nei confronti dell’essenzialismo deterministico e universalizzante non conduce tuttavia Plamper ad affermare la validità di un sociocostruttivismo radicale o a negare l’apporto fondamentale delle neuroscienze per la storia delle emozioni. L’autore critica giustamente tanto la deriva divulgativa e banalizzante dei lavori di LeDoux, Damasio e Rizzolatti (per citare soltanto i più celebri) quanto l’ingenuità delle scienze sociali – la neuroestetica e la neuropolitologia, innanzitutto – nell’incorporare presunti modelli del funzionamento del cervello e della mente senza avere in realtà alcuna competenza specifica in materia e senza disporre di alcuna conoscenza effettiva del pluralismo e della complessità delle ricerche in corso.
Proprio da un confronto serio e approfondito con le neuroscienze potrebbero per contro emergere, secondo Plamper, feconde possibilità di dialogo e interconnessione. Il superamento del paradigma della specificazione funzionale a favore di una concezione integrata del cervello promette, ad esempio, di ridurre la distanza dicotomica tra “cognizione” ed “emozione”, fornendo così possibili suggerimenti al campo delle scienze storiche, per quanto riguarda l’analisi delle scelte politico-ideologiche. Allo stesso modo, la neuroplasticità apre nuove prospettive alle scienze umane e alla storia: se la vita lascia costantemente le sue impronte nel cervello, quest’ultimo, lungi dall’essere un luogo immutabile, si storicizza, diviene oggetto di variabilità storica. Infine, la diffusione delle neuroscienze sociali e degli studi sull’empatia sembra anch’essa condurre a intersezioni epistemologiche rilevanti con le scienze umane, ad esempio nello studio del blocco dell’empatia in soggetti razzisti o nell’analisi della co-occorrenza di diversi sistemi motivazionali.
Nel suo inesausto sforzo di liberare lo storico dal lettino dell’analista – per usare la metafora di Plamper – che lo costringe ad oscillare tra nature e nurture, tra universalismo essenzializzante e relativismo sociocostruttivista, l’autore dedica l’ultima parte del libro a esporre concrete prospettive di sviluppo della storia delle emozioni, non come un genere a sé stante, ma come una nuova lente metodologica da applicare a una pluralità di sottodiscipline: dalla storia politica e dei movimenti sociali alla storia economica; dalla storia del lavoro a quella del consumo; dalla storia dei media e della propaganda alla storia orale e ai suoi rapporti con la memoria. In quest’ottica, gli storici stessi potrebbero un giorno finalmente scoprirsi come essere emotivi. Negli scritti autobiografici di Raul Hilberg, l’autore de Lo sterminio degli ebrei di Europa (1961), si legge, ad esempio, tutta la tensione presente dietro la volontà di nascondere le proprie emozioni, sommergendole sotto una mole di carte topografiche e di numeri, e mantenendo un tono il più possibile distaccato e freddo. Per superare questo dissidio emotivo interiore, Hilberg si rifugiò nella musica, ascoltando l’Appassionata di Beethoven: “Mi fece capire che non potevo urlare per mille pagine, che dovevo attutire il volume e l’eco e dovevo allentare la tensione solo sistematicamente, anzi molto sistematicamente”.
In una prospettiva che, da Ranke in poi, ha fatto dell’oggettività e della soppressione delle passioni la condizione per la scientificità della disciplina storica, l’autoriflessione emotiva degli storici non ha certo avuto molta fortuna. Ma in fondo ha ragione Plamper: perché gli storici non dovrebbero tenere una sorta di diario di lavoro sulle emozioni – il tedio, l’entusiasmo, la rabbia – da loro provate durante le ricerche di archivio?
francesco.cassata@unige.it
F Cassata insegna storia contemporanea all’Università di Genova


