Trittico di infelicità
recensione di Daniele Santero
dal numero di marzo 2015
Domenico Starnone
LACCI
pp. 138, €17.50
Einaudi, Torino 2014
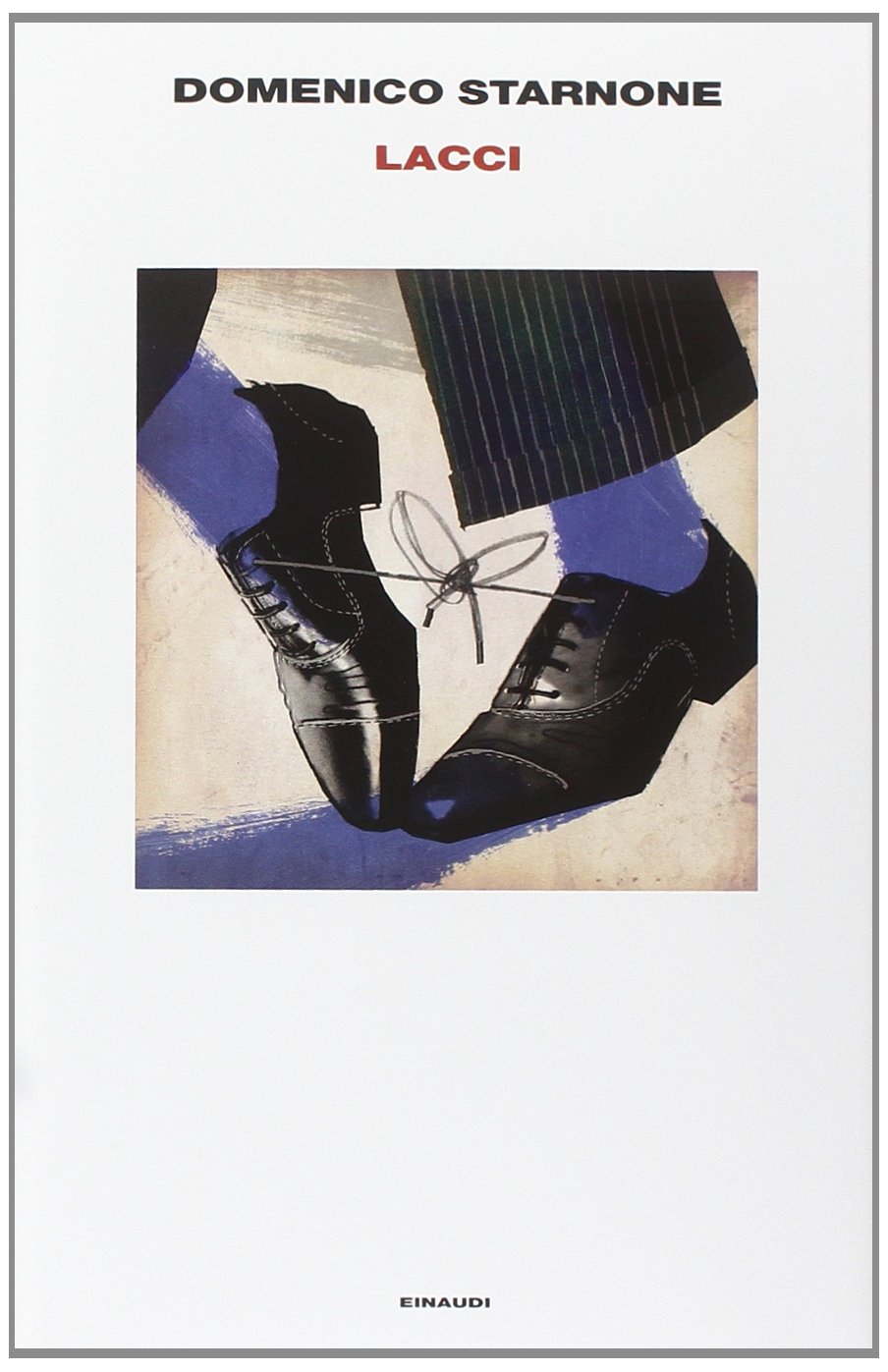 Il matrimonio è un luogo tranquillo, finché sventuratamente finisce di esserlo. Ora, data l’unione in un’età consona e profetizzando un decesso non così prematuro di uno dei due, lo si attraversa, amore e fedeltà del coniuge permettendo, da un capo all’altro in una cinquantina d’anni. E avanza ancora il tempo per prendere casa e dare alla luce un paio di bambini. Si può fare, quindi: e se hai capito come vanno le cose, hai cessato da un pezzo di confidare nella buona sorte e hai messo su un certo fatalismo.
Il matrimonio è un luogo tranquillo, finché sventuratamente finisce di esserlo. Ora, data l’unione in un’età consona e profetizzando un decesso non così prematuro di uno dei due, lo si attraversa, amore e fedeltà del coniuge permettendo, da un capo all’altro in una cinquantina d’anni. E avanza ancora il tempo per prendere casa e dare alla luce un paio di bambini. Si può fare, quindi: e se hai capito come vanno le cose, hai cessato da un pezzo di confidare nella buona sorte e hai messo su un certo fatalismo.
Ritorno alla coppia
Il romanzo di Starnone è la vivisezione anatomica, e perciò terribile (perché i corpi sono ancora ben vivi e quindi dolenti se incisi con bisturi e infedeltà) del sentimento amoroso quando questo va in bambola e decapita la coppia. Starnone racconta ciò che succede quando due individui che si sono uniti per una magheria sentimentale, riconosciuta in ambito sociale attraverso il rito matrimoniale, si sono a un tratto lasciati per l’infedeltà coniugale di uno dei due e alla fine, troppi anni dopo perché in mezzo a loro non sia venuto giù un crepaccio abissale, tornano a vivere insieme. Aldo e Vanda ventenni si sposano e hanno due figli, si lasciano per l’amore fedifrago di lui e, vecchi, tornano a condividere la vita. Per un trittico d’infelicità: giovane, adulta e pressoché postuma.
Brusco e imprevisto, maledetto da entrambi o più spesso solo da uno dei due, messo in conto e atteso, supplicato persino, il termine “abbandono” deriva dal francese medioevale à ban donner, e significa mettere a disposizione di chicchessia, lasciare ad altri che non siamo noi. Nella storia di Aldo e Vanda chicchessia si chiama Lidia. L’autore segue il distacco tra i due protagonisti centimetro a centimetro e, una volta inscenata la separazione la divarica, fino a giungere a una distanza di fronte alla quale sbiadisce quella tra Napoli, casa della famiglia, e Roma, dove c’è l’appartamento di Lidia. La letteratura del resto spesso si libra dallo scorporo, fermenta nell’incavo della divisione, quasi tutto è un’assenza che inizia, si protrae e mai si risolve anzi si aggrava: così è anche in Lacci, in cui sono la privazione, la distanza tra i corpi e non la loro coincidenza, la perdita commutata o subita, a consegnare lo spazio adeguato perché l’autore si insedi e ne resoconti i sedimenti, tramandi i lasciti, accarezzi i residui e vi si infavoli dentro. Vanda con le sue lettere micidiali reclama un possesso che è oramai solo precedente, una fonte che riteneva inesauribile e invece non lo è mai.
Rivuole suo marito, esige la risoluzione, che Aldo torni da lei e dai bambini. Ma lui ha questa gioia continua che è Lidia. Come in altri lavori precedenti, su tutti Labilità (Feltrinelli, 2005) e Prima esecuzione (Feltrinelli, 2007), anche in questo romanzo Starnone nebulizza per l’arco dell’intera vicenda una paura irrisolvibile. Fa paura la vita coniugale di Aldo e Vanda perché è la culla ctonia dell’amore: è stata allestita e poi, decenni dopo riallestita, con l’intento esatto di non dar modo a questo di trovarvi residenza. Fa paura vederla rompersi e invecchiare. Fa paura che i figli non contino nulla se non al momento del ricatto del coniuge lasciato o del senso di colpa dell’altro. E fanno paura questi stessi figli per il modo imprevisto in cui reagiscono alla tristezza che, allora bambini, subirono inermi.


