Una scrittura rigata di lacrime
recensione di Giovanni Tesio
Dal numero di gennaio 2014
Anna Banti
ROMANZI E RACCONTI
a cura di Fausta Garavini e Laura Desideri
pp. CLXIX-1794, € 65
Mondadori, Milano 2013
 “Ma io dipingo”. Eccolo il senso di tutta una vita che va incontro alla sua unica e possibile salvezza. Un senso piantato come una spina nella carne viva di Artemisia, il romanzo forse più emblematico di Anna Banti, che, non diversamente dalla sua creatura più sofferta e più viva, “entra in scrittura per combattere a colpi di penna un intimo malessere”, come sottolinea Fausta Garavini, “la esaltata Faustina” o anche “l’eccitata Faustina” del viaggio a Lisbona di Un grido lacerante. La cui bellissima introduzione e la ricca cronologia (accompagnate dalle note ai testi e dalla bibliografia dell’ottima Laura Desideri) corredano il “Meridiano” debitamente e finalmente riservato a Banti nel pur ineguale pantheon di Mondadori.
“Ma io dipingo”. Eccolo il senso di tutta una vita che va incontro alla sua unica e possibile salvezza. Un senso piantato come una spina nella carne viva di Artemisia, il romanzo forse più emblematico di Anna Banti, che, non diversamente dalla sua creatura più sofferta e più viva, “entra in scrittura per combattere a colpi di penna un intimo malessere”, come sottolinea Fausta Garavini, “la esaltata Faustina” o anche “l’eccitata Faustina” del viaggio a Lisbona di Un grido lacerante. La cui bellissima introduzione e la ricca cronologia (accompagnate dalle note ai testi e dalla bibliografia dell’ottima Laura Desideri) corredano il “Meridiano” debitamente e finalmente riservato a Banti nel pur ineguale pantheon di Mondadori.
Studiosa d’arte, moglie e compagna di Roberto Longhi, scrittrice per accidente (e forse, come osserva lei stessa, per “orgoglio” ma non certo per ripiego), autrice di alcuni libri memorabili, che la pongono tra le scrittrici più notevoli del Novecento, animatrice di un’ancipite e prestigiosa rivista come “Paragone”, critica letteraria (da Manzoni a Virginia Woolf), saggista, cinéphile, interprete profonda del mondo femminile, Anna Banti (nom de plume di Lucia Maria Pergentina Lopresti) ha giocato tra maschera e volto l’intero percorso di una personalità contraddittoria e complessa, che non bastano gli studiosi e intelligenti aggettivi di Garavini a catturare. Una personalità, insomma, costantemente unica e plurima, assetata di “verità”, costantemente tesa a rincorrere la domanda (“chi sono io?”) che tante volte nell’opera rintocca nel gioco degli specchi (ustori) delle figure traslate, delle donne inseguite prima ancora dentro che fuori di sé.
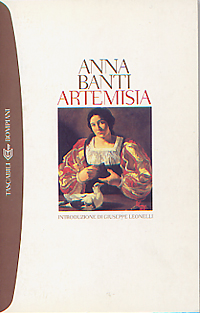 Nella falsa identità di autobiografia e scrittura (giocata su quel tracciato così sottilmente dialogico che sta tra la terza persona nell’Itinerario di Paolina e gli sdoppiamenti di prima e terza persona in Artemisia fino alla più confessionale ma non meno mascherata terza persona di Un grido lacerante) si affaccia tuttavia una questione che Garavini scioglie da ogni facile equivoco e da ogni indebito consumo, attraversando una terra accidentata e incondita, in cui nessuna tessera documentale riesce da sola a reggersi per intero. Ed è così che può approdare alla sua affermazione estrema: ossia che “la ‘vera’ autobiografia è nella fiction”, del resto stranamente prossima ai regimi di quell’autofiction su cui – lignée Sollers-Forest – si è dibattuto in Francia come (e lo dico palazzeschianamente) di una vera e propria nouveauté.
Nella falsa identità di autobiografia e scrittura (giocata su quel tracciato così sottilmente dialogico che sta tra la terza persona nell’Itinerario di Paolina e gli sdoppiamenti di prima e terza persona in Artemisia fino alla più confessionale ma non meno mascherata terza persona di Un grido lacerante) si affaccia tuttavia una questione che Garavini scioglie da ogni facile equivoco e da ogni indebito consumo, attraversando una terra accidentata e incondita, in cui nessuna tessera documentale riesce da sola a reggersi per intero. Ed è così che può approdare alla sua affermazione estrema: ossia che “la ‘vera’ autobiografia è nella fiction”, del resto stranamente prossima ai regimi di quell’autofiction su cui – lignée Sollers-Forest – si è dibattuto in Francia come (e lo dico palazzeschianamente) di una vera e propria nouveauté.
Il risultato che ne viene (ma anche la premessa su cui poggia) si concilia di fatto con la metamorfica natura di una personalità in sé tanto mobile e inquieta quanto per sé aliena da ogni cedimento sentimentalistico, pur potendosi per essa convocare le “lagrime difficili” della stessa Artemisia nel cuore del suo passaggio fiorentino. L’Artemisia che ben sa – come ben sa Banti – Di che lacrime (questo il felice titolo dell’introduzione che è frutto di un intervento che già apparve su “Paragone”) grondi l’umana esistenza della condizione femminile: una condizione costantemente interrogata ma mai risolta nei facili riduzionismi delle etichettature femministe (essendo la parola “femminismo” per Banti detestabile). Tanto da giungere (ancora in Un grido lacerante) alla più precisa delle “confessioni”: “Aveva amato pochi uomini, anzi un uomo solo, ma pochissime donne, e quelle poche, riunite in una favola, sempre la stessa: il mito dell’eccezione contro la norma del conformismo”.
A volere trarre da quest’opera un effetto di non cercata attualità, sono più d’una le situazioni che riguardano la violenza sulle donne, la paura da cui nascono i delitti (quelli che oggi si chiamano, con parola oscena, “femminicidi”). Per tutti, quell’orroroso cammeo che sta piantato nell’officina di Artemisia: “Allo scherno succedevano racconti di sevizie segrete e leggendarie con fantasmi di mogli claustrate, avvelenate, fatte sparire senza lasciar traccia, fantasmi che parevano mescolarsi al gruppo delle viventi e insinuarvi uno stimolo di vendetta che eccitava le nari insieme all’odor della trementina”.
Di quante e quali lacrime sia costellata, torno a dire, la narrativa di Banti lo vede bene chi ne ripassi l’opera intera, perlomeno l’opera che conta. Con variatio davvero notevole, sono le mai lacrimevoli lacrime (o anche il pianto “senza lacrime”, come nell’incipit di Un grido lacerante) a caratterizzare la complicata trama dei conflitti, ove solo se ne tengano presenti gli esiti più alti, da Artemisia a Un grido (ma molto anche nei tanti racconti). E per Artemisia basterebbe quest’altro incipit, reiterato (“Non piangere”) che l’io narrante rivolge a quel sé rimemorato di “donna accoccolata in singhiozzi”.
 Ma allora un altro punto, compresente al precedente, merita sottolineare: come attraverso le tante figure di donna, anche il mondo maschile si disegni con tutt’altro che monotono pregiudizio. Il mondo di Banti si gioca anche in quest’altro dialogo sghembo e imperfetto, in cui l’uomo non è poi tanto o soltanto il “fatale nemico”, ma piuttosto il frutto di un resistente e consistente mistero (e a me continua a sembrare emblematico, oscuramente complice, il rapporto che Artemisia ha con il marito Antonio Stiattesi, un uomo così amorosamente amato e così fuggitivamente presente; o con la figura del padre, sempre così inseguito e mai veramente conseguito). E qui, a proposito di Antonio, solo una citazione molto più che sintomatica: “Antonio dormiva da innocente e un uomo innocente è una gran cosa”.
Ma allora un altro punto, compresente al precedente, merita sottolineare: come attraverso le tante figure di donna, anche il mondo maschile si disegni con tutt’altro che monotono pregiudizio. Il mondo di Banti si gioca anche in quest’altro dialogo sghembo e imperfetto, in cui l’uomo non è poi tanto o soltanto il “fatale nemico”, ma piuttosto il frutto di un resistente e consistente mistero (e a me continua a sembrare emblematico, oscuramente complice, il rapporto che Artemisia ha con il marito Antonio Stiattesi, un uomo così amorosamente amato e così fuggitivamente presente; o con la figura del padre, sempre così inseguito e mai veramente conseguito). E qui, a proposito di Antonio, solo una citazione molto più che sintomatica: “Antonio dormiva da innocente e un uomo innocente è una gran cosa”.
Dopodiché a valere sono le tante facce di una scrittura (di uno “stile”) che è “costruzione” e che nulla concede alla facilità della lettura, aprendo varchi continui nei doppi fondi di coscienze offese o semplicemente dibattute, di condizioni conflittuali, di trapassi desultori, di inafferrabili malesseri, di complicate giunture. Inganni psicologistici? Solariani o bonsantiani? Direi di no, nemmeno nel principio, perché l’opera di Banti (a parte l’improponibilità del termine “intimismo”) si presenta, pur nelle sue discontinuità strutturali e stilistiche, come un’opera notevolmente compatta. In cui mi pare di dover segnalare l’importanza degli oggetti, la presenza degli elenchi, la puntualità delle cose che riflettono attraverso la loro consistenza la sottigliezza delle più fuggevoli sensazioni interiori: sempre i détours sono riscattati o bilanciati da una concretezza attenta ai dettagli e alle minime mutazioni emotive: climatologia psicologico-morale.
Con il che saremmo al punto forse più forte dell’intero itinerario: la tutta evidente visività di una narrativa come quella di Banti: un narrare per immagini che è di tipo addirittura cinematografico (nessuno stupore se solo si pensa alla quantità di recensioni dei tanti film amati e non). Quadri e fotogrammi pieni di oggetti che sicollocano in uno spazio allusivamente simbolico di precisione ambientale e, direi, atmosferica, che aprono parentele singolari con altre scritture (con la scrittura di Lalla Romano, ad esempio: sia per la presenza genetica di Proust, sia per la calda austerità del tratto, sia per la seconda vocazione; sia, infine, per la forza visiva delle immagini, che, come per Banti in Artemisia, “dalla memoria traggono un impercettibile alimento”). Da quale mai “pays lointain” ci arriva, dunque, questa voce animata da tanto pathos della distanza? Se, come appare all’inizio della Camicia bruciata, la storia “è avvezza a inventare e talvolta inventando scopre la verità”, questo tanto più vale per la letteratura. A cui Anna Banti tributa la più fervida e a un tempo la più distaccata delle testimonianze.
G. Tesio insegna letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale


