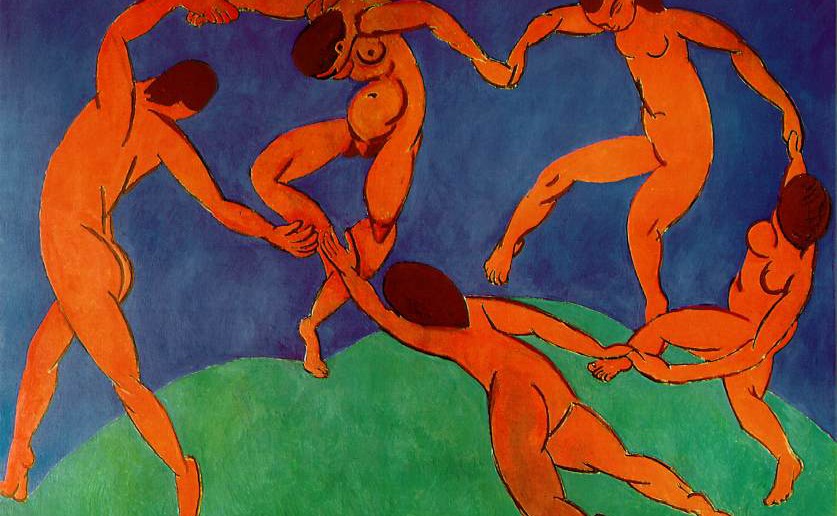Siamo tutti profughi della nostra infanzia
di Esterino Adami
dal numero di gennaio 2014
In un’epoca globalizzata e ricca di contraddizioni come la nostra, anche le lingue e le storie sono spesso in movimento, in fluttuazioni diasporiche fra i vari Nord e Sud del mondo. Ed è questo il caso di molti autori caratterizzati da quella cosiddetta matrice postcoloniale, la quale è spesso cifra di rappresentazioni identitarie profonde. Leggere di autori provenienti da paesi africani o asiatici, quindi, non vuol dire “consumare” una qualche forma di orientalismo moderno, ma implica un estendere il proprio sguardo e la propria riflessione sul mondo e sul significato della mobilità. Alcuni titoli apparsi recentemente possono inserirsi in questo tipo di riflessione e offrire interessanti esempi di come autori e testi siano in grado di rappresentare temi densi e forti, dai rapporti fra Occidente e Oriente alla visione politica ed economica che contrappone individui e comunità, al senso intimo delle proprie radici culturali, e i pericoli di sradicamento.
 In questo quadro di grandi forze culturali si colloca il romanzo di Taiye Selasi La bellezza delle cose fragili. Un breve accenno biografico sull’autrice è necessario al fine di comprendere le interconnessioni fra esperienza e scrittura: nata a Londra da padre ghanese e madre nigeriana, Selasi ha vissuto a Boston, New York, New Delhi, ha studiato a Yale e Oxford e infine si è stabilita a Roma. Una vita ricca di eventi, di incontri, di esperienze, sempre mossa da grande curiosità intellettuale. Il romanzo, che oscilla nervosamente fra Ghana, Stati Uniti, Nigeria e si sposta fra molti livelli temporali in una serie di flashback costanti fra passato e presente, non rappresenta tanto un “classico”, per così dire, romanzo di contesto diasporico africano, ma piuttosto una costante esplorazione del senso dei rapporti interni a una famiglia estesa (fotografata anche attraverso un albero genealogico all’inizio del testo), le cui ramificazioni, incompatibilità e tensioni sono dipinte in maniera sottile e penetrante.
In questo quadro di grandi forze culturali si colloca il romanzo di Taiye Selasi La bellezza delle cose fragili. Un breve accenno biografico sull’autrice è necessario al fine di comprendere le interconnessioni fra esperienza e scrittura: nata a Londra da padre ghanese e madre nigeriana, Selasi ha vissuto a Boston, New York, New Delhi, ha studiato a Yale e Oxford e infine si è stabilita a Roma. Una vita ricca di eventi, di incontri, di esperienze, sempre mossa da grande curiosità intellettuale. Il romanzo, che oscilla nervosamente fra Ghana, Stati Uniti, Nigeria e si sposta fra molti livelli temporali in una serie di flashback costanti fra passato e presente, non rappresenta tanto un “classico”, per così dire, romanzo di contesto diasporico africano, ma piuttosto una costante esplorazione del senso dei rapporti interni a una famiglia estesa (fotografata anche attraverso un albero genealogico all’inizio del testo), le cui ramificazioni, incompatibilità e tensioni sono dipinte in maniera sottile e penetrante.
La struttura frammentaria elaborata dall’autrice talvolta eccede, forse per fini di digressione narrativa, e la qualità della scrittura pare ricercare forme auliche e un po’ troppo artificiose, o a effetto. Tuttavia occorre riconoscere che la voce dei personaggi femminili è ben delineata e toccante nello svelare ferite, episodi, sentimenti: “Donne che sognavano. Donne pericolosissime. Donne che guardavano il mondo attraverso i loro grandi occhi di sognatrici e lo vedevano non per quello che era, un posto ‘brutale, senza senso’ eccetera eccetera; peggio: lo vedevano per come poteva essere, per come sarebbe potuto diventare”. Nel suo insieme, la storia si muove sui percorsi della migrazione, in senso esteso, cioè sia all’interno del continente africano, ad esempio quando Taiwo e Kehinde si trasferiscono a Lagos, sia nel contesto occidentale, quando vediamo i figli di Kweko e Fola partecipare al “grande sogno” americano, studiare medicina presso college rinomati, sposare una donna di origine cinese-americana, diventare artisti alternativi a Brooklyn.
 Parlare di Africa vuol dire anche esplorare altri sentieri e tradizioni, come dimostra lo scrittore keniota Binyavanga Wainaina con Un giorno scriverò di questo posto, originariamente pubblicato nel 2011. Mémoire di formazione, autobiografia romanzata, evocazione di ricordi e immagini, il testo segue la vita dell’autore dall’indipendenza del paese con Kenyatta alla brutalità del regime nell’Uganda di Amin, al “nuovo” Sudafrica post-apartheid quale crogiolo di migrazioni interne del continente africano e nuove formazioni culturali. Il protagonista, il cui desiderio di scandagliare il potere delle parola (e del multilinguismo tipico dell’Africa) e diventare scrittore è motore dell’intero testo, racconta della sua vita e delle sue esperienze, nonché del suo sguardo verso l’ambiente circostante, nei suoi giorni presso la scuola Mang’u (un tempo Kabaa High School), nelle sue visite a Nairobi, città dai tanti contrasti, nei suoi anni passati a studiare infruttuosamente a Cape Town, nella speranza di afferrare significati e valori (“Che cosa meravigliosa, mi dico, se potessi passare la vita ad abitare le forme, i suoni e le abitudini degli altri”).
Parlare di Africa vuol dire anche esplorare altri sentieri e tradizioni, come dimostra lo scrittore keniota Binyavanga Wainaina con Un giorno scriverò di questo posto, originariamente pubblicato nel 2011. Mémoire di formazione, autobiografia romanzata, evocazione di ricordi e immagini, il testo segue la vita dell’autore dall’indipendenza del paese con Kenyatta alla brutalità del regime nell’Uganda di Amin, al “nuovo” Sudafrica post-apartheid quale crogiolo di migrazioni interne del continente africano e nuove formazioni culturali. Il protagonista, il cui desiderio di scandagliare il potere delle parola (e del multilinguismo tipico dell’Africa) e diventare scrittore è motore dell’intero testo, racconta della sua vita e delle sue esperienze, nonché del suo sguardo verso l’ambiente circostante, nei suoi giorni presso la scuola Mang’u (un tempo Kabaa High School), nelle sue visite a Nairobi, città dai tanti contrasti, nei suoi anni passati a studiare infruttuosamente a Cape Town, nella speranza di afferrare significati e valori (“Che cosa meravigliosa, mi dico, se potessi passare la vita ad abitare le forme, i suoni e le abitudini degli altri”).
La dimensione migratoria e multilinguistica del testo è resa anche attraverso le connotazioni onomastiche che identificano il protagonista, il cui nome suggerisce origini etniche (“Per noi kikuyu il nome è una specie di destino”). Non si tratta di un mero dettaglio narrativo, ma piuttosto di un espediente per attivare una serie di riferimenti agli intricati rapporti sociali e tribali che legano e oppongono diverse realtà dell’Africa postcoloniale, spaziando dal Ghana alla Nigeria, evocando anche una nuova vivacità culturale e letteraria, che il protagonista stesso incarna e alimenta, mentre la sua passione per la lettura lo porta poi a cimentarsi con la scrittura.

Taiye Selasi
A tal proposito, se consideriamo l’attuale panorama culturale e letterario di molti paesi africani, è interessante confrontare le interpretazioni di taglio alquanto diverso, riconducibili anche a quanto Taiye Selasi e Binyavanga Wainaina hanno affermato in diverse interviste e discussioni: il termine chiave è “afropolita” (peraltro utilizzato da Selasi per un suo saggio nel 2005), quale categoria di riferimento per una serie di artisti e scrittori africani, spesso espatriati, come per esempio Derrick Ashong o Teju Cole. I nostri due autori hanno però opinioni quasi antitetiche: se da un lato, infatti, Selasi loda l’ibridismo interculturale di quegli intellettuali africani che si inseriscono nella scena occidentale da Londra a New York, spesso sovvertendo stilemi e tendenze nei vari campi artistici, dall’altro Wainaina teme i confini marcati delle definizioni e ritiene che la categoria sia in realtà da leggersi come un fenomeno di moda passeggera, un’astuta posa estetica, un po’ elitaria e commerciale, ben lontana dal vero dinamismo che percorre le città africane. Wainaina aderisce piuttosto a una concezione di panafricanismo, cioè un legame più intenso con la propria terra d’origine e una condivisione di ideali (“È così che si diventa africani”). Sul piano tematico, i due libri riflettono visioni contrapposte: con la scrittura Selasi cesella una celebrazione del multiculturalismo “globale” (soprattutto lungo traiettorie angloamericane) in cui l’identità africana viene modulata e ricomposta, mentre al contrario Un giorno scriverò di questo posto si nutre delle diversità culturali dell’Africa postcoloniale, che cerca di superare contraddizioni, conflitti e tensioni per guardare al futuro. Il dibattito è sicuramente ampio e sfaccettato, e destinato a generare reazioni e risposte.
Letteratura postcoloniale in Asia
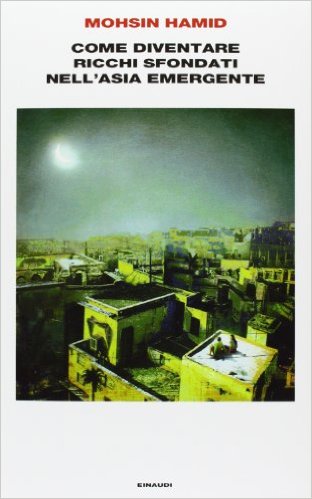 Una possibile sintesi, o almeno mediazione, fra queste due posizioni così marcate può forse arrivare dalle letterature postcoloniali del fronte asiatico, con l’originale Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente di Mohsin Hamid, in cui l’Oriente tradizionale e l’Occidente moderno si combinano e contaminano vicendevolmente. Il romanzo dipinge l’ascesa e caduta di un personaggio privo di nome in una non specificata metropoli (probabilmente nel subcontinente indiano) quale parabola non solo dello spostamento e della ridefinizione di nuovi scenari geopolitici, ma anche come percorso interiore in una dimensione più intima. A livello narrativo, il romanzo è concepito come un manuale di autoaiuto, con un indefinito “tu” soggetto che si muove dalle ristrettezze del villaggio natio alla tentacolare città che è simbolo di crescita e sviluppo, nonché miraggio di ricchezza e possibilità: “Trasferirsi in città è il primo passo per diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente. E adesso l’hai compiuto. Congratulazioni”. Tuttavia, Hamid non è semplicemente interessato a svelare gli aspetti più problematici dell’urbanizzazione e della crescita incontrollata di certi contesti asiatici, quanto piuttosto al microcosmo sociale e culturale che anima tali spazi e muove i destini degli individui.
Una possibile sintesi, o almeno mediazione, fra queste due posizioni così marcate può forse arrivare dalle letterature postcoloniali del fronte asiatico, con l’originale Come diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente di Mohsin Hamid, in cui l’Oriente tradizionale e l’Occidente moderno si combinano e contaminano vicendevolmente. Il romanzo dipinge l’ascesa e caduta di un personaggio privo di nome in una non specificata metropoli (probabilmente nel subcontinente indiano) quale parabola non solo dello spostamento e della ridefinizione di nuovi scenari geopolitici, ma anche come percorso interiore in una dimensione più intima. A livello narrativo, il romanzo è concepito come un manuale di autoaiuto, con un indefinito “tu” soggetto che si muove dalle ristrettezze del villaggio natio alla tentacolare città che è simbolo di crescita e sviluppo, nonché miraggio di ricchezza e possibilità: “Trasferirsi in città è il primo passo per diventare ricchi sfondati nell’Asia emergente. E adesso l’hai compiuto. Congratulazioni”. Tuttavia, Hamid non è semplicemente interessato a svelare gli aspetti più problematici dell’urbanizzazione e della crescita incontrollata di certi contesti asiatici, quanto piuttosto al microcosmo sociale e culturale che anima tali spazi e muove i destini degli individui.
Attraverso una prosa asciutta e lineare, il libro tocca i grandi temi del cambiamento (sociale) e del movimento (spaziale) contro i mali endemici della corruzione, della violenza, delle ingiustizie, per esempio in campo educativo, dove la figura del maestro è triste metafora di oppressione e insensibilità. Ma il libro è anche occasione per riflettere sul potere della scrittura, della narrazione, della memoria in un rapporto dialogico fra autore, lettore e personaggio: “Siamo tutti profughi dalla nostra infanzia. E così ci rivolgiamo, fra le altre cose, al racconto. Scrivere una storia, leggere una storia, significa rifuggire dalla condizione di profughi”. Scrivere del mondo che cambia non vuol dire dimenticare la propria condizione umana, quel misto di sogni e materia che tutti condividiamo, e che il protagonista idealizza nella figura ambivalente della “bella ragazza”, ora inafferrabile ora vicina.
In conclusione, possiamo dire che questi tre volumi, pur con le loro caratteristiche individuali, contribuiscono a galvanizzare il campo delle “altre letterature”, e le nuove definizioni o i tentativi, più o meno felici, di incasellare scrittori e stili che parlano del mondo contemporaneo e delle sue tante diaspore.
esterino.adami@unito.it
E Adami insegna lingua inglese all’Università di Torino