Sezione Il germoglio: Joachim Meyerhoff, Hakan Günday, Emilio Jona e Robert Seethaler
di Chiara D’Ippolito
A volte, per diventare adulti, è necessario un atto di coraggio. Quando il passato ci appare come un luogo insicuro che fa assomigliare la vita che abbiamo davanti a «una linea su cui stare in equilibrio con attenzione» e non a una «vasta superficie» aperta alla possibilità di scegliere e di decidere, è indispensabile riaprire e disfare i «pacchetti di ricordi archiviati» e capire che la nostra storia personale possiede una natura caotica che ha bisogno, prima di tutto, di essere riconosciuta, ma, subito dopo, anche di venire plasmata, abbellita e celebrata: solo così «il futuro manterrà la sua eterna promessa e sarà incerto». Ricostruire una storia familiare complessa e non sufficientemente elaborata tenendo sempre a mente che «inventare significa ricordare» – perché reinterpretare il proprio passato attraverso il gioco dell’invenzione è un modo per appropriarsene, e la finzione è, quindi, il punto di partenza di ogni tipo di racconto, anche autobiografico – è ciò che ha fatto Joachim Meyeroff con il romanzo Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato (Marsilio), vincitore della sesta edizione del Premio Bottari Lattes Grinzane per la sezione “Il Germoglio”, dedicata alle migliori opere italiane e straniere uscite in Italia nell’ultimo anno.
Ed era forse prevedibile che, tra i quattro romanzi selezionati dalla giuria tecnica presieduta dal professor Gian Luigi Beccaria – oltre allo scrittore e attore tedesco, a contendersi i voti delle 15 giurie scolastiche a cui ogni anno è affidata la scelta del vincitore, c’erano Hakan Günday con Ancóra (Marcos y Marcos), Emilio Jona con Il celeste scolaro (Neri Pozza) e Robert Seethaler con Una vita intera (Neri Pozza) – fosse proprio quello di Meyeroff a raccogliere il numero maggiore di preferenze.
 Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato, infatti, è un ottimo impasto tra umorismo, saggezza e commovente dolore. L’insolita vicenda personale dell’autore che, figlio del direttore di un ospedale psichiatrico per bambini e adolescenti del nord della Germania, è cresciuto considerando i malati psichici come parte naturale della propria famiglia e facendo di un luogo di follia un rassicurante universo di normalità dove le urla notturne dei pazienti sono un’indispensabile ninna nanna e l’alto muro di mattoni rossi intorno all’edificio è un baluardo che difende dagli intrusi, possiede, evidentemente, tutti gli elementi per affascinare: una trascinante e spassosa sequenza di aneddoti strampalati che coinvolgono il piccolo Josse, i suoi amici «dementini» e la sua bizzarra famiglia; una scrittura sempre sospesa tra comicità e malinconia, che non può che sedurre; un’intelligentissima leggerezza nel trasmettere una delle lezioni più importanti che il vero mattatore della storia, l’istrionico padre-psichiatra, ha voluto impartire ai suoi figli, ossia quella di diffidare delle apparenze e cercare la bellezza dove non si pensa di trovarla, anche in un viso sfigurato dalla malattia.
Quando tutto tornerà a essere come non è mai stato, infatti, è un ottimo impasto tra umorismo, saggezza e commovente dolore. L’insolita vicenda personale dell’autore che, figlio del direttore di un ospedale psichiatrico per bambini e adolescenti del nord della Germania, è cresciuto considerando i malati psichici come parte naturale della propria famiglia e facendo di un luogo di follia un rassicurante universo di normalità dove le urla notturne dei pazienti sono un’indispensabile ninna nanna e l’alto muro di mattoni rossi intorno all’edificio è un baluardo che difende dagli intrusi, possiede, evidentemente, tutti gli elementi per affascinare: una trascinante e spassosa sequenza di aneddoti strampalati che coinvolgono il piccolo Josse, i suoi amici «dementini» e la sua bizzarra famiglia; una scrittura sempre sospesa tra comicità e malinconia, che non può che sedurre; un’intelligentissima leggerezza nel trasmettere una delle lezioni più importanti che il vero mattatore della storia, l’istrionico padre-psichiatra, ha voluto impartire ai suoi figli, ossia quella di diffidare delle apparenze e cercare la bellezza dove non si pensa di trovarla, anche in un viso sfigurato dalla malattia.
Se il romanzo di Joachim Meyeroff riesce molto bene soprattutto nel descrivere la progressiva scomparsa di un mondo vissuto come sicuro, ma in realtà dolorosamente illusorio, è forse un peccato che a ricevere il premio della Giuria degli studenti non sia stato Hakan Günday, scrittore turco tra i più interessanti della nuova generazione e già conosciuto in Italia per A con Zeta (Marcos y Marcos, 2015). Vincitore in Francia del Prix Médicis 2015, Ancóra non si distingue solo per la sua complessità narrativa. Non colpisce in piena faccia soltanto per il crudo realismo con cui l’umanità-fantasma composta dai profughi che da anni attraversano la Turchia per raggiungere l’Europa viene fatta uscire dall’anonimato a cui è condannata (perché i migranti diventano visibili solo quando muoiono, e vengono filmati e fotografati per le prime pagine dei giornali). Ma sorprende soprattutto per l’efficacia – un’efficacia feroce e spietata ma potentissima – con cui Günday costruisce un racconto sull’irresistibilità del male, svelata, sotto forma di uno sconvolgente monologo-confessione, attraverso gli occhi di un bambino che, a nove anni, diventa un trafficante di esseri umani.
 Centro del romanzo è il terribile apprendistato dell’orrore a cui un passeur sottopone il proprio figlio, costringendolo a diventare il custode della cisterna in cui rinchiude i migranti che aspettano di essere trasportati fino alle rive dell’Egeo e alle barche degli scafisti greci: «una bara sempre calda» per centinaia di illusi, convinti che «se a questo mondo esiste un inferno fatto di fame e di guerra, dev’esserci per forza anche un paradiso», «una cisterna di invecchiamento» da cui si sente arrivare un’unica parola, “daha”, “ancóra”. Ancora acqua, ancora pane, ancora speranza.
Centro del romanzo è il terribile apprendistato dell’orrore a cui un passeur sottopone il proprio figlio, costringendolo a diventare il custode della cisterna in cui rinchiude i migranti che aspettano di essere trasportati fino alle rive dell’Egeo e alle barche degli scafisti greci: «una bara sempre calda» per centinaia di illusi, convinti che «se a questo mondo esiste un inferno fatto di fame e di guerra, dev’esserci per forza anche un paradiso», «una cisterna di invecchiamento» da cui si sente arrivare un’unica parola, “daha”, “ancóra”. Ancora acqua, ancora pane, ancora speranza.
E visto che per abituarsi al male ci vuole solo un po’ di tempo, perché «l’unica cosa insopportabile è che nulla è insopportabile», Gazâ apprende velocemente la lezione della malvagità – l’unica cosa che conta è imparare sopravvivere, e non importa a che prezzo, perché la vita è solo e sempre una questione di “tu o io” – e diventa ancora più crudele del padre. Viene contaminato dalla violenza di cui è vittima e ne diventa un attore accanito. Si trasforma in una «creatura mostruosa» incapace di provare qualsiasi empatia per quelle persone «per metà esseri umani e per metà merda». Fino a renderle oggetto di un vero e proprio esperimento sociologico in cui, attraverso un sistema di telecamere, si diverte a studiare sui suoi prigionieri gli effetti della paura, del potere della sottomissione e dell’implacabile legge del “tutti contro tutti”. Fino al momento in cui il camion che trasporta l’ennesimo carico di «carne» non cade in un precipizio e Gazâ, unico sopravvissuto, riesce a intravedere la possibilità di strapparsi di dosso il ruolo di mostro che la vita gli ha dato. Per poi scoprire che è impossibile sottrarsi al proprio passato se non attraverso un durissimo tragitto di sofferenza e di presa di coscienza: perché per “reincarnarsi” senza morire, serve prima di tutto la consapevolezza.
Ed è proprio il punto di vista scelto da Günday, quello di un bambino e della sua perdita di innocenza, a rappresentare l’ambiziosa sfida del suo romanzo: mostrare quanto sia facile adattarsi anche alla più inconcepibile delle atrocità, anche quando si è, appunto, solo dei bambini.
Se – riprendendo un passaggio della lectio magistralis tenuta da Amos Oz, vincitore della sezione “La Quercia” del Premio – la letteratura ci regala la possibilità di dialogare con noi stessi, dispiace allora che gli studenti non abbiano voluto far vincere un romanzo che, con una straordinaria lucidità di pensiero, sembra scritto apposta per metterci in contatto con la parte più oscura e infernale di noi stessi. Che più vogliamo rimuovere, ma che più dovremmo allenarci a riconoscere. In quell’inesorabile intercambiabilità dei ruoli che, nell’arco di una sola vita, è in grado di trasformarci da vittime in carnefici. Da rifugiati a trafficanti di rifugiati. Da persone che, ingiustamente, provano paura a persone che, ingiustamente, la suscitano.
Rispetto ai romanzi di Meyeroff e Günday, erano sicuramente più difficili da sottoporre ad un pubblico di studenti le altre due opere finaliste. Due romanzi, quelli di Jona e Seethaler, che, però, incarnano nel migliore dei modi la scommessa del Premio Bottari Lattes Grinzane – quella di avvicinare i giovani alla buona letteratura – proprio in virtù della loro evidente qualità.
 È una raffinata opera di ricostruzione di un’esistenza quella che Emilio Jona, avvocato biellese ma soprattutto scrittore, poeta, etnomusicologo – tra i fondatori dei “Cantacronache”, ha pubblicato saggi, canzoni, libretti d’opera, testi teatrali, raccolte di racconti, poesie, romanzi – ha compiuto con il delicato volume Il celeste scolaro. Attraverso un lavoro che, attingendo a lettere, manoscritti, poesie, diari, testimonianze, si rivela come una perfetta mescolanza tra memoria e invenzione, tra «documento e narrazione», Jona riporta alla luce la voce dell’amico e cugino Federico Almansi. Una voce dimenticata, e una storia drammatica, di cui sono rimaste poche tracce: gli scritti acerbi di un aspirante poeta (Federico), i versi di uno dei più grandi poeti italiani (Umberto Saba), il doloroso ricordo – presente, ormai, solo nella memoria dello scrittore – di una vita travolta dalla malattia mentale (la schizofrenia, “male generazionale” della famiglia Almansi).
È una raffinata opera di ricostruzione di un’esistenza quella che Emilio Jona, avvocato biellese ma soprattutto scrittore, poeta, etnomusicologo – tra i fondatori dei “Cantacronache”, ha pubblicato saggi, canzoni, libretti d’opera, testi teatrali, raccolte di racconti, poesie, romanzi – ha compiuto con il delicato volume Il celeste scolaro. Attraverso un lavoro che, attingendo a lettere, manoscritti, poesie, diari, testimonianze, si rivela come una perfetta mescolanza tra memoria e invenzione, tra «documento e narrazione», Jona riporta alla luce la voce dell’amico e cugino Federico Almansi. Una voce dimenticata, e una storia drammatica, di cui sono rimaste poche tracce: gli scritti acerbi di un aspirante poeta (Federico), i versi di uno dei più grandi poeti italiani (Umberto Saba), il doloroso ricordo – presente, ormai, solo nella memoria dello scrittore – di una vita travolta dalla malattia mentale (la schizofrenia, “male generazionale” della famiglia Almansi).
Quella che Il celeste scolaro ripercorre è, dunque, prima di tutto, la storia del rapporto tra Saba, amico degli Almansi, e un adolescente «dagli occhi di cielo» che «lo ascoltava incantato e lo guardava come un dio disceso per lui dal cielo in terra». Un’amicizia che Jona svela al lettore con estremo garbo, lasciando parlare per lo più lettere, racconti e versi (quelli di alcune poesie del Canzoniere e di molti aforismi di Scorciatoie e raccontini), e ritraendola come un appassionato sodalizio non solo sentimentale, ma anche intellettuale e spirituale: «fu una reciproca folgorazione e il volto del poeta amico invase lo spazio prima occupato dal chiaro e onesto volto del padre, da cui Federico vide scendere lacrime amare per quella amicizia che Emanuele percepiva come un odio a sé e distruttiva per il figlio».
Ma Il celeste scolaro è anche, e soprattutto, la malinconica testimonianza della trasformazione di un «ragazzetto selvatico» dalla bellezza misteriosa e apollinea in un fantasma dal viso gonfio e decaduto, i capelli rasati e la luce irrimediabilmente spenta negli occhi. Perché malgrado il tentativo del padre di «cambiare il sangue» sposando una sana e giovane contadina, «la malattia emerge dal suo lavorio sotterraneo e oscuro e invade la mente di Federico». Fino al giorno in cui Emanuele, ossessionato dal pensiero di lasciare il figlio a un destino fatto di ricoveri in manicomio, tenta di ucciderlo, pensando poi di suicidarsi. Ed è proprio nel racconto di questo allucinato gesto di pietà paterna che il romanzo di Jona si rivela nella sua delicata e, insieme, dolorosa intensità. Perché, ripercorrendo gli anni che seguono il processo a Emanuele – dopo una condanna mite, un giudice illuminato gli ridà l’affidamento del figlio che, così, viene sottratto «dal tallone di ferro dell’istituzione psichiatrica» e torna a vivere a Milano – riesce a rispondere a delle difficilissime, e sempre attuali, domande: è possibile pensare di uccidere il proprio figlio per salvarlo da un destino ritenuto peggiore della morte? In cosa consiste la sofferenza legata alla malattia mentale? E, infine, è possibile far convivere le regole della normalità con quelle, più lontane dal mondo dei sani, della follia?
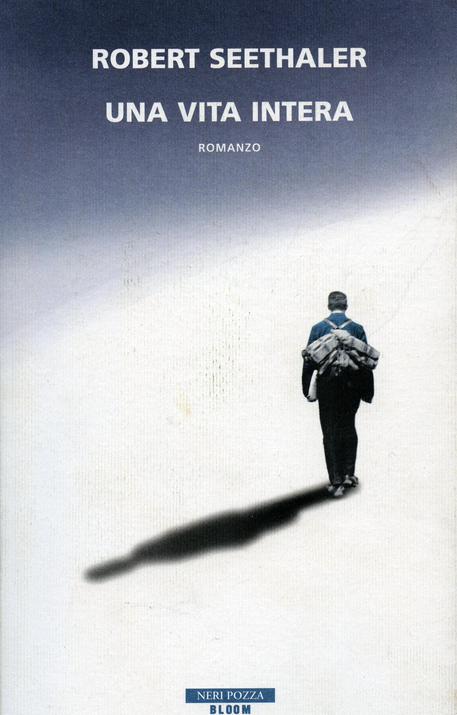 Ed è una vita contrassegnata da una durezza che sembra non concedere requie – ma che, in realtà, lascia spazio alla fiducia nel futuro – anche quella del protagonista del romanzo dell’austriaco Robert Seethaler. Considerato tra i più importanti libri di narrativa in lingua tedesca del 2014, Una vita intera racconta la difficile esistenza di un uomo che, fin dall’infanzia, impara ad affrontare ciò che gli accade con uno sguardo speciale.
Ed è una vita contrassegnata da una durezza che sembra non concedere requie – ma che, in realtà, lascia spazio alla fiducia nel futuro – anche quella del protagonista del romanzo dell’austriaco Robert Seethaler. Considerato tra i più importanti libri di narrativa in lingua tedesca del 2014, Una vita intera racconta la difficile esistenza di un uomo che, fin dall’infanzia, impara ad affrontare ciò che gli accade con uno sguardo speciale.
Quando arriva nel piccolo paese stretto tra le montagne austriache in cui passerà tutta la vita, Andreas Egger si ferma ad osservare stupito le cime splendenti di bianco. E anche se è ancora un bambino, intuisce che il suo destino è quello di accettare di vivere tra la bellezza dei monti e la crudeltà degli uomini senza perdere mai la consapevolezza e la capacità di meravigliarsi. Nonostante la violenza a cui lo sottopone il contadino che lo prende con sé dopo la morte della madre. Nonostante le botte che lo rendono zoppo. Nonostante la fatica del lavoro, appeso ai macchinari che devono costruire la prima funivia della valle. Grazie alla sua naturale propensione a fare di tutto ciò che accade un’opportunità, Andreas, in montagna, è «l’unico che cammina dritto». Diventa un uomo forte, capace di affrontare la vita e prendere decisioni: «era forte, ma lento. Pensava con lentezza, parlava con lentezza, ma ogni pensiero, ogni parola e ogni passo lasciavano un segno, e proprio nel punto in cui secondo lui quel segno doveva essere lasciato». E anche quando l’unica donna che abbia mai amato muore per colpa di una valanga, il suo sguardo rimane innocente, non rassegnato. Dedito allo stupore e alla soddisfazione per ciò che la vita gli riserva. Perché il suo segreto è quello del silenzio. Il silenzio delle montagne, che gli permette di vivere sensazioni di grande meraviglia ma anche di grande paura. Il silenzio di un uomo, che pensa alle parole come ad una complicazione per le relazioni con gli altri esseri umani. Che considera la solitudine l’unica strada per una vita interiore più ricca. Per arrivare ad assaporare la grandiosità e la bellezza della natura che lo circonda e, da sempre, decide della sua sorte.
Scritto con uno stile asciutto e limpido, ma ricco di immagini (esattamente come i pensieri del suo protagonista), Una vita intera è, dunque, un romanzo su una vita difficile. Su una vita che molti potrebbero definire troppo difficile e, forse, anche troppo ordinaria. Ma che ci insegna a capire che, se solo lo vogliamo, «si possono comprare le ore di un uomo, privarlo dei giorni o derubarlo della vita. Ma ci sono attimi che nessuno potrà portargli via».
chiaradippolito@icloud.com
C D’Ippolito è redattrice


